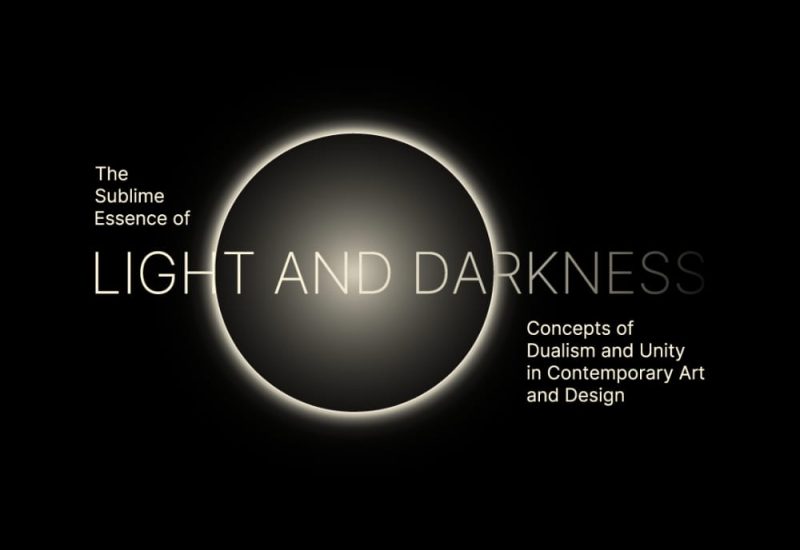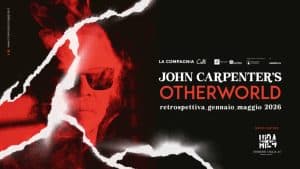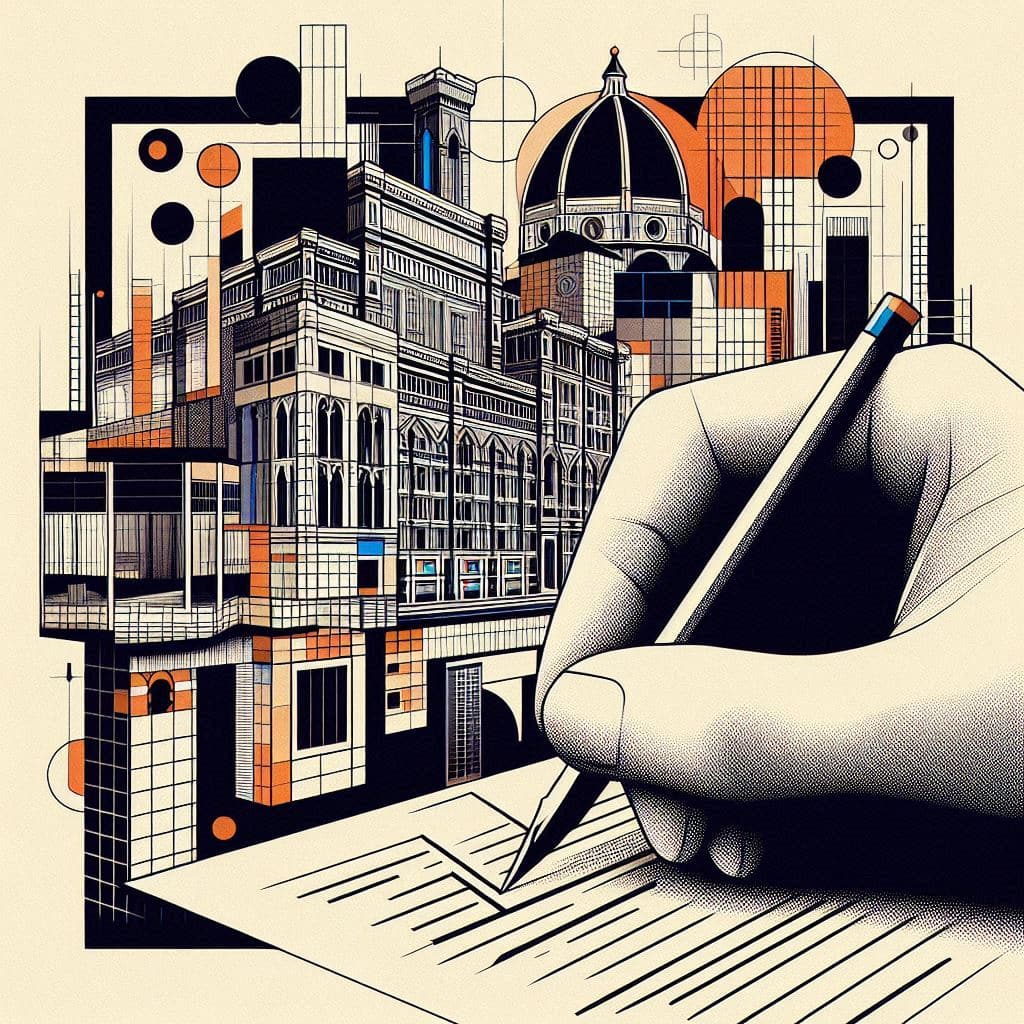Oltre 20.000 visitatori, 550 artisti da 85 Paesi e due ospiti d’eccezione, Tim Burton e Patricia Urquiola: un’edizione di grande successo, ma che lascia aperti interrogativi su qualità, identità e futuro della Biennale
Si è chiusa con successo la XV edizione della Florence Biennale, svoltasi dal 18 al 26 ottobre 2025 presso la Fortezza da Basso di Firenze. La rassegna ha registrato oltre 20.000 presenze complessive nei suoi otto giorni di apertura, con la partecipazione di più di 550 artisti e designer provenienti da oltre 85 Paesi e cinque continenti, confermandosi una delle piattaforme artistiche più importanti a livello internazionale.
Tra i momenti più significativi, la presenza straordinaria di Tim Burton, regista, illustratore e visionario artista statunitense, e Patricia Urquiola, designer e architetta di fama mondiale. Entrambi hanno ricevuto in presenza il Premio “Lorenzo il Magnifico” alla Carriera rispettivamente per le categorie Arte e Design e sono stati protagonisti di due mostre personali inedite, che hanno attirato migliaia di visitatori, divenendo l’epicentro dell’intera manifestazione.
La Florence Biennale 2025 ha confermato il suo grande potenziale come luogo di incontro e di scambio culturale. Tuttavia, accanto ai meriti, emergono riflessioni e critiche costruttive. L’evento sembra oggi oscillare tra la dimensione di fiera internazionale e quella di biennale d’arte, una doppia natura che, se da un lato amplia la partecipazione e la visibilità degli artisti, dall’altro rischia di rendere meno definita la propria identità culturale e curatoriale.
Molti partecipanti hanno segnalato come gli spazi espositivi, in diversi casi, risultino limitati e uniformati, non sempre adeguati a valorizzare la complessità delle opere presentate. Il formato più accessibile economicamente prevede infatti uno spazio ridotto, adatto a una sola opera, mentre chi desidera presentare un progetto più ampio deve affrontare costi significativamente più elevati. A questo si aggiungono le spese legate alla spedizione delle opere, al vitto, all’alloggio e alla permanenza in città, che vanno a incidere in modo considerevole sulla partecipazione degli artisti, rendendo difficile, per molti, sostenere i costi complessivi dell’esperienza.
In questo senso, sarebbe auspicabile una riforma della struttura espositiva che valorizzi maggiormente le differenze tra artisti emergenti e affermati, e che, sfruttando appieno le potenzialità architettoniche della Fortezza da Basso, possa svilupparsi attraverso più padiglioni tematici, offrendo spazi coerenti con le diverse poetiche e forme artistiche.
Un’altra riflessione riguarda il rapporto tra qualità e quantità: l’altissimo numero di visitatori – in gran parte giovani – è stato determinato soprattutto dalla presenza straordinaria di Tim Burton e dalla sua mostra personale, divenuta un magnete mediatico. Un successo indiscutibile, ma che solleva la questione di quanto la notorietà dei singoli ospiti influenzi il pubblico, più che la conoscenza o la curiosità verso la Biennale stessa.
Anche il momento della premiazione di Tim Burton ha suscitato opinioni contrastanti. Il regista ha infatti tenuto un breve discorso di circa due minuti, senza concedere spazio ai giornalisti per eventuali domande, né al pubblico per un momento di interazione. Una presenza percepita da molti come troppo fugace, che avrebbe potuto trasformarsi in un’occasione molto più ricca e significativa. Sarebbe stato, infatti, auspicabile organizzare un momento più concreto e partecipativo, in cui il pubblico, gli appassionati e la stampa potessero dialogare direttamente con Burton, magari attraverso un breve incontro, una sessione di autografi, fotografie o domande dal pubblico. Un’occasione di confronto che, oltre a rendere omaggio all’artista, avrebbe potuto generare un momento culturale di grande valore per la città e per i visitatori della Biennale.
Intervista al maestro Chao Ge: l’arte come equilibrio e disciplina

Tra gli incontri più significativi della Biennale, ho avuto l’onore di conversare con Chao Ge, artista cinese di fama internazionale, nato nel 1957 a Huhehot, nella Mongolia Interna. Pittore di rara sensibilità, noto per le sue grandi tele dove la figura umana si fonde con la natura, in una ricerca di armonia spirituale tra l’uomo e il mondo. Laureato all’Accademia Centrale di Belle Arti di Pechino, ha esposto in numerosi musei e biennali internazionali, e le sue opere fanno parte di importanti collezioni in Cina, Europa e Stati Uniti. La sua pittura, intensa e silenziosa, è una riflessione continua sul tempo, sulla memoria e sul legame tra corpo e spirito. L’intervista si è svolta con l’aiuto di un’interprete.
Domanda 1 – Le sue opere sembrano cercare una dimensione interiore e spirituale. Come nasce per lei un’immagine? È più un atto di pensiero o di intuizione?
«Quando scorgo una figura o un volto che mi attira, non la registro subito come “soggetto da dipingere”. Attendo. Osservo il ritmo del gesto, l’ombra che traccia il corpo, il silenzio che lo circonda. È un momento sospeso, di ascolto: il pensiero cede il passo all’intuizione. Quindi inizio un dialogo invisibile con quel modello, o con il paesaggio interiore che riconosco in me mosso non da un’idea preformata, ma da una sensazione che pulsa. In quel dialogo accade qualcosa: l’immagine che nascerà non è il ritratto di ciò che vedo, ma la fusione fra il visibile e l’invisibile. Poi, in studio, con la tela e il colore e talvolta con la natura come seconda presenza rendo manifesto ciò che è accaduto nell’interiorità. Il volto, la postura, il paesaggio non sono più solo “ciò che vedo”, ma “ciò che sento”. Perciò ogni opera comincia con l’intuizione e matura con il pensiero: l’intuizione apre la porta, il pensiero ne scandisce il passo. Solo così l’immagine può diventare autentica, capace di toccare lo spettatore al di là della mera forma.»

Domanda 2 – Lei ha vissuto e lavorato tra Oriente e Occidente. In che modo questo dialogo culturale ha trasformato il suo modo di vedere e di dipingere?
«Una delle differenze più profonde tra Oriente e Occidente è il rapporto con la natura e la spiritualità. Quando pongo le mie figure al centro di spazi verdi, in mezzo alla natura, voglio trasmettere un senso di coesione e di unione spirituale: che le persone, gli animali e la natura vivano tutt’uno, con rispetto reciproco, senza distinzioni di superiorità o gerarchie. Noi orientali cerchiamo di mantenere questo equilibrio, mentre nel mondo occidentale vedo una separazione: l’uomo è uomo, l’animale è animale, la cosa è cosa. Manca una coesione spirituale e un senso di unione profonda. Io cerco di rappresentare, attraverso la pittura, quella coesione universale che per me è fondamentale.»
Domanda 3 – Qual è, secondo lei, il primo passo che un giovane artista deve compiere per trovare la propria voce autentica?
«La più grande rivoluzione artistica della storia è stata quella del Novecento, la distruzione del sistema. Prima del Novecento, nel Settecento, Ottocento e nei secoli precedenti, esisteva un sistema preciso fatto di regole, tecnica e forma. Con il Novecento questo sistema si rompe, ma per poterlo superare bisogna prima conoscerlo. Un artista deve studiare l’arte del passato, perché solo su quella base può costruire la propria forza personale e aggiungere la propria voce autentica. Chi non studia nulla e vuole subito creare grandi opere, facendo solo ciò che gli piace, non va lontano. Il problema non è guardare al passato, ma la mancanza di cultura generale dei giovani, il poco impegno, la scarsa dedizione e la tendenza a voler saltare le fasi di studio tecnico e storico. Oggi nelle accademie c’è troppa libertà e poca disciplina: molti vogliono essere artisti concettuali o astratti senza conoscere le fondamenta. Ma senza radici non può esserci crescita, e senza studio non può esserci libertà vera.»
Dopo averlo incontrato e ascoltato parlare, ho percepito in Chao Ge un’umanità rara, di quelle che si rispecchiano nei gesti lenti e nelle parole meditate. La sua presenza non è quella dell’artista che impone, ma di chi vive l’arte come disciplina interiore, come esercizio di equilibrio e di silenzio. Mi ha colpito il modo in cui, mentre parlava di spiritualità e rispetto per la natura, il suo sguardo sembrava cercare un punto preciso nell’aria come se anche la parola, per lui, dovesse trovare il suo spazio giusto, la sua armonia.
Nel suo pensiero si riflette una saggezza antica, asciutta e concreta, capace di dialogare con la nostra epoca senza perdere profondità. La sua visione sull’arte contemporanea – tra dedizione, studio e umiltà – dovrebbe far riflettere molti giovani artisti occidentali, spesso più attenti alla visibilità che alla costruzione interiore. Chao Ge ricorda, con la serenità di chi non ha bisogno di dimostrare nulla, che l’arte non è spettacolo, ma una forma di equilibrio tra spirito e materia, un cammino lento, necessario, dove ogni gesto e ogni colore diventano parte di un’unica meditazione.

Conclusione
La Florence Biennale 2025 si conferma un evento di straordinario respiro internazionale, capace di portare a Firenze migliaia di persone e di aprire nuovi dialoghi tra culture e generazioni. Ma il suo futuro dipenderà dalla capacità di trasformare il successo di pubblico in una crescita qualitativa, rafforzando la propria identità e coinvolgendo più attivamente artisti, critici e spettatori. Le parole del maestro Chao Ge, tra spiritualità e disciplina, ricordano che l’arte non è solo esposizione, ma ricerca, ascolto e costruzione interiore. Forse è proprio da qui che la Biennale potrà ripartire per diventare un vero laboratorio del pensiero contemporaneo.