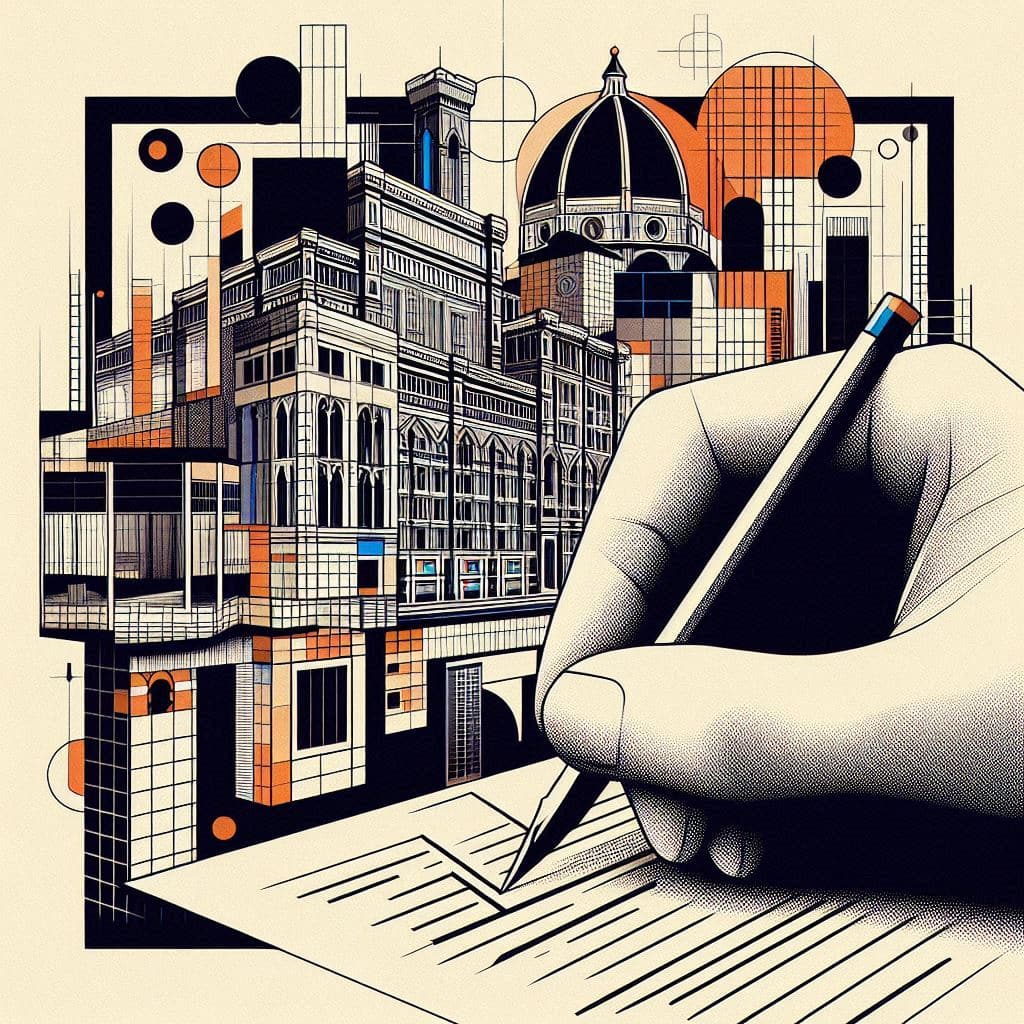La Firenze che vorrei è il nome che abbiamo scelto per questo giornale. Vuole essere un invito a fermarci un attimo, a prenderci un respiro e a guardare questa nostra vecchia città con occhi nuovi.
È un invito a recuperare il contatto con quella Firenze che da qualche parte ci è rimasta in fondo all’anima. Alcuni per farlo dovranno forse tornare indietro nel tempo, magari a quei luoghi della memoria che hanno fatto la nostra Firenze di bambini o di ragazzi. Per me erano i baci dati sui motorini fuori dal Liceo Galileo in mezzo al gasolio degli autobus e i doposcuola da American Transfers in Via Nazionale. Prima ancora erano i trenini di Dreoni, le ginocchia sbucciate alle Cascine, o le lanterne della Rificolona e il profumo dello stucco dei proiettili della cerbottana. Quei luoghi e quelle immagini sono il patrimonio comune di tanti di noi che siamo nati negli anni ’70 e ’80. Ma ognuno ha il suo di patrimonio, ognuno di noi si è costruito una sua mappa emotiva della città.
Poi certo, la vita cambia, si cresce, il traffico e lo stress della città ci imbruttiscono. Piano piano quella mappa emotiva si sbiadisce, i luoghi perdono di significato. E non siamo solo noi a cambiare; i luoghi stessi cambiano, si imbruttiscono pure loro, e troppo spesso sentiamo che non ci appartengono più. Le serate in piazza no, c’è la ZTL e non si entra, hai visto quanta gentaglia, e poi 40 minuti per parcheggiare anche no, all’angolo un’altra vecchia bottega chiude i battenti, e ieri non ti trovo un nuovo cantiere che non si può passare, e poi ancora una spaccata alla panetteria, e il centro è una trappola per turisti, e via dicendo.
Ed ecco che arriva in salvo la politica che ci bombarda con una poggia di soluzioni molto in voga, la città green, smart, plurale, e compagnia cantante. Ma gli anni passano, e questa politica – sempre la stessa, tra l’altro – ci restituisce una città sempre più cementificata, sempre meno intelligente, sempre meno inclusiva. Invece di offrire soluzioni al servizio del cittadino, ci impone scelte sempre più ideologiche, e sempre più lontane dalle nostre necessità reali. Allora ci ritiriamo in noi stessi, alziamo le mani e ci abituiamo a muoverci in questo organismo incomprensibile, ma senza più esserne parte attiva e viva. Piano piano la città non la viviamo, ma la subiamo. Poi capita che a volte torniamo in certi luoghi della città, e ci chiediamo cosa ne è di quella magia che un tempo ci fece innamorare di Firenze. Beh, la verità è che Firenze è cambiata, spesso in peggio, e noi siamo stati a guardare.
E anche noi ci siamo imbruttiti parecchio: usciamo poco, ci divertiamo poco, partecipiamo poco, viviamo poco. Ma se siamo stanchi di stare a guardare, e di subire questa città invece di vivercela, allora dobbiamo tornare a sporcarci le mani. Lasciamo da parte i nostri schemi di pensiero abituali. Proviamo a guardare alla città con occhi nuovi: non quelli dell’elettore che fatica a masticare un’agenda di governo sempre più distante dai suoi bisogni, né quelli del turista che in 48 ore si consuma una città formattata dei grandi brand transnazionali dell’immobiliare e del turismo. E neanche con gli occhi bassi del rassegnato che tira dritto verso casa, per scansare le brutture e il degrado che lo circondano.
Dobbiamo tornare a vivercela questa Firenze, ricominciando da ciò che è rimasto di bello e vivo (e c’è ancora tanto), metterci in gioco, e lasciare qui i segni della nostra umanità e della nostra creatività.
E per fare questo abbiamo bisogno prima di tutto di tornare a raccontarla, a dibatterla, a parteciparla, a litigarcela, a immaginarcela, questa Firenze.
La Firenze che vorrei è un luogo in cui vogliamo che convergano visioni, idee e voci provenienti da tutti gli angoli della città. La nostra ambizione è quella di mettere in rete le voci alternative, di dare visibilità a quelle realtà cittadine che oggi sono troppo spesso marginalizzate o ignorate dal dibattito pubblico. Dai gridi d’allarme di San Jacopino alle petizioni popolari di Ribella Firenze, dalle manifestazioni di Aria Nuova per Firenze ai tanti comitati cittadini, dal lavoro dei consiglieri di quartiere, che spesso sono i primi a segnalare i problemi che non arrivano nelle grandi discussioni politiche, ai comunicati delle opposizioni che, nonostante l’isolamento, portano avanti proposte che meriterebbero di essere ascoltate.
La Firenze che vorrei vuole essere un crocevia di proposte che rappresentano il desiderio di un cambiamento autentico di chi non fa parte della macchina clientelare che ha cristallizzato la politica cittadina per troppi decenni. Di chi non ha interessi a mantenere lo status quo e non è tra i rassegnati della continuità a tutti i costi, ma vuole che qualcosa cambi davvero e in meglio. Vogliamo costruire una rete di cittadini e di idee che possa, finalmente, competere con la macchina amministrativa cittadina, e fare un lobbying costruttivo per spingere l’amministrazione a riconsiderare quelle scelte politiche, ambientali, sociali e urbanistiche che hanno dimostrato di non funzionare.
Sempre consapevoli che la politica deve essere lì per servire i cittadini, e non viceversa.
La Firenze che vorrei vuole raccogliere le voci di chi la città non la subisce, delle tante energie trasversali che da anni lavorano per immaginare proposte alternative. Vogliamo che questo giornale diventi un collettivo di appassionati visionari e innovatori, una piattaforma aperta a chi non ha paura di pensare in modo diverso. Vogliamo coltivare idee progettuali nuove, proposte di rigenerazione visionarie, soluzioni mai pensate per risolvere gli annosi problemi dell’esistenza urbana, unendo le migliori energie per formulare soluzioni pratiche e realizzabili per le sfide che Firenze si trova ad affrontare. Se guardiamo a città più avanzate della nostra, dalle metropoli europee alle piccole realtà italiane, troveremo esempi di buona amministrazione e pratiche virtuose da imitare in settori come la cura del verde, il riuso degli edifici abbandonati, la rigenerazione di aree dismesse e il recupero di strade e piazze. Dalle “case di quartiere” di Torino ai bonus per giovani creativi per affittare spazi a Lipsia, dalle spiagge temporanee installate sulle rive della Senna a Parigi, ai dormitori popolari trasformati in città-giardino a Londra, non possiamo fare a meno di interrogarci: perché non possiamo farlo anche noi? Ricordiamoci che da anni Firenze è tra le prime città italiane per entrate fiscali pro capite, e si piazza al secondo posto, subito dopo Roma, per incassi derivanti dalla tassa di soggiorno. Non viviamo in una città povera di mezzi.
Facciamo ribollire le idee. Firenze è una città che da troppi decenni vive di passato, ma il feticcio del passato non salverà Firenze dal suo presente. Proviamo a guardarla con gli occhi visionari dei bambini. O degli artisti. Guardiamola con gli occhi delle comunità e dei rioni: come possiamo noi, comunità di cittadini, partecipare alla riconquista degli spazi che ci appartengono? La progettazione della città deve essere un atto collettivo, in alternativa i progetti falliscono. Per troppo tempo una grande fetta della cittadinanza che non si riconosce nel potere istituzionale è stata tenuta fuori dai giochi.
Dobbiamo tornare, noi cittadini, a immaginare come vorremmo i nostri quartieri e le nostre strade.
L’invito, in fondo, è a recuperare il contatto con una città che ha avuto tanti momenti gloriosi, che sembrano ormai sepolti in un archivio polveroso della storia, ricoperti da decenni di troppa politica e poca visione. È tempo di lasciare da parte il cinismo del «vaia vaia», di chi crede che non si possa mai fare nulla. Firenze lo merita. Il decoro, la sicurezza, la buona convivenza sociale, il senso di orgoglio di vivere in questo grande capolavoro urbano non sono cose che ci verranno calate dall’alto. Dobbiamo riconquistarle. Vogliamo ridare voce a chi ha idee e le vuole proporre, e insieme avere il coraggio di guardare oltre.