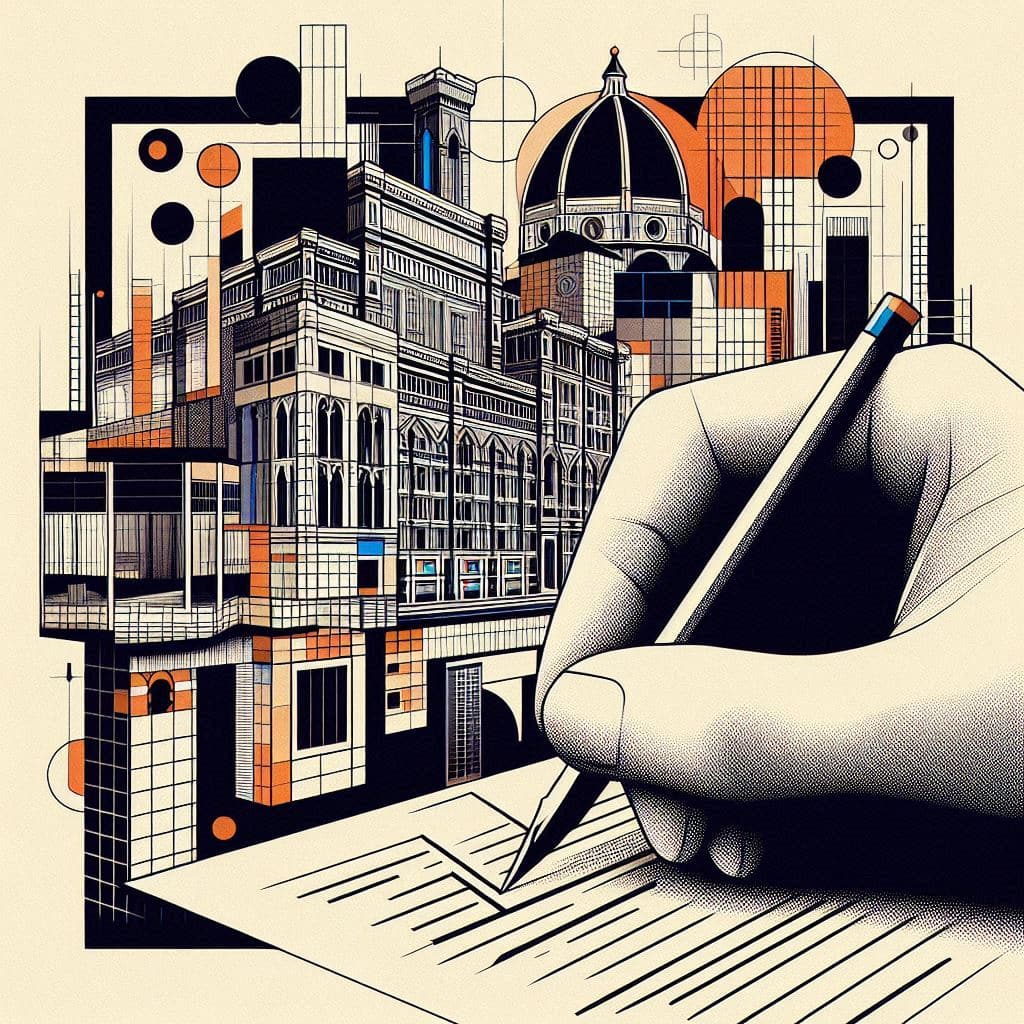La città ha perso le sue aziende, le sue agenzie, il suo forziere. Bisogna uscire dalla mentalità della “rendita”. La disamina del consigliere Sabatini.
Energico consigliere della Lista civica Eike Schmidt, Massimo Sabatini, è anche un lettore già affezionato de La Firenze che vorrei. Dalla tramvia – tra un guasto e l’altro – alla sicurezza, dai lavori al Franchi rigorosamente senza cronoprogramma allo Scudo “Marrone”, Sabatini è sempre attivo e presente nel dibattito. Ci ha trasmesso questo intervento, che pubblichiamo integralmente.
Ormai da decenni la nostra città ha perso il suo ruolo di rilievo che, oltre a turistico ed artistico, era di prim’ordine anche sul fronte economico ed industriale. Da cosa dipende tutto ciò? Dalle visioni dominanti di chi l’amministra da troppo tempo senza alternanza alcuna. Lo sviluppo economico, infatti, non deve essere visto come mero arricchimento di chi ne é protagonista. Eliminare questa visione riduttiva in logica di colpa è il punto di partenza della crescita.
Senza sviluppo economico non avremmo avuto il Rinascimento né la città che i Medici ci hanno lasciato e di cui godiamo ancora oggi a più di 500 anni di distanza. Lo sviluppo economico e industriale non implica necessariamente il degrado del patrimonio culturale e artistico, anzi il contrario: ne discende la sua ulteriore valorizzazione. E il divario cultura/industria dovrebbe essere sempre colmato proprio dalla politica.
Firenze era una città industriale, una delle più importanti d’Italia dopo il famoso triangolo MI-TO-GE. Ma chi l’ha guidata sembra che non lo sapesse proprio. Si pensi anche agli impatti sul sistema scolastico: dove vanno oggi i ragazzi che escono dall’ITI? E dove è andata a finire l’ITI? Che ne resta di quella formidabile scuola di professionismo e specializzazione? Era al top rispetto a tutta Italia, oggi è messa da una parte anche qui.
Ecco, la difesa dell’esistente, è proprio un punto debole. Perché se non lo si difende, lo sviluppo economico evapora. Il caso dell’azienda Seves dal 2009 ad oggi è uno dei più emblematici. Trattavasi di una meravigliosa sintesi – il vetro cemento – tra ciò che è fantasia artigianale e capacità industriale. Possibile solo l’idea di vederla sparire? Invece l’hanno fatto avvenire, senza mai una politica locale attiva nella soluzione. Per fortuna oggi c’è Leofrance che farà rinascere quell’importante complesso industriale, seppur in altro settore.
Assistere a queste perdite è ancor più grave se la cosa avviene per mere intenzioni speculative, quelle che portano a mettere costruzioni laddove prima vi erano attività.
Vogliamo parlare anche dell’ex-area FIAT a Novoli? Dove è stata fatta scappare anche la svedese GKN? O ancora, nessuno ricorda il vecchio nome della Sime Telefonia, la cui zona in Via Toscanini è stata ri-edificata? In termini di valore globale è stato certo clamoroso il caso di Europa Metalli. Laddove avevamo un’azienda che, nata qui, era riuscita a dominare il 30% dell’intero mercato mondiale del rame (una ricchezza spaventosa), oggi abbiamo un hotel. Bello sicuramente, ma non con le stesse centinaia di posti di lavoro.
E la Manetti & Roberts? Il largo consumo, uno degli Eldorado formativi dei neolaureati, non era forse il caso di tenerselo stretto? No, via. A Milano! Né si sono notate azioni fattive per le situazioni di Findomestic e Centroleasing. E che dire dell’editoria come Le Monnier e Nuova Italia, lasciate andare (sempre Milano) al cospetto di Mondadori e Rizzoli?
Restando nel mondo dei servizi pure Arval, oltre 500 posti di lavoro a Scandicci, ha rischiato di fuggire verso il Trentino per tematiche di tasse locali. Un suicidio sfiorato riguarda le Officine Galileo. Di un simile valore, si stava addirittura perdendo il nome. Salvato reintroducendolo a Campi Bisenzio (dunque non più Comune di Firenze) tutta l’avionica di Alenia. Altro nome dell’immobilismo locale è stato Targetti.
Insomma, nessuno sembra aver agito per arginare questa infinita diaspora!
Non dimentichiamoci poi, che un buon sviluppo economico richiede circolazione delle idee e predisposizione al rischio. Pensiamo anche ai servizi: essi si sviluppano dove c’è impresa, altrimenti sono solo servizi “di base”, senza valore aggiunto e, quindi, senza generare risorse economiche da investire a favore della comunità. L’impresa familiare, seppur importante, non crea larga diffusione e ridistribuzione di ricchezza. Per questo servirebbe la grande azienda, ma le grandi aziende abbandonano Firenze. Perché?
Anche all’arrivo di figure importanti come Commisso oggi si creano ostacoli e non aperture. Perché? Nessuno ha pensato a parlare da vicino con questo imprenditore anche della sua importante azienda di servizi di telecomunicazioni? Una realtà come Mediacom non aiuterebbe Firenze e la Toscana? Nessuno ci arriva?
Negli anni ’70 la Leader, agenzia pubblicitaria di Firenze, creò slogan mitici come “chi ama brucia” (per i biscotti Pavesini) o “chi Vespa mangia le Mele” (per gli scooter più belli del mondo). Oggi la Piaggio, azienda toscana, usa agenzie di Milano a più di 300 km di distanza, perché?
La Fondiaria era originariamente fiorentina, oggi la sede di Firenze è ormai “andata”, perché? Il tema della capacità negoziale torna come cruciale. Con l’ex presidente Pecci surclassato da Ligresti, quella non era più la cassaforte della borghesia fiorentina.
Altro spunto dimenticato è quello dell’ex dinamitificio Nobel. All’epoca aurea di Cecchi Gori si parlava di sviluppi del settore cinematografico. Tutto lasciato sfumare, negli stessi anni in cui Veltroni ha edificato il festival romano, perché? Nel tempo è stata persa la competitività negoziale.
Che dire oggi della Cassa di Risparmio di Firenze presa da Intesa San Paolo e il cui marchio (uno dei più nobili, riconoscibili e fiorentinissimi) è stato fatto andare in evanescenza? Altre città hanno difeso meglio il loro forziere. Firenze nient’affatto.
Una città, seppur patrimonio artistico mondiale, non può vivere di solo turismo “di giornata”. Il turismo deve essere al contrario occasione per scambio di idee, confronto, di visioni imprenditoriali, ma deve integrarsi con una città viva, attiva, operosa e non indurre ad un atteggiamento passivo di riscossione di “mance”.
Fino a poco prima dell’emergenza Covid, la tassa di soggiorno (oltre 70 milioni di euro) a Firenze non veniva re-investita sul settore e quel che è successo dopo è sotto gli occhi di tutti. Disastro totale, nessun aiuto comunale al settore, morìa continua di aziende e di posti di lavoro.
E non dimentichiamoci di citare gli artigiani o i commercianti. Tutti i livelli amministrativi (da quelli centrali, fino ai sindaci, alle giunte, fino alle stessi figure dirigenziali dei vigili) hanno fuso e confuso la figura dei maestri artigiani o della bottega con quella dei Padroni/datori di lavoro/industriali, pretendendo anche dai titolari di piccole ditte gli stessi oneri amministrativi e burocratici delle grande industrie. Solo pensando alle scadenze, un colpo ferale.
Infine l’innovazione, il rispetto della tradizione non implica “conservatorismo”. Lo sviluppo economico non può prescindere dall’innovazione: se oggi digitiamo “Firenze” su Google, escono solo articoli sull’Arte e sulla sua Storia. Poco che riguardi oggi o tantomeno il futuro.
Una città può essere moderna, funzionale, dinamica e parimenti conservare tutte le sue bellezze e la sua personalità. Il conservatorismo favorisce la “rendita”, proprio ciò che questa città dice a parole di contrastare mentre invece sembra attuare una politica proprio contro gli interessi dei suoi stessi imprenditori cittadini. Che é la scomoda eredità di una gestione amministrativa che ha scoraggiato piuttosto che incentivare e stimolare l’innovazione.