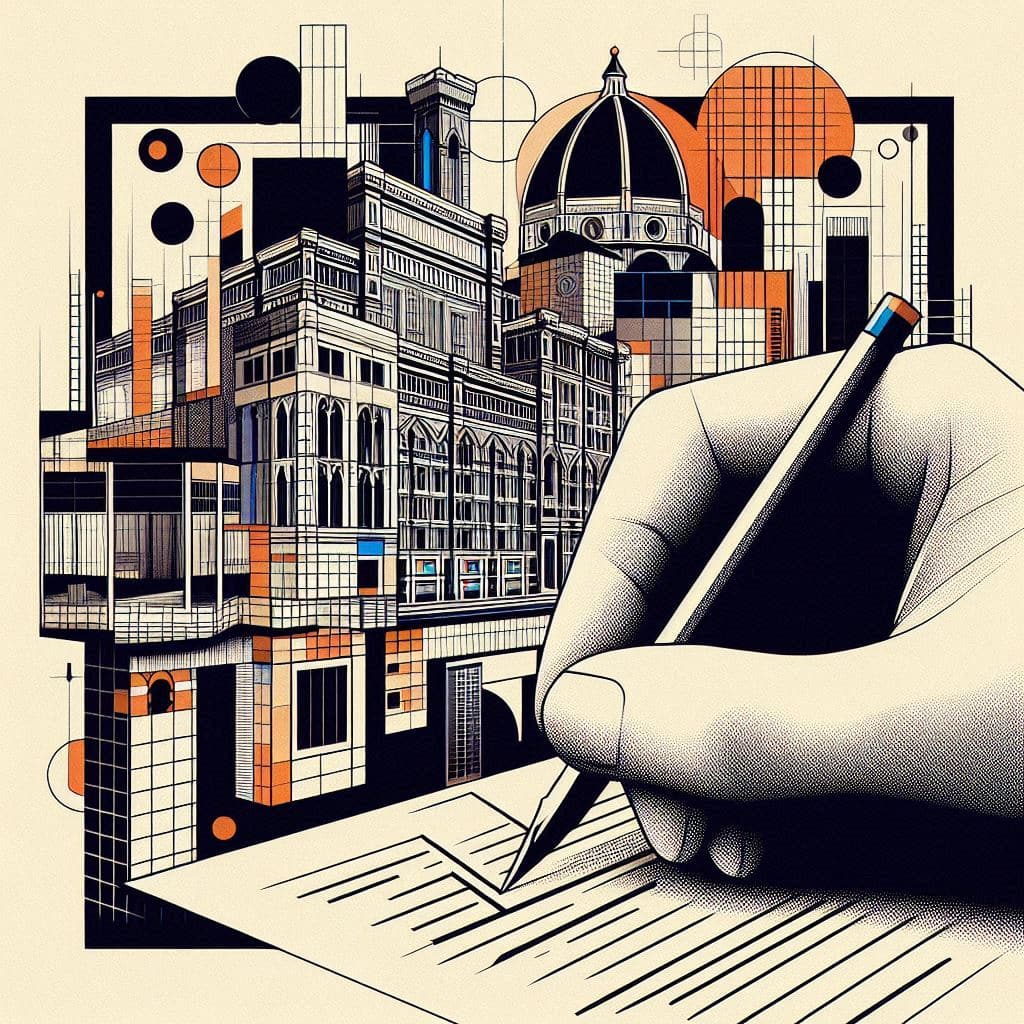A cura del Prof. Alessio Fontani
Le ragioni di questo approfondimento
È apparso di recente sullla rivista on-line La Firenze che vorrei un interessante articolo dell’Avvocato Michele Sanfilippo dal titolo Città ed obiettivi: l’efficacia costituzionale. L’autore è un noto specialista di Diritto Costituzionale, Diritto Pubblico dell’Economia e Diritto Sanitario, oltre ad essere portatore di stimate ed autorevoli esperienze in ambito politico e di gestione nelle amministrazioni locali.
Il testo pubblicato contiene una tesi ampiamente condivisibile dal punto di vista giuridico, e appropriata sul piano sociologico: in sostanza, Sanfilippo sostiene che l’azione pubblica ha un senso soltanto se è pienamente efficace nel realizzare gli obiettivi sui quali si è impegnata in base al mandato elettorale. Tali obiettivi devono essere in ogni caso pienamente coerenti con quanto previsto nella carta costituzionale, per cui non sarà mai possibile invocare l’efficienza nella gestione della cosa pubblica laddove essa sacrifichi i diritti fondamentali dei cittadini rappresentati realizzando obiettivi estranei a tali diritti o solo parzialmente risolutivi di obblighi connessi con la fornitura di servizi essenziali.
Completa l’analisi di Sanfilippo la proposta di servizi di Advisory Sociale delegati ad Autorità indipendenti che, sulla base di indicatori quali/quantitativi basati su un noto lavoro di studiosi quali Fitoussi, Stiglitz e Sen, possano nel tempo continuo valutare la coerenza fra gli obiettivi realizzati e gli obblighi costituzionali che l’azione pubblica deve garantire.
Ora, tale analisi è pienamente rispondente alle logiche giuridiche e costituzionali tipiche della specializzazione del giurista e dell’esperienza del politologo, ma a mio avviso mostra alcune criticità e carenze sotto il profilo degli aspetti economici del diritto e, più in generale, rischia di alimentare illusioni e distorsioni ideologiche sulla base di una semplice analisi di categorie interpretative che sono naturali argomenti dell’analisi economica.
Produzione economica e benessere collettivo: una riflessione critica sul ruolo della crescita nella misurazione delle politiche pubbliche
Nell’articolo di Sanfilippo si fa ampio riferimento ad uno studio del 2008, pubblicato nell’ambito dei lavori della Commissione voluta dall’ex Presidente della Repubblica di Francia N. Sarkozy, composta dagli studiosi Fitoussi, Stiglitz e Sen (Commissione poi confluita nell’OCSE). Lo studio in generale sostiene che gli indicatori sintetici della crescita economica – il riferimento è al Prodotto Interno Lordo – sono né sufficienti né adeguati a rappresentare l’effettivo stato di benessere della popolazione, e andrebbero quindi integrati con altri indicatori quali/quantitativi più adatti ad evidenziare ad esempio il degrado ambientale, le disponibilità abitative, le disuguaglianze di reddito, l’accesso ai servizi e alla formazione superiore ecc. Sono altre 250 gli indicatori che lo studio sottopone all’attenzione degli osservatori e dei decisori politici e istituzionali.
Nell’articolo di Sanfilippo si riporta in particolare una frase di Fitoussi che ha questo tenore: “Misurare meglio significa governare meglio. Se misuriamo solo la produzione economica, perdiamo di vista ciò che conta davvero: il benessere delle persone”.
A me pare che questa affermazione contenga in nuce una contraddizione ed una sottovalutazione, e possa prestarsi a significative distorsioni ideologiche, in grado di generare – queste sì – rilevanti errori nel processo di decisione politica, laddove soprattutto questa debba occuparsi di allocare correttamente le limitate risorse a disposizione delle pubbliche amministrazioni.
Nel corso degli ultimi decenni, il dibattito sulla misurazione del progresso economico e sociale si è intensificato, portando all’emergere di posizioni critiche nei confronti dell’utilizzo esclusivo del Prodotto Interno Lordo (PIL) come indicatore di riferimento per le politiche pubbliche. In tale contesto la Commissione Stiglitz-Sen-Fitoussi (2008) ha rappresentato senz’altro un momento di svolta, ponendo l’accento sulla necessità di ampliare lo spettro degli indicatori della crescita.
Pur condividendo l’intento di ampliare la prospettiva analitica delle politiche economiche, questa affermazione solleva interrogativi legittimi circa la relazione tra crescita produttiva e benessere collettivo. In particolare, si rischia di alimentare un fraintendimento teorico e operativo, laddove si suggerisca implicitamente che l’incremento della produzione economica possa, o debba, essere subordinato a criteri alternativi di benessere.
Tale posizione trascura un elemento fondamentale: la finalità propria dell’economia – sia nella sua dimensione teorica che in quella operativa – è l’organizzazione efficiente delle risorse in vista del soddisfacimento dei bisogni collettivi. Ne consegue che la crescita economica costituisce una condizione necessaria, sebbene non sufficiente, per l’aumento del benessere collettivo. In presenza di dinamiche demografiche espansive e di un generale innalzamento degli standard di vita, la pressione sulla domanda aggregata (misurata dal PIL) tende ad aumentare in modo strutturale. In assenza di una corrispondente crescita dell’offerta di beni e servizi, si generano squilibri macroeconomici rilevanti, quali inflazione da domanda in eccesso e scarsità relativa da un lato; aumento della pressione fiscale e contrazione degli investimenti produttivi dell’altro, proprio al fine di contrastare l’aumento dell’inflazione ma al costo di esasperare la scarsità relativa.
Tutti fenomeni questi che contribuiscono a un deterioramento effettivo del benessere materiale, ben al di là di quanto possa essere rilevato da indicatori soggettivi o multidimensionali. Questo non implica una negazione del valore informativo degli indicatori integrativi e/o alternativi al PIL. Al contrario, essi possono svolgere un ruolo utile come elementi complementari dell’analisi economica, offrendo una rappresentazione più articolata dei fenomeni sociali. Tuttavia, è necessario ribadire che nessuna metrica, per quanto evoluta e consistente dal punto di vista statistico, può sostituire la funzione generativa e redistributiva della produzione economica. Gli indicatori infatti, svolgono una mera funzione descrittiva e orientativa, ma non costituiscono strumenti risolutivi dei problemi economici reali.
Per concludere questa parte, la contrapposizione fra crescita economica e benessere risulta teoricamente infondata e operativamente fuorviante. Il compito delle politiche pubbliche non è quello di scegliere tra produzione e qualità della vita, bensì di integrare la crescita economica all’interno di un progetto coerente di sviluppo sostenibile e inclusivo. Solo in tal modo sarà possibile conciliare l’espansione della base produttiva con la promozione di condizioni di vita eque, dignitose e durature per l’intera collettività.
Il concetto di efficienza: l’evidenza teorica in economia e le divergenze con l’orientamento normo-guidato dell’azione pubblica
Questo tema costituisce il cuore dell’editoriale di Sanfilippo, ed in sostanza lo si può sintetizzare così: la bontà (l’aderenza ai principi costituzionali) dell’azione pubblica la si commisura sull’efficacia, ovvero sui risultati conseguiti e in linea con i bisogni collettivi rappresentati; ai fini dell’efficacia, le pubbliche amministrazioni devono essere “operativamente” efficienti nel senso della trasparenza e coerenza delle procedure adottate, ed “economicamente” efficienti nel senso di adeguare il processo di realizzazione dei progetti alle effettive dotazioni allocate in bilancio.
Gli argomenti trattati nel precedente paragrafo sono un’utile introduzione per quanto andremo argomentando in questa sezione, e vediamo perché. Che l’economia trascuri gli elementi del benessere collettivo è smentito chiaramente dal fatto che un qualunque testo di Micreconomia (di solito un corso del primo anno) si sofferma sui cosiddetti “I° e II° Teorema dell’economia del benessere”. Essi costituiscono il fondamento teorico della visione economica del benessere, e sono la base solida sulla quale costruire ogni ipotesi di risposta pubblica finalizzata al miglioramento delle condizioni di vita delle collettività rappresentate.
In base al I° teorema, si può dimostrare che in un mercato perfettamente concorrenziale ogni equilibrio è “Pareto-efficiente”, ovvero esso giace in una condizione di ottimo nella quale non è possibile riallocare le risorse per migliorare il benessere di un individuo senza che se ne danneggi qualcun altro.
Più importante ai fini del presente lavoro è però il II° teorema, che in sintesi afferma che attraverso un mercato perfettamente concorrenziale è sempre possibile realizzare una condizione di equilibrio “Pareto-efficiente”, anche se la distribuzione iniziale delle risorse non è considerata equa e quindi funzionale al raggiungimento di quello stato di “ottimo”. Se volessimo derivarne una conseguenza, questo teorema suggerisce che efficienza ed equità sono finalità separate sia in termini di responsabilità che di processi operativi: l’efficienza la si approssima mediante il ricorso al mercato, mentre l’equità implica questioni di politica redistributiva che restano sotto la responsabilità dell’azione pubblica.
È in questo quadro teorico che si inserisce il tema elaborato da Sanfilippo dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione pubblica.
Il quadro consolidato degli studi economici è costruito sul concetto di “utilità marginale”. In termini di produzione ciò implica che l’impresa deve risolvere un problema di ottimizzazione, ovvero deve massimizzare l’output atteso (beni e/o servizi) minimizzando gli input (capitale fisico, capitale umano e tecnologia, essendo il denaro una variabile strumentale in questa analisi).
Pertanto, sul versante per così dire “privatistico” dell’economia – preferisco tuttavia denominarla “economia pura” – il concetto di efficienza si declina in termini di “efficienza di costo” nella funzione di produzione, costo che deve essere minimizzato perché l’impresa sopravviva in un mercato perfettamente concorrenziale. Quel mercato, per riprendere la notazione teoretica precedente, attraverso il quale si possono realizzare equilibri “Pareto-efficienti” funzionali al miglioramento del benessere collettivo.
Anche le pubbliche amministrazioni sono enti di produzione di servizi per la collettività. E tuttavia, alla luce di quanto correttamente evidenzia Sanfilippo, e nei termini elaborati dalla teoria economica i concetti di efficienza ed efficacia dell’azione pubblica vanno necessariamente coniugati in maniera affatto diversa rispetto alle utilità marginali degli attori coinvolti.
L’azione pubblica infatti deve avere come necessaria finalità – necessaria perché normativamente fissata – la realizzazione di obiettivi dotati di utilità collettiva. Sul raggiungimento di questi obiettivi si misura l’efficacia dell’azione pubblica. Se il focus dell’azione è quindi costituzionalmente orientato verso gli obiettivi, le pubbliche amministrazioni non devono a rigore risolvere un problema di ottimizzazione, ovvero non hanno un integrale problema di efficienza se non quello legato a correttezza, coerenza e trasparenza dei processi decisionali.
In sostanza la necessità di ottenere l’obiettivo fissato per i propri rappresentati, ovvero l’efficacia dei progetti di produzione dei servizi pubblici, prevale sulle valutazioni di efficienza di produzione di quei servizi, e caso mai implica soltanto una pre-analisi della coerenza fra obiettivi da raggiungere e dotazione dei mezzi economici per realizzarli. Notoriamente infatti le risorse finanziarie a disposizione delle pubbliche amministrazioni sono limitate, e sono di fatto costituite soltanto dai proventi della tassazione (sulla cui dimensione ottimale non è il caso di dilungarsi qui).
Concludiamo allora riprendendo il “II° teorema dell’economia del benessere”, e valutandolo alla luce della produzione e distribuzione di servizi pubblici: essi sono in genere sottratti a un mercato perfettamente concorrenziale, e non devono quindi necessariamente sottostare a considerazioni di efficienza produttiva da parte dell’agente pubblico. Devono tuttavia mantenere l’efficacia costituzionalmente fissata specie laddove impattino sui diritti fondamentali ed insopprimibili della persona; essendo le dotazioni economiche delle amministrazioni pubbliche limitate, il problema della equa redistribuzione delle risorse che emerge nella visione teorica “privatistica” dell’economia si ripropone con maggiore forza nel caso dei servizi pubblici.
È qui che la corrispondenza delle promesse elettorali con l’effettiva azione politica degli organi costituzionalmente preposti alla decisione collettiva gioca la sua efficacia, nella realizzazione degli obiettivi di pubblica utilità promessi a fronte di risorse scarse che devono essere equamente e correttamente distribuite.
In copertina: copyright Fotocronache Germogli