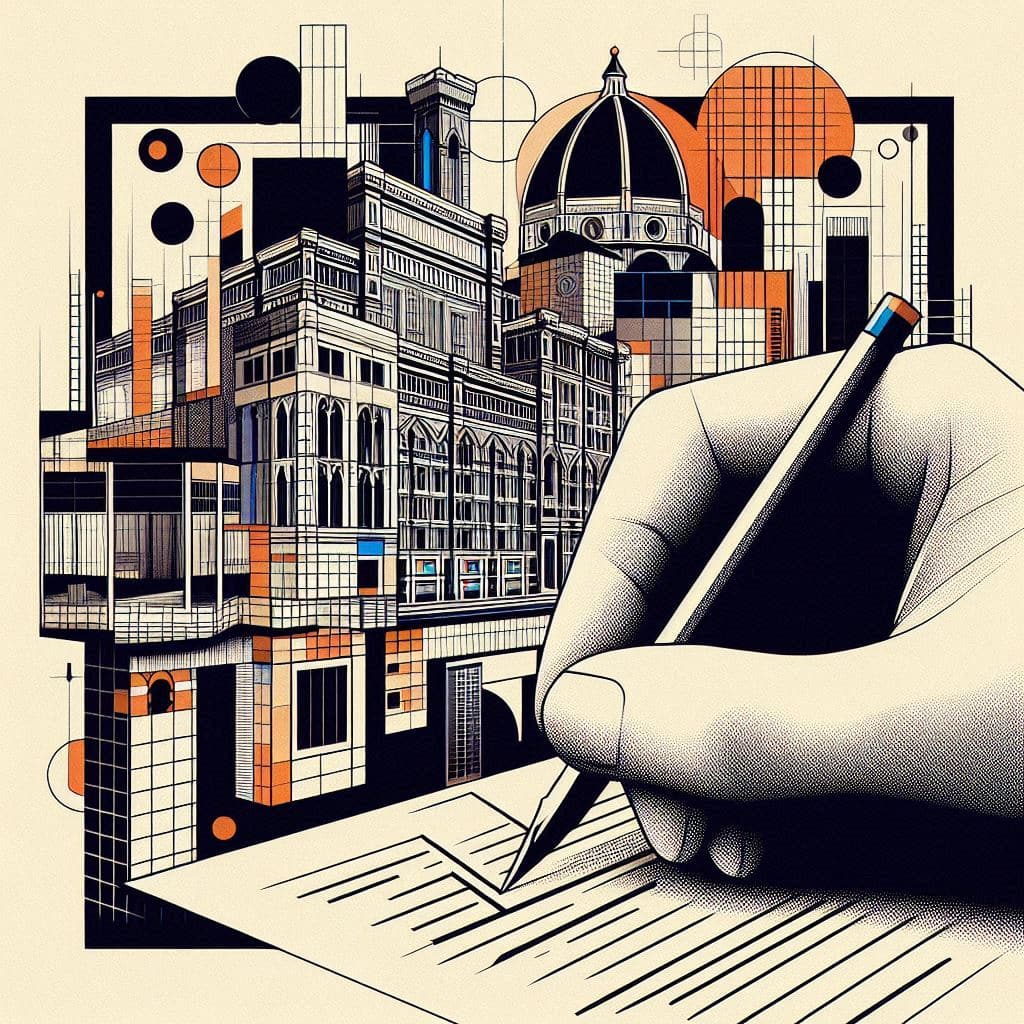di Michele Sanfilippo
Presto ci saranno le elezioni, vorrei proporre criteri di valutazione e di riflessione per esprimere un voto non solo consapevole, ma conforme alla Costituzione, perché ci si riempie la bocca con richiami aulici, ma che poi, regolarmente, sono, alla verifica della successiva tornata del tutto disattesi. Infatti, il giudizio sulla Pubblica Amministrazione si esprime mediante l’esercizio del diritto-dovere del voto. Il criterio di valutazione, al fine, però, di evitare di cadere in posizioni preconcette ed ideologiche, è dato dall’art. 97 della costituzione: «I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione».
L’imparzialità è un concetto semplice e di facile intuizione che ci riporta ai caratteri generali di una norma che deve essere, tendenzialmente dotata delle caratteristiche della generalità e della astrattezza ed anche la sua applicazione, nell’azione amministrativa concreta, deve adeguarsi a tale principio, anche se vi è il vezzo italico che “le norme si applicano per i nemici e si interpretano per gli amici”. In caso di imparzialità manifesta l’ordinamento ha in dotazione tutto lo strumentario giurisdizionale.
Più complesso è il concetto di buona andamento. Cosa vuole dire?
La definizione classica, da Wikipedia o chatgpt, è che per Buon Andamento, si intende “l’obbligo per la pubblica amministrazione di agire in modo funzionale agli interessi pubblici, perseguendo risultati utili, in tempi congrui e con risorse adeguate”. Bene! Lo studente ha passato l’esame, ma il cittadino ci ha capito qualcosa?
La giurisprudenza ed i sapientoni della dottrina collegano questo agire a due concetti: l’efficienza e l’efficacia. Entrambi i vocaboli derivano da una constatazione che ci vuole una azione da fuori (ex-facere), perché le cose non si realizzano da sole ed è richiesta, quindi, una attività. Nel compiere questa azione potremmo agire in modo non corretto: o perché si spendono troppe energie o perché non si raggiunge il risultato. Nel primo caso, uno sperpero di risorse, si parla di non efficienza, nel secondo caso, invece, si guarda al raggiungimento del risultato. In altre parole, la Pubblica Amministrazione si dota di strumenti in grado di valutare l’economicità degli interventi e (dovrebbe) individuare gli obiettivi che (dovrebbero essere) esplicati nel programma.
Non per essere indulgenti nei confronti degli amministratori, ma il fatto che non si raggiunga il risultato non è affatto cosa scontata. Nel dire questo, mi riferisco alla teoria della cosiddetta “Ecologia dell’azione”, formulata da Edgar Morin a partire dagli anni ’80. Per spiegarla facciamo un esempio: sono a giocare a biliardo e dichiaro di voler mandare in buca la palla. Poniamo che non vi siano altre palle. L’obiettivo, la palla in buca, dipende, pertanto, solo dalla mia capacità di indirizzare la palla. Poniamo, però, che vi siano una pluralità di palle sul piano del biliardo e che questi girino su se stesse, ognuna con un suo verso. Raggiungere l’obiettivo è molto più difficile, perché il mio tiro interagisce con il movimento della altre sfere. Questa è la descrizione di una realtà complessa, o più sinteticamente della complessità. Il filosofo francese Edgar Morin (ancora vivente e scrivente, da ultra centenario), ha espresso tale concetto con l’espressione nelle realtà complesse «l’azione sfugge all’intenzione». Il filosofo francese, quindi, ci insegna un metodo (come preannunciato dalla sua monumentale opera dal titotlo Il metodo): dobbiamo essere umili, perché non possiamo prevedere tutto, prudenti e dotarci di una etica della responsabilità che ci porta a valutare gli effetti collaterali delle nostre azioni e dotarci di strumenti di monitoraggio e di correzione.
La città è una realtà complessa e, quindi, spesso, anche se dotati delle migliori intenzioni, la nostra azione non raggiunge i risultati. Da qui, alcuni amministratori, ritengono che il miglior modo di governare sia, in buona sostanza, non fare assolutamente nulla, perché si rischia, pur dotati delle buone intenzioni, di fare peggio. L’atteggiamento è, di conseguenza, attendista; si interviene a tamponare. Questo atteggiamento di rassegnazione, non mi pare dei migliori, perché è sempre meglio prevenire e la programmazione è volta ad anticipare i fenomeni. Faccio un esempio che mi allarma: nel 2050, secondo le proiezioni demografiche, la popolazione italiana sarà costituita per il 50% da ultra ottantenni. Abbiamo meno di 25 anni per adottare politiche per rendere sostenibile o, quantomeno, ridurne l’impatto.
Il ruolo dell’elettore consapevole
Da questi semplici spunti si deducono importanti punti fermi che servono per il giudizio dell’elettore consapevole. Intanto, chi ci chiede il voto deve indicarci, con chiarezza, gli obiettivi: ossia perché gli si dovrebbe attribuire un potere (verbo ausiliario che pretende l’indicazione dell’azione ad esso collegata). Più l’obiettivo è generico, maggiore è la probabilità che la finalità della richiesta sia una mera occupazione di uno status o, peggio ancora, vi siano nascoste altre finalità, che potremmo sintetizzare con la sostantivizzazione del verbo in “il Potere” (quell’articolo che dice tutto), analogo a un acquitrino stagnante che genera, comunque, una situazione di parzialità. La finalità, in tal caso, non è certo il bene comune, ma la persistenza.
Ideologia e responsabilità politica
Da ciò si desume che quanto più la richiesta è di tipo ideologico, tanto più ci si allontana da un percorso virtuoso fatto di responsabilità e monitoraggio (e relative attività di correzione), violando sia le regole etiche indicate da Morin, sia, in buona sostanza, il parametro del buon andamento. La tentazione di trasformare le tornate elettorali in sfide ideologiche produce una grave violazione, sulla testa del povero elettore, del diritto/dovere di scegliere, e una successiva irresponsabilità, perché non vi sono parametri di valutazione e di fatto si produce una delega in bianco (quanti esempi di “Unti del Signore!”), contraria ai più basilari principi democratici.
Il modello amministrativo degli anni ’90
Purtroppo, il sistema disegnato per le amministrazioni locali alla fine degli anni ’90 – e di cui uno dei principali responsabili è proprio un fiorentino, allora capo di gabinetto del ministro Bassanini – ha prodotto un livellamento della decisione politica a mera attività contabile e amministrativa. In una visione di contenimento dei costi (i tagli lineari di Tremonti, i patti di stabilità interna, l’austerità…), si è avuto da un lato la corsa alla dismissione dei servizi mediante esternalizzazioni, con conseguente riduzione del personale degli enti locali; dall’altro, un modello aziendalistico che tende a fondere i due parametri dell’efficienza e dell’efficacia, dove l’obiettivo è il contenimento dei costi.
Le distorsioni delle esternalizzazioni
L’esternalizzazione ha prodotto però una perdita di competenze nei soggetti preposti al controllo. In alcuni casi si è assistito ad autentici cortocircuiti, dove il controllore era il controllato. In tale modello, da “bocconiani di noialtri” o dei poveri, la verifica è di breve termine, focalizzata solo sui bilanci.
La deriva ragionieristica e il decisionismo
Abbiamo assistito al prevalere di una visione ragionieristica che nulla ha a che vedere con il buon andamento della pubblica amministrazione. Il noto capo di gabinetto teorizzava che i Sindaci fossero dei manager – o meglio, dei City Manager – e che si dovessero eliminare sia i controlli interni che quelli degli organi rappresentativi (riduzione del ruolo dei Consigli comunali). Poi non meravigliamoci se arriva qualcuno con il piglio decisionista e propone la stucchevole locuzione del “Sindaco d’Italia”.
Obiettivi vincolati e Costituzione
Questi soloni non hanno tenuto conto di un particolare: gli obiettivi sono vincolati. Il Costituente, che secondo alcuni avrebbe scritto la “Costituzione più brutta” (giudizio da Forza Italia o da supplemento de Il Giornale), aveva però una visione derivata dall’esperienza. Il totalitarismo nasce dove “l’uomo è per lo Stato”; per questo motivo, il Costituente ha rovesciato l’assioma in: “Lo Stato è per (al servizio di) l’Uomo”.
Gli obiettivi sono quindi vincolati perché devono garantire i diritti inviolabili della persona umana, da intendersi non solo in senso individuale, ma anche nella sua dimensione sociale.
L'”efficacia costituzionale”
Ed eccoci al colpo di scena: l’efficacia è vincolata dalla Costituzione. Per spiegare questo concetto uso l’espressione “efficacia costituzionale”. Questa idea mi venne quando fui invitato a tenere una conferenza (dotta, direbbe Francesco Guccini) sulla chiusura dell’Ospedale di Massa Marittima. Mi scontrai con le esigenze efficentiste delle economie di scala, da un lato, e, dall’altro, con il principio di perequazione territoriale e il diritto alla salute: la distanza dall’ospedale centralizzato su Grosseto non garantiva il diritto costituzionale alla salute.
Esempi di inefficacia costituzionale
Alcuni esempi di valutazioni fallimentari secondo i criteri costituzionali:
- Sanità: le liste d’attesa (che prima non c’erano) e l’intasamento dei pronto soccorso, con conseguente scivolamento verso i privati.
- Ambiente: la vicenda dei rifiuti sulla FiPiLi, la distruzione del patrimonio arboreo di Firenze e la successiva cementificazione.
- Imparzialità: i cambi di itinerario delle tramvie (ad esempio quella da Campi Bisenzio), l’assenza di armonizzazione fra le realtà provinciali e il capoluogo, con evidente sperequazione territoriale.
Stato minimo, efficienza e libertà
L’economia efficientista nasconde una duplice visione: da un lato, asseconda la tendenza monopolistica del mercato (specie sul piano delle economie di scala); dall’altro, è figlia della filosofia politica del Minimal State di Robert Nozick. Si potrebbe contrapporre a questa visione la “Terza via” della dottrina sociale cristiana, dalla Rerum Novarum all’Ordoliberismo tedesco, dove lo Stato e il mercato devono stare lontano sia dalla persona che dai corpi intermedi.
Questa visione tutela la libertà, ponendo limiti all’intrusione sia dello Stato che del mercato nella sfera personale. Le politiche efficentiste, invece, spesso entrano in contrasto con i diritti di libertà, soprattutto quando cedono i servizi primari a soggetti in posizione dominante.
La questione democratica e le Multiutilities
La creazione di posizioni dominanti, per garantire presunte economie di scala, opera su ambiti territoriali diversi da quelli del potere politico. Così facendo, si sfugge al controllo democratico. Non credo che costruire aggregati come le Multiutilities sia conforme agli obiettivi costituzionali, in primis il controllo democratico sui servizi di interesse pubblico. Questi aggregati sembrano piuttosto strumenti per perpetuare il potere, distribuire poltrone e assecondare le potenze dominanti (francesi, inglesi o tedesche che siano).
Una proposta: l’Advisoring sociale
Lancio una provocazione: perché i candidati non sottopongono i propri programmi a verifiche di advisoring sociale?
L’advisoring sociale è una forma di monitoraggio tramite indicatori di umanità, come:
• gli Indicatori di benessere equo e sostenibile (BES),
• l’Indice di sviluppo umano (ISU).
Su questi temi hanno lavorato studiosi come Fitoussi, Stiglitz e Sen, all’interno della Commissione Stiglitz-Sen-Fitoussi (2008). Secondo Fitoussi: “Misurare meglio significa governare meglio. Se misuriamo solo la produzione economica, perdiamo di vista ciò che conta davvero: il benessere delle persone”.
Conclusione: Costituzione come azione
Un simile approccio è conforme al vincolo del buon andamento, ma è del tutto opposto allo scontro tra tifoserie (ideologiche, post-ideologiche, personalistiche). Mi verrebbe da dire, parafrasando il Vangelo, che il principio del buon andamento, ovvero dell’efficacia in senso costituzionale, corrisponda a dire: “Non chi dice Costituzione, ma chi fa la mia volontà!”
E prima che un fulmine mi incenerisca… vi saluto.