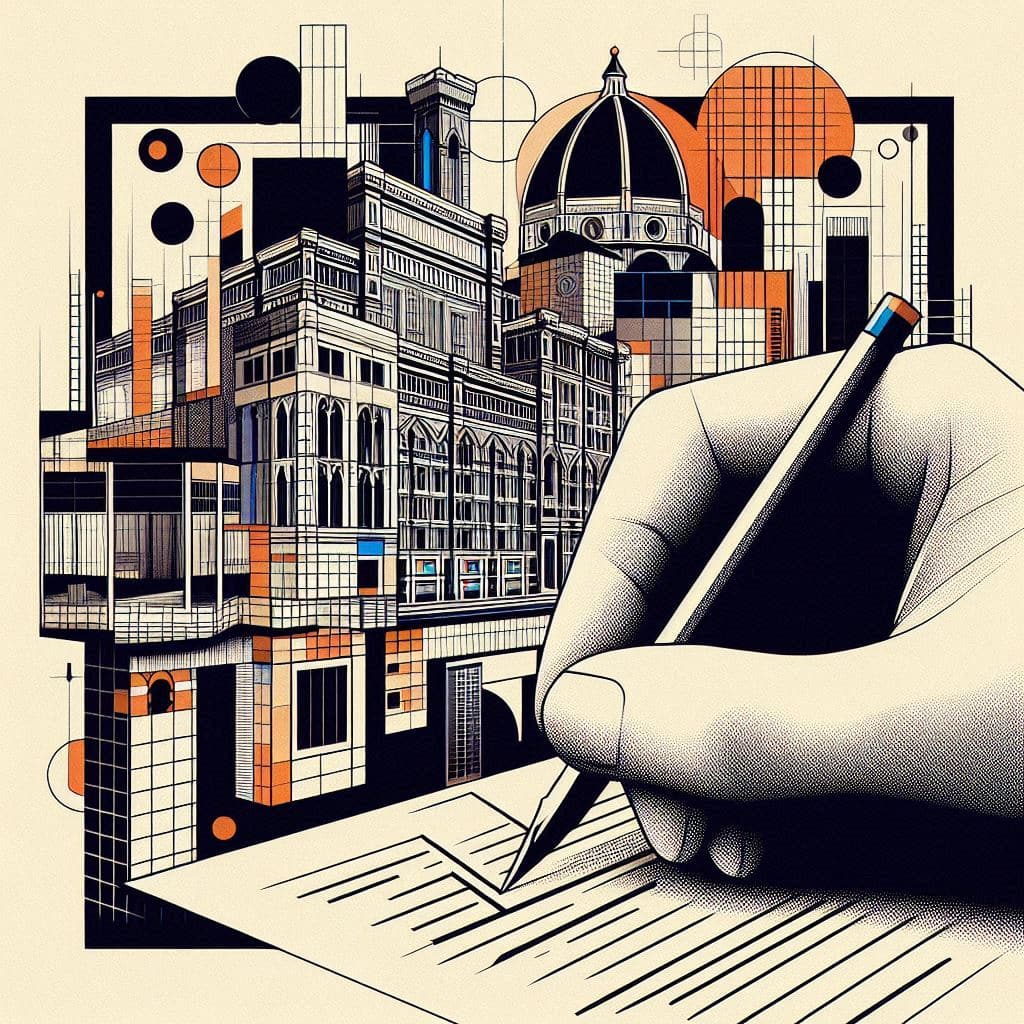Milano è considerata la città più “d’avanguardia” in Italia. Da là transitano tutte le mode e le tendenze. È la porta attraverso la quale penetrano i capitali ma anche i modelli culturali, non sempre meritevoli di imitazione. È la città, non a caso, della televisione privata, cioè del consumo e del trash. È anche il terreno di una profonda trasformazione urbana che segue le tendenze della globalizzazione. Firenze segue a ruota.
Per molto tempo, a Firenze in particolare, la bellezza non è stata solo un modo per riprodurre, nella naturale imperfezione della materia, le forme del Creato, scoprendo in esso una geometria cosmica da cui prendere esempio, è stata anche un mezzo di controllo politico. L’ordine di un’architettura definita e simmetrica, pur dando molta più libertà d’interpretazione di quanto si pensi, come prodromo di una gerarchia sociale.
C’è stata un’interruzione, brusca. Alla ricerca della bellezza si è sostituita un’estetica sostanzialmente piatta, anonima cioè senz’anima, non di rado brutta. Da un canone sostanzialmente in linea con la Classicità si passa al ribellismo costante, nel suo piattume. Certo, dagli anni ’80 in poi, nuove classi sociali e, soprattutto, nuove masse di popolazione hanno avuto accesso alla ricchezza e ai mezzi di comunicazione; dunque, il linguaggio – non solo nelle arti ma anche nei media – è stato ridotto e banalizzato fino all’estremo, fino quasi all’essere una parodia o un deliberato insulto, pur di farlo risultare, in qualche modo, digeribile e comprensibile all’uomo globale.
D’altronde, la modernità vive di strappi e distacchi, ma il grado di aperto odio verso il bello di prima non ha eguali.
Tutti sono pensati e disegnati allo stesso modo, i nuovi edifici: grandi, perché c’è il culto della grandezza (anche se le grandi città perdono abitanti), e perfettamente identici perché si è tutti “cittadini” di un villaggio “globale”. È così a Milano, dove proprio le grandi trasformazioni urbane sono al centro di un’inchiesta che sta facendo vacillare la Giunta Sala – preso tutto lo spazio a terra si passa a colonizzare il cielo in una sorta di “sacco verticale” -, da qualche anno, pure a Firenze. Gli studentati “di lusso”, che puntellano la cintura dei viali – come nuovi torrioni in sostituzione delle distrutte mura – ma penetrano anche nel centro che dovrebbe esserne esentato (via Pietrapiana) e fuori (via Mannelli) in barba a ogni limitazione. Spiccano per un’architettura standard; quello di viale Belfiore è talmente brutale da far invidia a certi mono-blocchi del blocco sovietico. Chissà cosa direbbe il grande Kurt Cobain, lui sì e i movimenti di Seattle capaci di anticipare la critica alla globalizzazione, a leggere “Come as you are” all’ingresso di quel blocco di cemento. In tutto questo, l’occhialuta Soprintendenza non ha nulla da eccepire; semmai, la Soprintendenza – come un notaio dell’urbanistica – serve a dare una sanzione di legittimità a queste grandi trasformazioni dal punto di vista tecnico-burocratico. Insomma, gli architetti e gli urbanisti di oggi – se ve ne sono – odiano apertamente il passato e perfino la natura, quale serbatoio, fonte d’ispirazione del bello.
Sì, anche l’attacco serrato al verde urbano va letto in quest’ottica: la conquista di nuovi metri quadrati e la loro destinazione all’uso e al consumo.
C’è anche tutta l’arroganza dell’uomo che smette di vivere, al centro sì ma in armonia, con il Creato – le sue stagioni, i suoi ritmi, le sue fioriture – e punta a cambiare la Terra violentemente per rifarla secondo i suoi gusti, per estrarne “valore”.
Allo stesso modo, appare sempre più nitidamente che queste mastodontiche speculazioni immobiliari, con ogni probabilità non sorrette da un ritorno economico nell’immediato almeno, servono a riversare denaro virtuale in investimenti fisici.
C’è una sovrabbondanza di denaro, per lo più denaro scadente, sganciato da decenni dalla base aurea e anche dalla produzione materiale di beni, che deve essere fatto fruttare diversamente: serve immobilizzarlo in patrimoni fisici che rinforzano la tenuta dei conti e un domani faranno comodo.
Dunque, i grandi fondi riversano investimenti a Milano, a Firenze, a Roma. Comprano spazi e li riconvertono a un consumo privato modellato sulle tendenze globali. Puntellano il loro controllo dei flussi di capitale incamerando immobili, trasformandoli in stanze per studenti o camere d’albergo. In più, dato che si è ricchi solo possedendo la terra, tornano ad acquistare – con poco – campi coltivabili, prosperando nell’atavica frammentazione in piccola proprietà; vi impiantano pannelli solari (tardivi gli allarmi dei coltivatori), batterie d’accumulo o, in generale, impianti che servano a far fruttare l’investimento, con buona pace della collettività che ne subisce i danni (rumore, inquinamento elettromagnetico).
Ovviamente, sono cambiati gli utenti. Queste grandi trasformazioni urbane sono pensate espressamente per i consumatori del grande duty free della globalizzazione, forse prossima a essere ristrutturata (l’ondata di dazi sicuramente frammenta il mercato globale in sfere di influenza e blocchi economici). Il ricco di oggi possiede e basta, vive distaccato senza la minima contezza del contesto e non ha relazione con il preesistente tessuto umano e sociale, non ha contezza del paesaggio, che è degradato a mero fondale. Vive in appartamenti certamente luminosi e open space (probabilmente senza quadri), mangia lo stesso cibo a Firenze come in America e in Asia, non va al museo perché preferisce “l’esperienza” virtuale. Consuma allo stesso modo. E anche questo è un cambiamento perché il ricco o il nobile, la storia fiorentina ne è testimonianza, si premurava sempre e comunque di mantenere un rapporto, pur nella fissità delle condizioni sociali di partenza, con la collettività.
In ultima istanza è cambiato il sistema di comando. Il capitale sfugge a ogni mediazione. Gli spazi di democrazia si riducono. Si espropriano spazi fisici e civici, senza nemmeno darne conto. Lo si apprende dai giornali che nascerà una cabina elettrica al Sodo. Nessuno è coinvolto nelle grandi trasformazioni e, a Milano, il proprio immobile si ritrova sommerso dal cemento verticale e non c’è più luce naturale.
Nel grande bazar globale l’Italia, meta prediletta perché bella e appetibile, da punto di riferimento per un canone mondiale di bellezza, ha iniziato a ricevere e riprodurre il brutto. Il turismo di massa, spinto anche da queste grandi speculazioni, ristruttura le città e sostituisce agli abitanti, che vive ed esercita diritti, un’utenza mobile, uniforme, non residente.
Tuttavia, la rinascita dell’Italia è possibile. Troppo bello, troppo benedetto è questo Paese per essere degradato così. Firenze sarà indispensabile perché custode delle forme del bello. Da ora in avanti, forti anche dei risvolti dell’inchiesta milanese, si deve opporre una critica rigorosa a questa pratica di espropriazione coatta, ma si deve aver chiaro che con questo modello tossico non ci sono mediazioni possibili. O la resa o la lotta.
In copertina: copyright Fotocronache Germogli