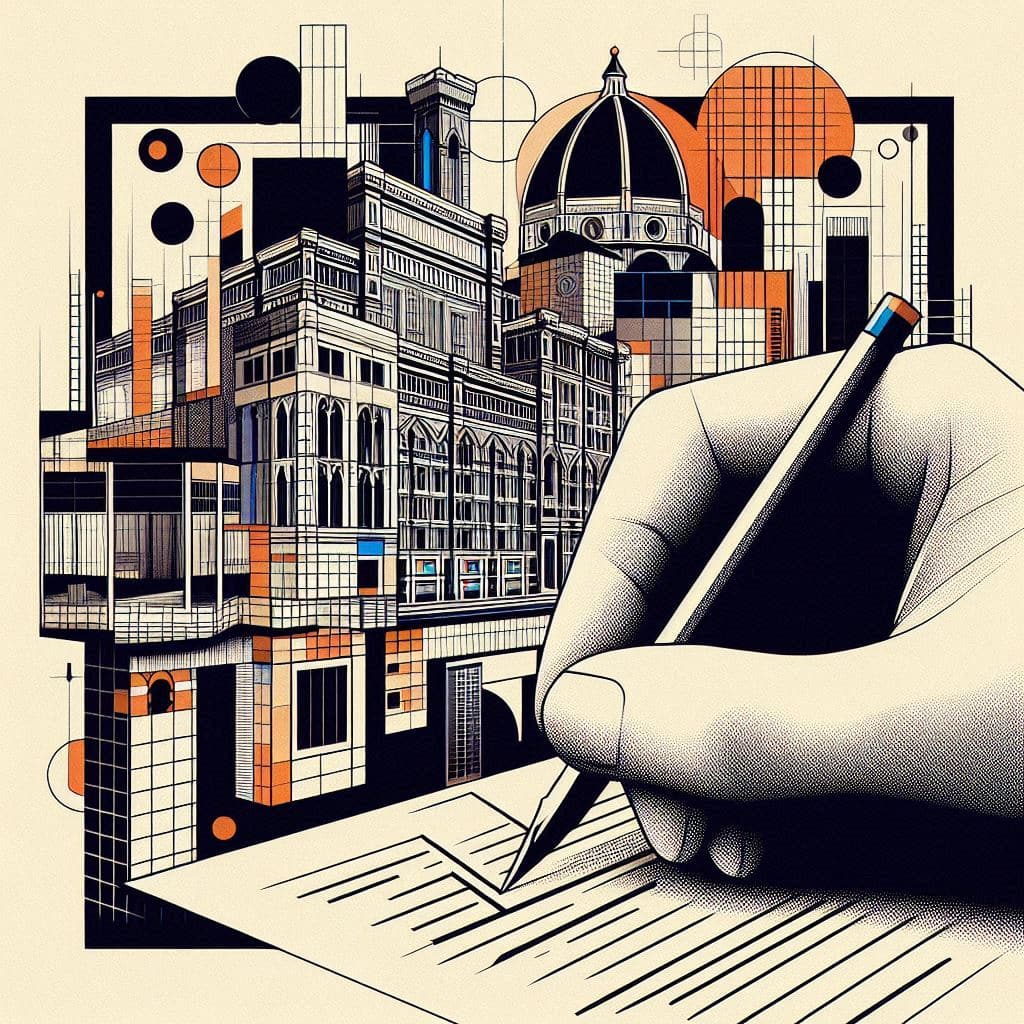Quando il palco progressista diventa passerella e chi invitava a “essere scomodi” scopre di aver costruito il problema che ora denuncia.
Vagnoli era ospite fissa delle kermesse d’ispirazione PD a Firenze. Dika dixit: “Carlotta è un’ispirazione”
Negli ultimi giorni l’opinione pubblica è stata travolta da una vicenda che mette a nudo il lato oscuro dell’attivismo mediatico: quella che coinvolge Carlotta Vagnoli, Valeria Fonte e Benedetta Sabene, tre figure presentate fino a ieri come simboli del femminismo digitale e, oggi, al centro di un’inchiesta per diffamazione e stalking online. Secondo le ricostruzioni della Procura di Monza, le tre avrebbero partecipato a una campagna di denigrazione sistematica sui social, una vera e propria “caccia all’uomo” condotta in gruppo, che ha sollevato interrogativi profondi sul confine tra impegno civile e persecuzione digitale.
Ciò che colpisce non è solo il contenuto delle indagini, ma il rovesciamento simbolico: chi si è eretto per anni a portavoce della sensibilità, del rispetto e della lotta alla violenza di genere, oggi si trova accusato di comportamenti che incarnano l’opposto di quei valori.
Carlotta Vagnoli, celebrata come autrice impegnata e divulgatrice femminista, diventa il paradigma di un attivismo che si è fatto spettacolo, di una militanza che, nel bisogno di visibilità, ha smarrito la misura e il senso. Valeria Fonte, che sui social invocava la ribellione e la rottura, ha trasformato il linguaggio del cambiamento in una retorica aggressiva, dove il disaccordo diventa insulto e la critica si fa gogna. Benedetta Sabene, meno esposta ma non meno partecipe, mostra come dietro un profilo pubblico “impegnato” possa nascondersi la stessa logica di gruppo e di potere che si dice di voler combattere.
Accanto alle accuse formali, dai dispositivi acquisiti emergono chat di gruppo in cui le tre avrebbero espresso messaggi d’odio, aggressivi e diffamatori, rivolti a figure pubbliche – anche apicali – e attiviste come: Sergio Mattarella, Liliana Segre, Michela Murgia, Selvaggia Lucarelli e altri soggetti della rete civile e culturale. Tali messaggi secondo gli atti riflettono un atteggiamento di sopraffazione e controllo, trasformando il dibattito civico e femminista in uno spazio di conflitto personale e mediatico. Questo comportamento contrasta radicalmente con il ruolo pubblico e la reputazione che le tre donne si erano costruite, mostrando quanto fragile possa essere il confine tra attivismo autentico e protagonismo tossico.
Eppure, il nodo più scomodo non riguarda solo le tre protagoniste. Riguarda la politica che le ha applaudite, sostenute, plasmate e portate sui palchi. Perché oggi chi, come Dario Nardella, ex Sindaco di Firenze e ora Eurodeputato del Partito Democratico, si scaglia contro le derive dell’attivismo tossico, dovrebbe ricordare di essere stato tra coloro che ne hanno favorito la legittimazione pubblica.
La memoria istituzionale non può cancellare che proprio la Regione Toscana, guidata dal centrosinistra, abbia premiato Carlotta Vagnoli con il Pegaso nel 2023 durante il “Next Generation Fest”, un evento celebrato come simbolo dell’impegno dei giovani per un mondo più giusto (La Firenze che vorrei ha parlato anche del caso Martina Strazzer). E che in quell’occasione Bernard Dika, allora Portavoce del Presidente Eugenio Giani e oggi Consigliere Regionale PD, dichiarò entusiasta:
«Ho detto a Carlotta che è un esempio, un’ispirazione per noi, perché ci insegna quanto sia bello avere il coraggio di esprimere le proprie idee, di non avere paura delle proprie idee, e soprattutto di essere scomodi… e noi giovani per cambiare il mondo dobbiamo essere scomodi, altrimenti resta così com’è».
Parole che oggi suonano come un’amara profezia: la politica che invitava a “essere scomodi” si trova ora a dover gestire le conseguenze di ciò che ha creato.
Non è la prima volta, del resto, che le stesse amministrazioni progressiste hanno concesso visibilità e spazi istituzionali a figure rivelatesi poi divisive. Già nel 2021, Vagnoli era ospite della rassegna “L’Eredità delle Donne” alla Manifattura Tabacchi, evento patrocinato dal Comune di Firenze e presentato come vetrina del pensiero femminile contemporaneo. Una lunga serie di inviti, saluti istituzionali, post celebrativi e riconoscimenti che hanno trasformato il messaggio in marchio, l’attivismo in prodotto e la riflessione in spettacolo.
Oggi, davanti alle accuse e alle rivelazioni che emergono dalle chat e dalle indagini, la sinistra istituzionale finge stupore, come se non avesse mai visto o sentito ciò che accadeva nei circuiti che essa stessa ha alimentato. Ma la verità è che per anni si è preferito confondere l’impegno civile con l’influencer marketing, la lotta per i diritti con la costruzione di consenso mediatico. In nome della “modernità” e della “comunicazione giovanile”, la politica ha affidato temi profondi come: il femminismo, la parità, l’educazione digitale a chi li trattava come brand personali. Oggi quel castello di carta si sgretola, mostrando quanto fragile fosse la base su cui era stato costruito.
La domanda, a questo punto, è inevitabile: chi ha concesso il microfono e chi lo ha usato per amplificare se stesso? È troppo comodo indignarsi a posteriori. La responsabilità non è solo di chi ha scritto, parlato o insultato, ma anche di chi ha legittimato, invitato e celebrato. Se la sinistra vuole davvero ricostruire credibilità nel campo dei diritti e della cultura, deve ammettere di aver confuso la militanza con la popolarità, l’impegno con l’immagine, la sostanza con la performance.
Il caso Vagnoli-Fonte-Sabene non è un incidente isolato, ma un sintomo di una malattia culturale più ampia: quella di un attivismo spettacolarizzato, alimentato da un sistema politico che preferisce figure “visibili” a pensieri solidi. E mentre i like si trasformano in prove d’indagine, resta una lezione amara: chi costruisce il consenso sulla superficie, prima o poi ne paga la profondità.