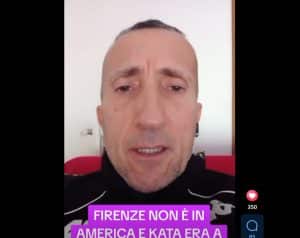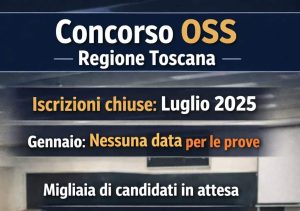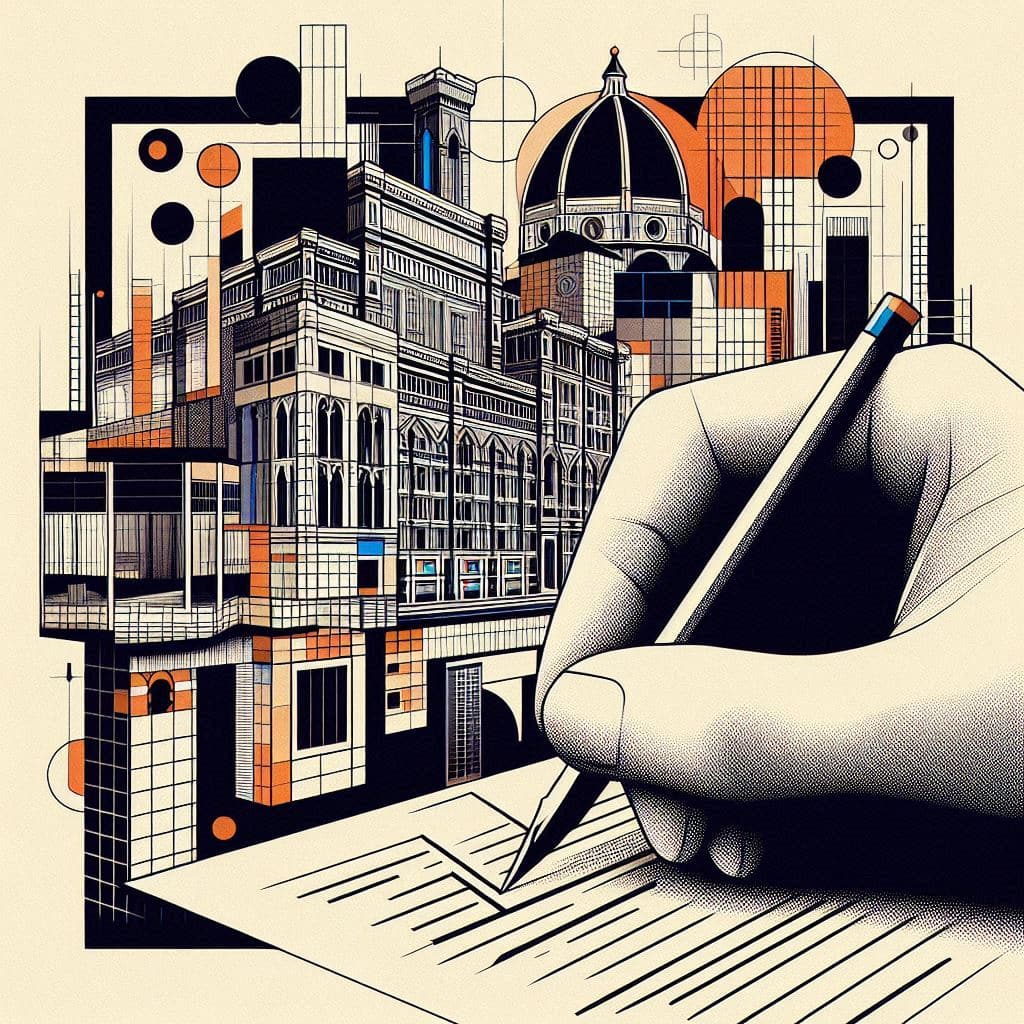di Michele Sanfilippo
Per comprendere il tema del rapporto fra Costituzione e Città, a mio avviso, occorre partire dal concetto di eguaglianza, che, in termini costituzionali, rimanda al tema della dignità umana e impone la creazione di un armamentario giuridico, ideologico e di politiche sociali, volte a consentire ad ogni uomo – nessuno escluso – di vivere degnamente, avendo, almeno, quel minimo per vivere dignitosamente, o come sapientemente recita l’art. 36 della Costituzione: “(…) In ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.
I beni primari sono, quindi: una casa (salubre), un sostentamento tale da garantire una vita dignitosa (attraverso il lavoro come strumento di valorizzazione umana), la possibilità di costruire una famiglia e ciò proietta ad una dimensione futura, cioè il diritto ad un futuro che il costituzionalismo statunitense sintetizzava nella formula “Diritto alla felicità”.
Una siffatta persona, che vive in un contesto rispettoso della sua dignità, sarà libero dai bisogni e perciò libero.
Il tema della libertà dal bisogno e della dignità umana è il nodo centrale della democrazia.
A tale proposito si può citare, in contrapposizione, la tesi elitista di Sidney Sonnino, che riteneva che chi non contribuiva attivamente alla società – per esempio un senzatetto, appunto – non dovesse avere il medesimo peso politico di un cittadino “virtuoso”: «Non si può mettere sullo stesso piano, nel decidere delle sorti dello Stato, un cittadino colto e impegnato e un barbone che dorme sotto i ponti».
Quanto pare attuale la posizione di Sidney Sonnino! Mi viene alla mente uno spot pubblicitario di un politico che vuole correre alle prossime regionali che mette sullo stesso piano i diritti, i doveri, perché ad avviso del medesimo “I diritti senza i doveri generano privilegi”. Può essere condivisibile in un contesto di piena eguaglianza, ma una cosa è certa, la nostra non è più una società che mira all’eguaglianza sostanziale.
A questo proposito giova ricordare la formula attribuita a Peter Glotz, importante politico del Partito Socialdemocratico Tedesco (occidentale) che nel 1984 coniò l’espressione “La Società dei Due terzi” per spiegare i meccanismi che generano marginalizzazione ed esclusione sociale e, conseguentemente conflitto. Da qui gli studi sociologici di Ralf Dahrendorf sul conflitto sociale nella modernità.
Oggi la società ha certamente superato l’ideale piramide stratificata, perché la classe media è stata divelta da processi di divaricazione sociale che si misurano, in economia, con l’Indice Gini che è un indice dato dal valore da 0 a 1, dove 0 indica una società egualitaria e 1 una società con una forte connotazione di divaricazione fra ricchi e poveri. La diseguaglianza crea conflitto.
L’indicatore di Corrado Gini, però ha dei limiti, perché fotografa la situazione, ma non ci dice chi è il povero e, probabilmente, non riesce a calcolare gli “invisibili” e le nostre città sono piene di invisibili, penso agli anziani soli, alle persone senza fissa dimora, agli immigrati esclusi dal circuito virtuoso del lavoro. Se guardo l’indice Gini, vedo società fortemente disegualitarie (Sudafrica con lo 0,63 o gli Usa con lo 0,43) ed una Italia posizionata intorno allo 0,35. Firenze dovrebbe attestarsi sul livello della Toscana, intorno allo 0,32.
Pensiamo alla nostra città e guardiamo le nostre strade, piazze, stazioni e vedremo la povertà. Lo studio di Luca Ricolfi sulle “società signorili di massa” ci spiega che in dette tipologie di società (quelle occidentali) si assiste ad una disoccupazione mascherata, dove molti campano non sul proprio lavoro ma vivono grazie a pensioni, patrimoni familiari o reddito pubblico, pur in un contesto di iperconsumo con standard di vita alto, anche senza partecipazione al lavoro produttivo, in un contesto di decrescita demografica e occupazionale, a piramide rovesciata (i pochi che lavorano devono sostenere i molti) che produce una dipendenza da eredità e Stato sociale, la società è sostenuta dal capitale accumulato nel passato, da qui il forte debito pubblico e l’inevitabile crescita esponenziale dello stesso.
Se faccio il parallelismo fra la “Società dei due terzi”, dove il terzo escluso era dato dai precari, disoccupati, nuovi poveri, soggetti a marginalità strutturale e la “Società signorile”, constato, con disperazione che la precarietà e povertà sono il segno distintivo della maggioranza della popolazione, specie per i giovani.
Per capire i livelli di povertà o, come si dice, la “Soglia di povertà”, è dato da un valore inferiore al 60% del reddito medio. In Italia, tale soglia, è fra i 12.000 € ed i 10.000 € (nelle grandi città). Traete voi le conclusioni, in rapporto alle pensioni ed alle opportunità di guadagno per i giovani, ai separati, alle madri monoreddito.
I valori, però cambiano in base all’effettivo potere di acquisto (comparazione che si effettua confrontando il prezzo del panino Big Mac ed il reddito).
Una politica che non guarda queste cose è destinata a creare sacche di diseguaglianza. Ed ancora di più, una politica che crea Corvée generalizzate, aumenta la forbice di diseguaglianza.
Vi sono servizi essenziali e correlati diritti fondamentali (quelli che garantiscono la dignità delle persone) che non possono e non devono essere appesantiti da un aumento dei prezzi, perché tale aumento innesca meccanismi di espulsione sociale e sacche di privilegio.
A questo proposito è interessante notare che l’etimologia di privilegio (deriva da privus, “individuale”, “privato” e lex (legis), “legge”), ovvero la “legge privata”. Si deve comprendere che “Privato” deriva dal verbo “Privare”, ciò indica quel processo avvenuto intorno al XIII° secolo che ha portato alla sottrazione delle terre comuni (i beni comuni) a favore dei pochi (Magna Charta Libertatum – per i Baroni – e la Carta dei boschi 1218 per i villaggi).
Chiedo solo di riflettere alla presenza degli spazi pubblici, perché a guardare bene, si assiste ad una riduzione degli stessi, “concessi” dal potere politico a società (quindi soggetti privati, anche se con capitale pubblico). Circolare (libertà di movimento) e, quindi, fermarsi (parcheggio) può essere fatto solo mediante una transazione economica, priva di corrispettivo (cioè una gabella!).
Il trasporto pubblico (le famose tramvie) è soggetto ad un aumento per mantenere la redditività degli strumenti finanziari sottesi ed in base a quella redditività si disegna la città con collettori (parcheggi scambiatori) volti ad aumentare i fruitori, ossia la redditività.
Lo stesso potremmo dire per le politiche della casa ed il proliferare del turistico-ricettivo e le agevolazioni (veri privilegi) per la costruzione di alberghi, quando avremmo bisogno di dare una casa e di un ammodernamento del patrimonio abitativo, che specie nelle periferie risente del passare del tempo di case costruite negli anni ’50 e ’60 con le tecniche e materiali in voga all’epoca.
In tema di privilegio, ricordo che lo stesso è un vantaggio speciale o una posizione favorevole concessa a una persona o a un gruppo che si può realizzare mediante meccanismi di segregazione spaziale.
Invito tutti a riflettere ai meccanismi impliciti di segregazione spaziale che sono presenti nella nostra città, dalla movida allo stadio, dallo svuotamento funzionale del centro, ormai mero meretricio turistico e poi città alta per la globalizzazione, destinata ad un aumento dei prezzi sulla base delle grandi città della globalizzazione (una media di 15.000/18.000 € al metro quadro per l’acquisto) e l’esodo verso le periferie fuori contesto cittadino.
Questo modello è ben descritto dal sociologo francese Armand Mattelart con la sua definizione di “città globalizzata”. In dette città vi è una secante, fisica, che divide la parte globalizzata (la città alta e dei ricchi) dalle aree di produzione, di classi subalterne.
Pensate, ora, alle secanti che si creano con i percorsi della tramvia ed i tragitti obbligati (ad imbuto) per i traffico.
Lo spazio non consente di esporre le possibili alternative a detto modello.
Noto solo quanto è distante questo modello di città dal sogno costituzionale!
E quanto è distante il sogno rinascimentale della “Città perfetta”, che ricercava l’armonia. Per questo Firenze è sempre più un museo a cielo aperto, svuotata del suo autentico messaggio di una vocazione storica che rischia di diventare sterile simulacro dei lustri passati.