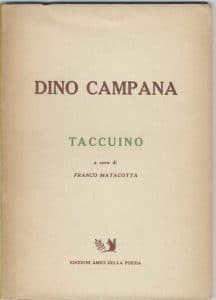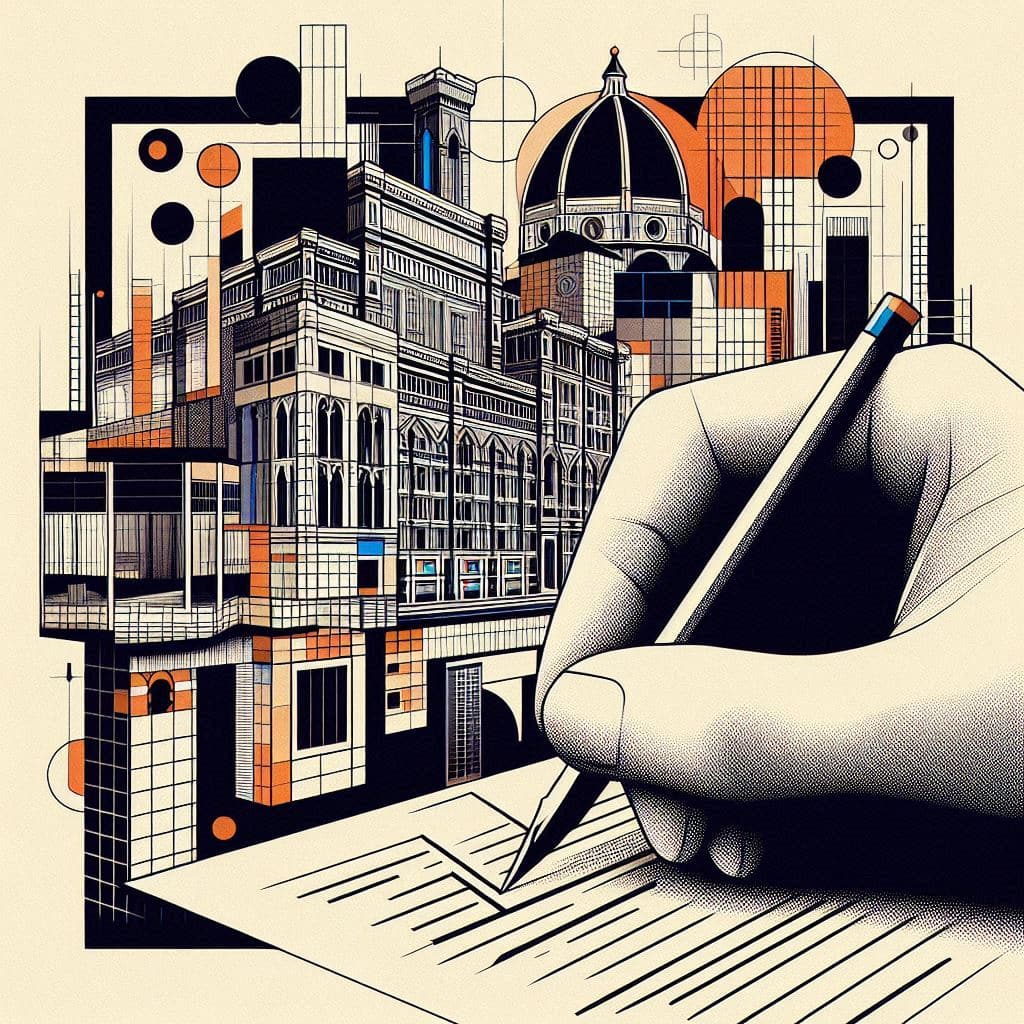Siamo lieti di ospitare una bella riflessione di Francesco Borgognoni sulla città
“… Invece Dante deve accettare quel Dio così come deve accettare che Beatrice non lo abbia amato, che Firenze sia infame, così come dovrà accettare l’esilio e la morte a Ravenna…”
Non molti anni orsono, i cittadini di Firenze hanno attraversato le celebrazioni dei centocinquanta anni di Firenze Capitale. L’occasione è stata importante, a mio avviso, soprattutto perché ha stimolato la riflessione su un argomento del quale si erano perse le tracce. E questo argomento è la città e la sua storia.
Da allora è passato assai più tempo di quello segnalato dai calendari.
L’evoluzione della comunicazione on-line ha, banalmente, configurato, presso le nostre coscienze, un nuovo spazio-tempo, che ha cambiato radicalmente la nostra percezione, anche fisica, dell’esistere. Il senso comune, infatti, ci racconta che l’Universo, tutti gli Universi, sono nello smartphone di ciascuno di noi. Nella nostre tasche si custodirebbe il potere di una trasmigrazione perenne e assoluta. Deserto o campagna, selva o città, la connessione dell’individuo alla sua comunità di riferimento è possibile sempre, deprivandone la collocazione fisica di importanza e, forse, anche di necessità. È il mondo del Virtuale che si afferma come unica realtà possibile.
Naturalmente non è che le cose stanno proprio così.
Anche se ce ne dimentichiamo, siamo una altra cosa, perché veniamo da una altra storia.
Anche per queste ragioni, sviluppare una riflessione su Firenze, città conosciuta nel mondo da molti secoli, potrebbe, proprio per la unicità millenaria che la distingue, aiutarci a sviluppare una riflessione compiuta sulla città, come rappresentazione simbolica della storia dell’umano svolgersi, e sul significato che questo può assumere, nel quadro più ampio della costruzione di un senso del nostro passato.
La città, infatti, non è solo una dimensione geografica dello stare, bensì una categoria complessa del convivere.
La città che, in Europa, segna – nei modi e nelle forme – il passaggio dal Medio Evo all’Età Moderna. La città, la cui aria rendeva liberi, così difficile da gestire nelle sue contraddizioni, è stato, infatti, il laboratorio di alchimie sociali complesse. La città, nel cui ventre si è generata la politica, che quando è città vera, è prima una vocazione e dopo un destino. Il luogo dove, idealmente, si è posta la pietra angolare su cui si è costruito l’edificio della narrazione dell’Occidente.
Sviluppare una riflessione, dicevo. E farlo a partire da una attenzione nuova per il periodo tra più felici della sua storia, maturato in quei cinquanta anni a cavallo tra ‘800 e ‘900.
Da cittadino di Firenze, travolto dall’amore quanto dalla delusione per la città dove sono nato e dove ho passato quasi tutta la mia vita, non posso non indulgere alla nostalgia per quella Firenze del “dopo Capitale”, che ancora, in qualche modo, ci parla e ci lancia messaggi e che nel mondo attuale potrebbero trovare maggiore considerazione.
Dopo il tempo della Firenze medievale – della città dei Templari e della Pietra – dopo la Firenze dei Medici e del Rinascimento, dopo il Settecento Riformatore di Pietro Leopoldo, il tempo della Città Capitale d’Italia sintetizza una esperienza che va aldilà della storia e che ci lascia un messaggio che – ripeto – dovremmo raccogliere.
La Firenze di Gian Burrasca e dell’avvocato Maralli e dell’editore di Pinocchio è una città con una vocazione cosmopolita e nella quale le ristrutturazioni urbanistiche sono il teatro di una azione segnata da una concezione laica della vita cittadina e da una attenzione alle molteplicità etniche e religiose che ancora fa scuola.
La chiusura del Ghetto – totalmente concordato con la Comunità Ebraica – e la costruzione della Sinagoga si inseriscono in un processo ampio, che vede la città popolarsi di attività e imprese che nel loro stesso nome portano il segno di una provenienza e la ricerca di una possibilità. Nomi strani: Pineider, Rivoire, Bemporad, Paskowscki, Olscki, Le Monnier, Seeber, Neuberg, Stibbert e tanti altri che a Firenze nell’Ottocento e nel primo Novecento avevano individuato proprio nella nostra città il luogo privilegiato nel quale tentare una esperienza. Firenze Capitale, simbolicamente questo tentativo rappresenta ed il tempo a seguire, fino allo scoppio della Prima guerra mondiale, è un tempo felice e fecondo. Il tempo della ri-celebrazione di Dante e della sua lingua. Che è poi la nostra. L’italiano. Il codice espressivo delle élites d’Europa che, nella mitologia del nostro passato d’arte, celebrano l’approdo ad una Gerusalemme laica, che il rigore, stupendo e terribile del Battistero, celebra. Nel ricordare e nel ricordarsi che impresa e cultura, commercio ed arte, qui si sono virtuosamente incontrati, rappresentandosi nella bellezza dei luoghi e nella cura dei paesaggi, in una bellezza che era misura, armonia e visione del futuro, impariamo finalmente la lezione del costruire.
Niente è scritto. Il futuro appartiene a coloro che ne hanno visione.
In copertina: Copyright Fotocronache Germogli