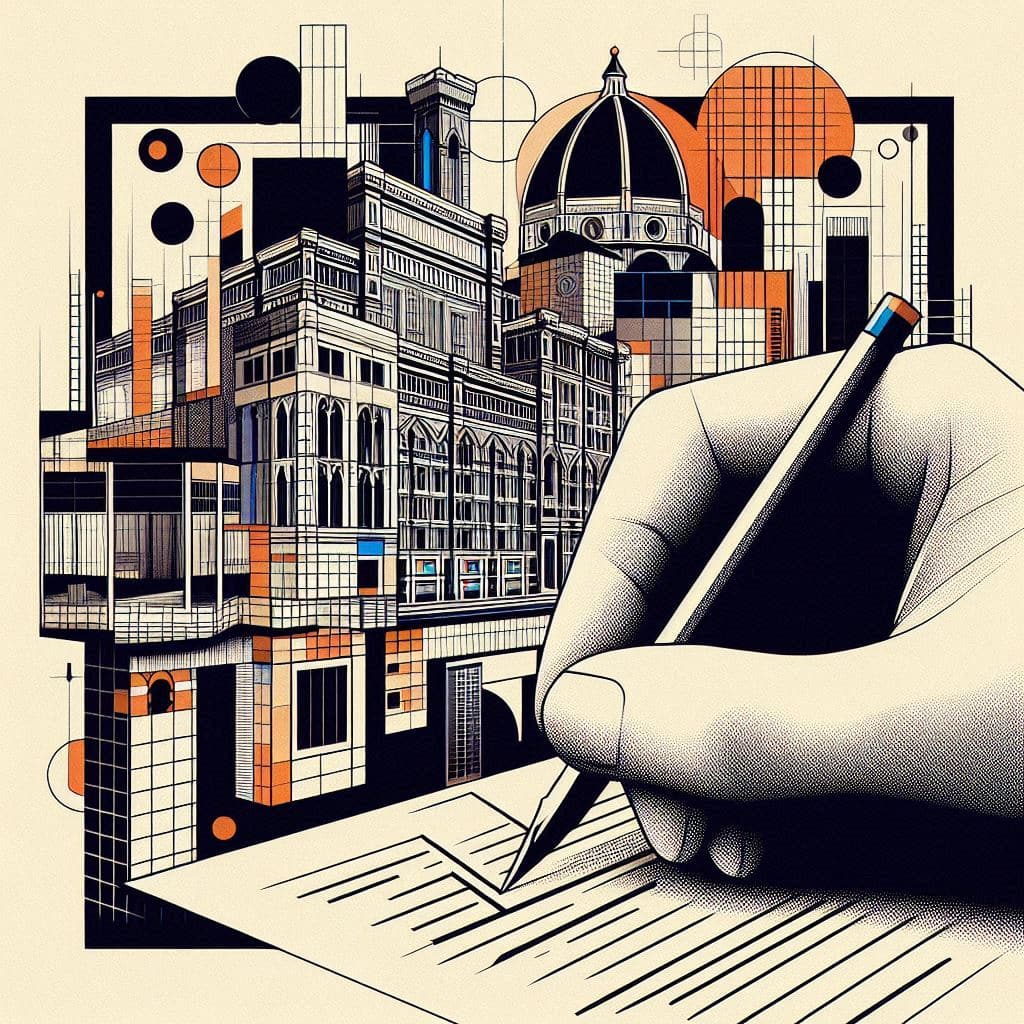I numeri raccontano una città senza zone sicure: con 6.507 denunce ogni 100mila abitanti, Firenze è la seconda provincia più criminale d’Italia, dove il degrado ormai si è fatto sistema
Di Roberto Vedovi
Firenze è ufficialmente la seconda provincia italiana per densità di reati: 6.507,8 denunce ogni 100 mila abitanti, un balzo del +7,4% rispetto al 2023 che ha portato il totale a 64.392 delitti (+4.439 in un solo anno). Per trovare un volume simile bisogna tornare al 2007, prima che una lunga fase di calo portasse la criminalità ai minimi storici pre-pandemia. Oggi la curva è risalita, e non si tratta di un rimbalzo fisiologico: la micro-criminalità – furti, scippi, rapine, danneggiamenti – si è diffusa a macchia di leopardo su tutto il territorio comunale.
Non esiste più un centro “pericoloso” e una periferia “tranquilla”: dal Duomo a Novoli, da San Lorenzo all’Oltrarno, da Rifredi a Campo di Marte, il degrado e la paura serale sono diventati compagni quotidiani dei fiorentini. Quartieri un tempo tranquilli ora registrano furti in abitazione in aumento (4.236 denunce, terza in Italia) e rapine che non risparmiano più nessuno, con una percezione diffusa di insicurezza che erode la qualità della vita: una signora non può più portare la borsa a tracolla senza ansia, un genitore esita a lasciare i figli rientrare da soli da scuola o dalle uscite con gli amici dopo il tramonto, costretti ad attraversare luoghi insicuri come parchi bui o strade affollate da spacciatori, un commerciante chiude bottega con il cuore in gola.
- I minori: un esercito di baby-rapinatori, intrappolati in un sistema che fallisce
E per le strade di Firenze sono ormai i minori, stranieri nella maggior parte dei casi a farla da padrone: un esercito di baby-rapinatori, intrappolati in un sistema che fallisce. Il dato nazionale è allarmante: 38.247 minori denunciati o arrestati nel 2024, +30% sul 2019 e +16% sul 2023. È il numero più alto dell’ultimo decennio, con uno su quattro rapinatori in strada under 18. A Firenze il fenomeno si vede nei 765 scippi in pubblica via (seconda in Italia dopo Roma) e negli 11.051 furti con destrezza (+48% in un anno, record assoluto dal 2006). Questi non sono reati isolati, ma il sintomo di un disagio giovanile esploso post-pandemia: isolamento, iperconnessione digitale, famiglie fragili. Moltissimi dei protagonisti sono ragazzi stranieri arrivati soli in Italia, spesso nordafricani di 16-17 anni, finiti nel circuito della devianza.
Secondo la Garante per l’Infanzia Marina Terragni, più del 4% di loro finisce nella giustizia minorile; il 44% dei loro reati è contro il patrimonio – borseggi, scippi, piccole rapine. Sono ragazzi con traumi migratori, dipendenze da crack o hashish, zero reti sociali: la pandemia ha amplificato tutto, trasformandoli in prede facili per bande organizzate che li usano come “manodopera” nei furti turistici. La risposta italiana è stata repressiva e superficiale: il decreto Caivano ha inasprito le pene per i minori, ampliando la custodia cautelare, ma la prevenzione – scuole aperte la sera, associazioni sportive gratuite, percorsi di inserimento – è rimasta un miraggio.
A Firenze, peggio ancora: i Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) – che ormai ospitano sia adulti che minori stranieri arrivati soli – sono spesso gestiti da cooperative private che incassano migliaia di euro al giorno per ospite (fino a 80-100 euro pro capite, finanziati da fondi pubblici regionali e statali) ma offrono servizi minimali. Controlli sporadici, educatori sotto organico (spesso uno ogni 10-15 ragazzi), fughe notturne che finiscono in stazione o parchi. Queste strutture si sono trasformate in serre di devianza: i minori escono senza competenze, senza regole, pronti a delinquere per fame o per appartenenza a un gruppo. Per anni si è chiuso un occhio, in nome di un’accoglienza “umanitaria”, ma oggi il conto lo pagano i fiorentini: un minore che ruba una borsa in via dei Calzaiuoli non è un “fantasma”, è il prodotto di un sistema che lucra sul caos invece di educare.
- Gli stranieri: 56% degli arrestati, il prezzo di un’immigrazione senza bussola
A Firenze il 56% di chi viene fermato o arrestato è straniero – seconda solo a Prato (62%). La sproporzione è enorme nei reati di strada: 69% dei furti con destrezza (Firenze prima in Italia), 61% dei furti con strappo, 60,1% delle rapine in pubblica via (seconda in Italia con 765 denunce). Gli irregolari – appena il 5,6% degli stranieri presenti in Italia (circa 321 mila su 5,7 milioni) – commettono circa il 70% dei reati imputabili a immigrati, secondo lo studio Barbagli-Colombo (1988-2009) e le analisi più recenti di Paolo Pinotti (Bocconi). Chi è regolarmente residente, invece, ha una propensione al crimine in linea con gli italiani – la regolarizzazione dimezza la recidiva, come dimostrato dall’indulto del 2006 per rumeni e bulgari post-UE.
Ma per decenni la Toscana ha praticato un’immigrazione incontrollata, con porte spalancate senza filtri né sbocchi. Permessi umanitari rinnovati automaticamente, espulsioni cartacee mai eseguite, flussi che finiscono nei CAS senza piani di integrazione. Le cooperative – spesso le stesse che gestiscono i CAS per adulti e minori – hanno costruito un business milionario sull’accoglienza: bandi al ribasso vinti con offerte aggressive, personale precario senza competenze psicologiche o linguistiche, zero monitoraggio post-accoglienza. Risultato? Quartieri come Santa Maria Novella o San Jacopino sono diventati zone franche dove spaccio di crack (consumato in pubblico, a pochi passi dai turisti), prostituzione e micro-criminalità sono tollerati in nome di una solidarietà malintesa. L’immigrazione irregolare non è “colpa” degli stranieri, ma di politiche che li lasciano sradicati, invisibili, costretti a sopravvivere con furti o dosi. E i fiorentini? Pagano con violenze sessuali in aumento (+7,5% nazionale, quarta in Italia qui) e un degrado che allontana investitori e residenti.
- Il turismo: 18,8 milioni di bersagli in movimento, un amplificatore letale
Firenze ha 366.927 residenti, ma nel 2024 ha ospitato 10,3 milioni di pernottanti e 8,5 milioni di escursionisti giornalieri. Di giorno la popolazione triplica, creando un serbatoio infinito di vittime per borseggiatori e scippatori. I reati si concentrano nelle ore di punta turistica – Piazza della Stazione un “suk” di furti –, ma poi si diffondono ovunque: i malviventi si spostano con i mezzi pubblici, colpiscono nei mercati rionali, nei parchi, nei supermercati. Il tasso di delittuosità ufficiale non tiene conto di questa “popolazione flottante”, rendendo i numeri già drammatici ancora più sottostimati. Il turismo, che porta miliardi, genera anche vulnerabilità: turisti distratti sono prede ideali, e il ciclo si autoalimenta – più insicurezza, meno recensioni positive, meno arrivi.
- L’amministrazione risponde con slogan e selfie: tanti proclami e nessuna visione
La sindaca Sara Funaro (PD) ha annunciato 200 nuove assunzioni nella Polizia municipale e l’obiettivo di raggiungere 1.000 agenti entro il 2026. Ma dietro i numeri, la realtà è ben diversa. Non esiste una formazione mirata: i nuovi vigili non sono preparati ad affrontare bande giovanili, situazioni di de-escalation o la microcriminalità organizzata che affolla le strade. I corsi restano generici, senza alcun focus su traumi migratori, dipendenze o dinamiche sociali complesse.
E l’unità antidegrado? Appena 90 agenti per una città di 380 mila abitanti – a cui si sommano milioni di turisti – un presidio simbolico che copre a fatica il centro storico, lasciando il resto di Firenze scoperto e vulnerabile.
Il Comune partecipa regolarmente al COSP (Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica), presieduto dal Prefetto e con vertici delle forze dell’ordine. Lì arrivano dati puntuali su reati e trend. Il problema? Le priorità portate dal Comune sono spesso di natura economica o di immagine: Via Palazzuolo (degrado cronico con spacciatori di crack, risse quotidiane e spostamento del problema verso altre zone) e la Stazione Santa Maria Novella (furti seriali da “pickpockets”, spaccio in pieno giorno e risse tra tossici) dominano le agende perché colpiscono il turismo e l’immagine della città Unesco. Altre realtà altrettanto gravi – come il degrado silenzioso a Novoli o le baby-gang a San Jacopino – vengono tralasciate, in un gioco di priorità che privilegia il “vetrina” al tessuto sociale.
Intanto la Prefettura celebra un calo nei primi nove mesi del 2025: -10,86% nel centro storico, fino a -46,09% a Rifredi. Ma è un dato fuorviante: molti fiorentini hanno smesso di denunciare, stufi di code in questura e di indagini evanescenti. Il “sommerso” cresce, la percezione di insicurezza pure – un sondaggio Ecoló indica che il 68% si sente minacciato dal degrado urbano.
- Una sottovalutazione durata decenni: l’accoglienza come alibi per l’immobilismo
Per anni sindaci, assessori, intellettuali toscani hanno negato il nesso tra immigrazione irregolare e criminalità, tacciando di razzismo chi lo denunciava. La “tradizione regionale dell’accoglienza” – radicata in un umanesimo progressista – si è trasformata in comodità politica: flussi non gestiti, cooperative intoccabili, degrado normalizzato. Chi arriva senza regole resta invisibile, ma non innocuo: finisce a rubare per fame o a spacciare per sopravvivenza. Le cooperative, con i loro CAS fatiscenti, hanno lucrato miliardi senza accountability – fughe, abusi, zero follow-up. Il fenomeno è stato sottovalutato per decenni, come un “male necessario” per non sporcare l’immagine di Firenze solidale. Oggi, con 11.051 furti con destrezza (record storico e prima in Italia) e 765 rapine in pubblica via (seconda solo a Roma), il conto è salato: una città divisa tra bellezza e barbarie.
Non bastano assunzioni simboliche o COSP di facciata: servono azioni concrete, non conferenze stampa.
Serve una formazione seria per vigili e operatori sociali, capace di affrontare davvero devianza giovanile e integrazione.
Serve un’unità antidegrado potenziata, con almeno 300 agenti dedicati, non appena 90 per un’intera città.
Serve un riequilibrio delle priorità nei COSP, che non guardi solo al turismo, ma anche alle periferie e al disagio reale.
Serve chiudere i rubinetti dell’accoglienza indiscriminata, sostituendola con quote controllate e percorsi obbligatori di inserimento.
Serve un controllo rigoroso sulle cooperative, con audit annuali e revoche per inefficienza.
E servono espulsioni effettive per chi delinque, senza più alibi umanitari.
Altrimenti, la città più bella del mondo continuerà a essere anche una delle più insicure.
E il Rinascimento resterà solo un ricordo sbiadito sulle cartoline, cancellato dal bagliore di una pipetta di crack.