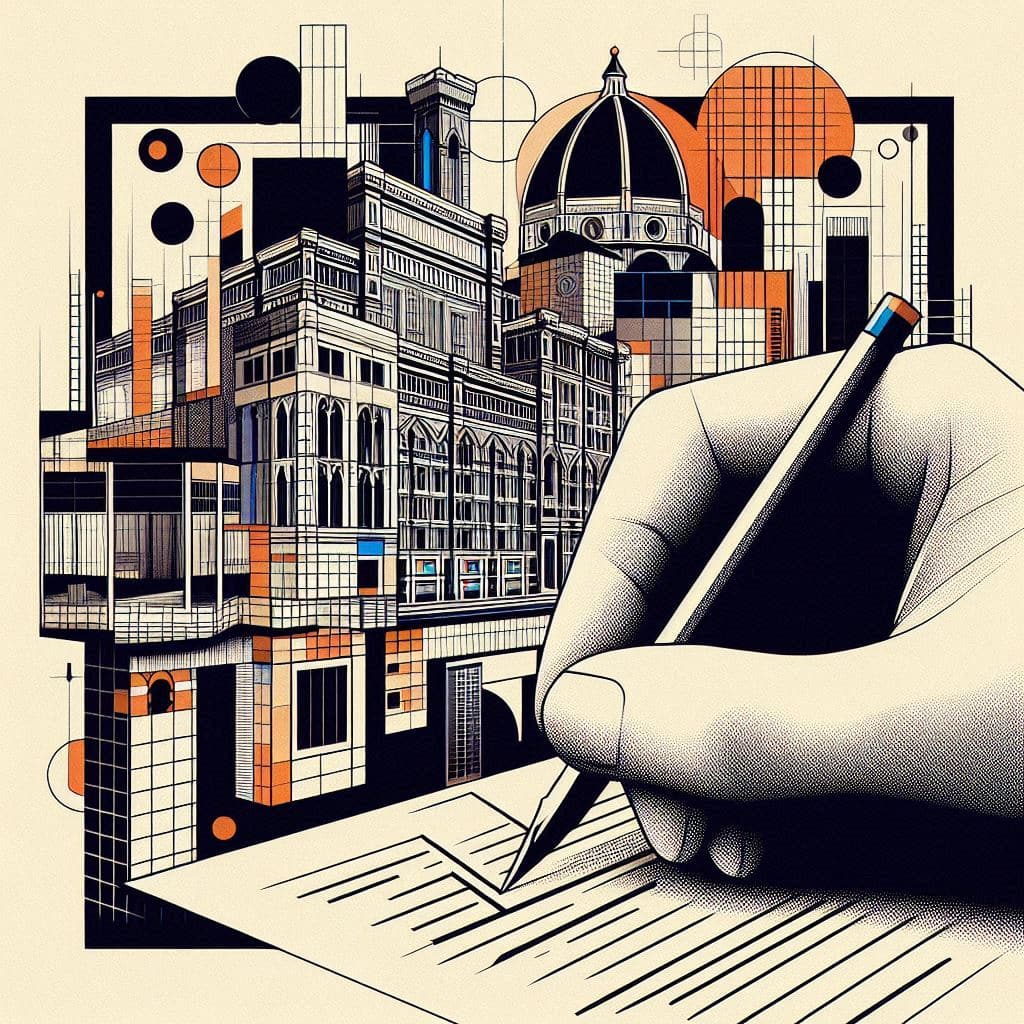Di Romana Bergamaschi
Solo dopo 40 anni dalla fine della II guerra mondiale si è iniziato a far conoscere la verità sui 600.000 militari italiani internati nei campi di concentramento per essersi rifiutati di giurare per il Führer e, pur essendo perfettamente consapevoli di quello che avrebbero dovuto affrontare, consegnatisi volontariamente ai tedeschi. Tale atto di coraggio fu dovuto al loro senso del dovere sia come uomini, sia come italiani pronti a resistete e a lottare per la libertà del loro paese. Di quei 600.000 mila ne morirono più di 40.000, e il loro sacrificio è stato prima ignorato e poi, con il tempo, cancellato del tutto.
Non posso fare a meno di pensare che questo sia stato reso possibile grazie a un disegno strategico voluto dai vari governi per rimuovere qualsiasi altra forma di resistenza che non fosse solo e soltanto “la loro”. È inaccettabile che un paese non onori i propri morti. Del resto lo hanno fatto anche con i caduti della prima guerra mondiale, quando hanno trasformato il 4 novembre nella festa delle Forze Armate: tutti gli anni si recano in pompa magna a deporre una corona sulla tomba del Milite Ignoto, forse per mettere a tacere la loro coscienza – io parlerei piuttosto dei Militi Ignorati.
Anno dopo anno le celebrazioni del 25 aprile si sono trasformate in una specie di festa privata come se la liberazione fosse avvenuta solo ad opera loro e, ancor più grave, hanno privato i 600.000 militari italiani internati nei campi di concentramento tedeschi del diritto di essere ricordati. Nel 1984 è stato pubblicato il libro ” Resistenza senza armi”, grazie anche al prezioso contributo di Giovanni Spadolini. Il libro raccoglie ricordi e testimonianze preziose degli internati toscani- Tra questi ci fu mio padre, milanese di nascita ma fiorentino di adozione.
L’introduzione sottolinea gli sforzi e le difficoltà sostenute perché le parole di quei soldati fossero conosciute, e spiega come sia importante divulgarle anche nelle scuole come lezione di vita, di verità storica e di esempio per le generazioni future. Mio padre me lo regalò con una dedica che ha formato ma mia coscienza di donna e di cittadina: “C’ero anch’io, perché speravo ,e spero, che certe cose non accadano più”. L’insegnamento che ho tratto dalla lettura è la consapevolezza che, per quanto le situazioni siano difficili, ognuno di noi deve operare ed agire per quelli che è giusto e che la parola dovere implica che le nostre azioni debbano essere improntate alla lealtà, alla coerenza delle nostre idee e all’ onestà intellettuale che ne consegue.
Ho deciso di cominciare dalla testimonianza di mio padre Renato Bergamaschi, che racconta la stato d’animo e la difficile scelta all’indomani dell’ 8 settembre 1943. Il governo Badoglio non aveva comunicato a nessun reparto militare l’avvenuto armistizio, abbandonano così tutti al loro destino. A quel tempo mio padre si trovava in Francia, in Provenza. Quando venne annunciato l’armistizio in lingua italiana, tutti si guardarono sgomenti. Poi verso le 10 del mattino vennero circondati dai tedeschi che intimarono loro di deporre le armi. Alle 18 si presentò il comando tedesco per presentare 3 domande: 1- Volte combattere con il grande Reich? 2- Volete collaborare con il grande Reich? 3- Qual’è la vostra risposta? La risposta NO alla terza domanda doveva intendersi come prigionia.
Riporto qui le sue parole esatte: “Tralascio le considerazioni sull’assurdità delle prime due domande, che solamente la mancanza di acume politico e psicologico tedesco aveva potuto concepire. Solamente la terza soluzione ci avrebbe dato la certezza di sentirci dignitosamente uomini ed ancora soldati, virtualmente legati dal giuramento alla patria, forse impotenti, ma preparati a subire e pronti a sopportare qualsiasi evenienza il futuro mandasse. Un atto di sfida al destino e di resistenza al nuovo nemico, passiva, ancora indefinita, ma certa.”
Testimonianze e memorie si susseguono nei ricordi: la resistenza dei martiri di Cefalonia, dove morirono 9.709 militari di cui 4.678 catturati e trucidati dai tedeschi. Alcuni hanno rievocato il lungo viaggio stipati nei vagoni merce o in quelli per animali, spesso senza cibo e con poca acqua per arrivare nel lager. Il sacrificio di Armando Frigo, giocatore della Fiorentina fucilato appena catturato. Le testimonianze continuano nei racconti della vita ( se così possiamo definirla ) nei campi di concentramento: il duro lavoro nelle miniere o nelle fabbriche, la fame e gli stenti, i continui tentativi per costringere i militari italiani a giurare per il Führer; il freddo, le sevizie crudeli come quella di Pietro Rossi punito con acido gettato nelle sue parti intime per non aver risposto alle domande formulate in tedesco, lingua a lui sconosciuta. Per finire, la testimonianza di chi ha assistito alla fucilazione di un giovane soldato che si rifiutò di aprire la mano dove teneva nascosto un torsolo di mela raccolto per terra, spinto dalla fame.
Voglio concludere con le parole del Sen. Prof. Paride Piasenti, Presidente nazionale dell’ A.N.E.I. (Associazione Nazionale Ex Internati): “Ciò che rimane nel tempo, al di sopra di qualsiasi interpretazione della storia, è il valore sommo della libertà e della dignità umana. E davvero fragile tornerebbe ad essere il popolo italiano, il giorno in cui ne perdesse memoria”.
Foto: Bundesarchiv, Bild 183-J30385 / Schwahn / CC-BY-SA 3.0. Campo di internamento per militari italiani catturati dai tedeschi dopo l’Armistizio dell’8 settembre 1943. Foto di propaganda di guerra nazista proveniente dal Deutsches Bundesarchiv, firmata “Schwahn”.