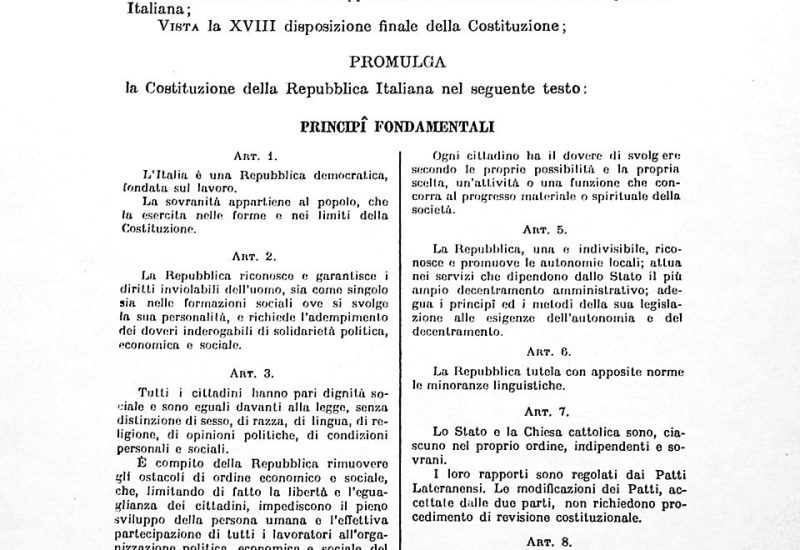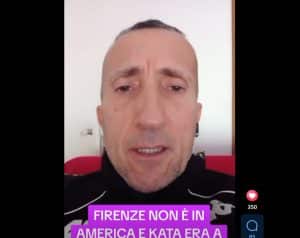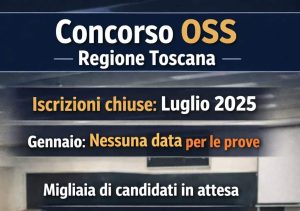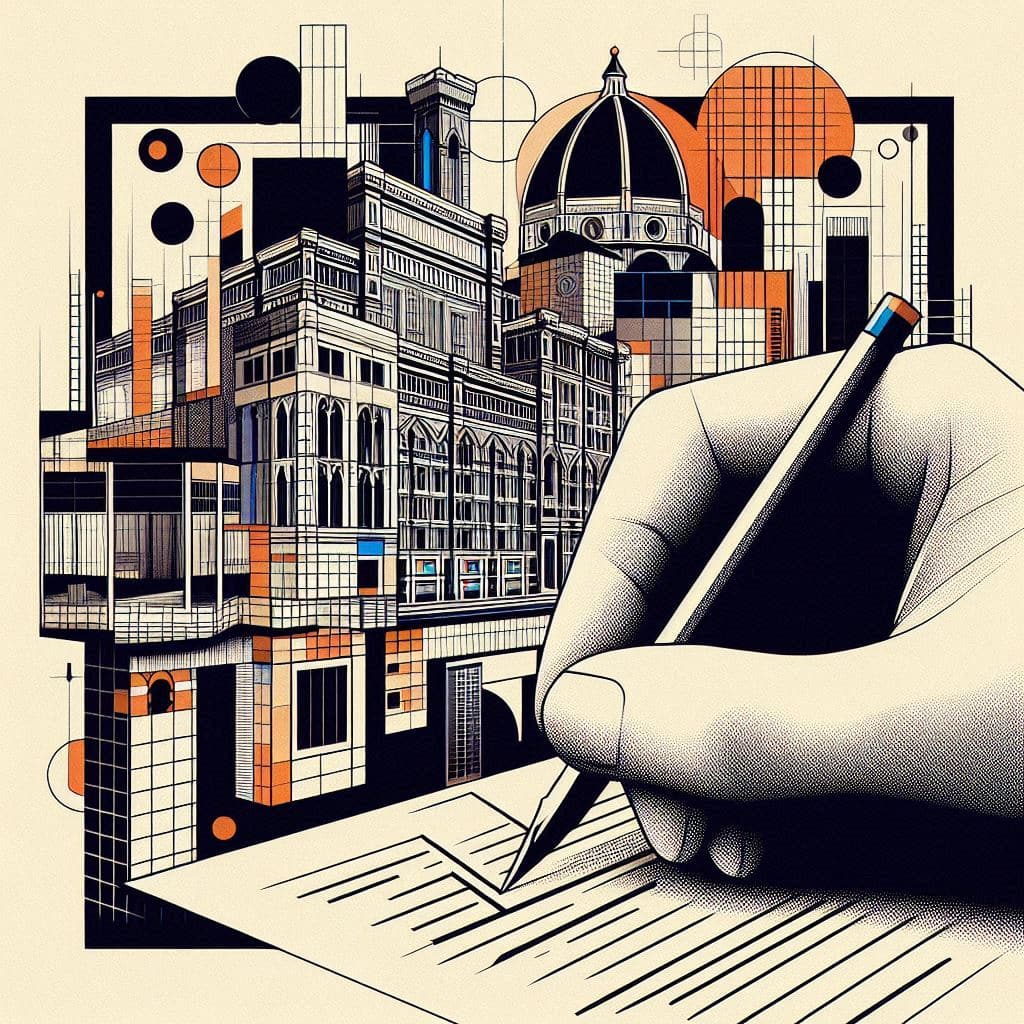di Michele Sanfilippo
Il rapporto fra la Costituzione e la Città. In questi miei articoli vorrei esplorare tale nesso e vedere lo stato dell’arte. Questa ricerca ha un simbolismo elevatissimo, perché proprio a Firenze, dal 22 al 28 ottobre del 1945, si tenne la XIX edizione della Settimana Sociale dei Cattolici d’Italia sul tema «Costituzione e Costituente», con insigni relatori, sia istituzionali, Alcide De Gasperi e Mario Scelba, o futuri padri della Costituente quali Giuseppe Lazzati, Amintore Fanfani e i legatissimi (all’epoca) Giuseppe Dossetti e Giorgio La Pira, Egidio Tosato nonché il laico Meuccio Ruini e figure di spicco del mondo politico quali Guido Gonella. Oltre ai politici ed alla presenza di ecclesiastici quali il Cardinale Elia Dalla Costa ed il Vescovo di Bergamo Adriano Bernaggi, uno dei fautori del dibattito sui rapporti fra il Vaticano e la nuova società italiana (dal quale scaturì la formulazione dell’art.7 della Costituzione) e la firma più autorevole della Civiltà Cattolica (di cui fu redattore per ben quarantasei anni) Padre Antonio Messineo. Oltre a questi personaggi, vi era anche un giovanissimo Ettore Bernabei. Nonché figure del livello di Antonio Amorth, giurista allievo della scuola Patavina o Camillo Corsanego che aveva la doppia laurea sia in Diritto Canonico che in Scienze economiche, che insieme Angelo Raffaele Jervolino aveva combattuto per l’autonomia e l’indipendenza della Gioventù cattolica contro il regime fascista che mal tollerava le associazioni non di promanazione diretta, Ferruccio Pergolesi studioso del diritto del lavoro e poi docente a Bologna di Diritto costituzionale.
Senza sminuire il ruolo e la funzione del Codice di Camaldoli, che fu un primo incontro, promosso da Giovanni Battista Montini, ma ad alta valenza etica, si può dire che le linee di fondo del dibattito alla Costituente furono redatte proprio nella settimana fiorentina.
Tralascio l’emozione che provai, quando, nel lontano 1995, nel riordinare il Fondo librario di Santi Romano, che per percorsi strani era stato donato alla Diocesi di Fiesole, mi imbattei nel volumetto della ICAS (con la copertina rossa) che riportava gli atti del convegno. Ricordo ancora l’emozione di Ettore Bernabei (quale tuffo nella memoria, perché vi partecipò quale redattore del Il Popolo) quando gli parlai della mia tesi di laurea (relatore Ugo De Siervo) che innovava, polemicamente, la vulgata del ruolo fondativo della Carta di Camaldoli, che degradai ad una funzione etica (una sorta di sermone), ma priva di quelle indicazioni precise e puntuali che emersero nel consesso fiorentino, che effettivamente dettò la linea da tenersi alla Costituente, in particolare contro una visione (all’epoca definita “Roussoviana”) di democrazia diretta e populistica, rappresentata dal monocameralismo e da un “sovranismo” (sovranità popolare) illimitato (senza un controllo giurisdizionale delle leggi/atti normativi). Qualche domanda ci si pone sull’idea attuale di elezione diretta del Sindaco, di Sindaco Manager della Governance locale, dell’assetto fra Giunta e Consiglio comunale, sul rapporto fra le fonti interne al Comune.
Poco dopo trovai, un opuscoletto di Carlo Arturo Jemolo che spiegava che cosa era la Costituzione.
Quello che più colpiva, nel leggere quelle pagine, era la semplicità del linguaggio. Lo sforzo degli autori, tutti, sia lo Jemolo, ma anche i relatori della Settimana Sociale, volevano farsi capire e farsi comprendere da tutti e per questo si sforzavano di utilizzare un lessico comprensibile.
Significativo questo sforzo, dove si genera un circuito virtuoso fra linguaggio comprensibile e ricerca di dare un fondamento al nuovo ordine giuridico. Un ordine giuridico che parte dal basso, dall’uomo semplice, perché la Costituzione appartiene anche all’uomo semplice, anzi, verrebbe da dire, a leggere le pagine di La Pira e di Fanfani, a partire dall’uomo semplice che si trova in posizione di debolezza ed è più svantaggiato.
Da queste considerazioni si comprende che la Costituzione si vive nella quotidianità e la quotidianità si realizza nelle realtà locali.
A questo proposito è emblematico ciò che avvenne nella Firenze del 1956 dove Piero Calamandrei si candidò a sindaco, con l’appoggio del Partito Socialista Italiano (PSI), assieme al movimento Unità Popolare in alternativa all’uscente Giorgio La Pira. Uso il termine in alternativa e non “In contrapposizione” perché e lo vedremo dagli eventi, vi era una comunanza, nonostante le profonde diversità fra il “Sindaco santo” ed il rigoroso azionista laico Piero Calamandrei e più che altro un rispetto profondo, non solo fra esponenti politici, ma anche fra colleghi della stessa Università e facoltà.
Alle elezioni amministrative del 27 maggio 1956 Calamandrei fu eletto consigliere comunale e dopo l’insediamento del consiglio, il 31 luglio, fece seguito la votazione per la nomina del Sindaco, che all’epoca avveniva all’interno del consiglio comunale. Calamandrei ottenne 28 voti mentre Giorgio La Pira ne ottenne, Sindaco uscente, solo 24, risultando sconfitto, ma durante la seduta del 3 agosto 1956, Calamandrei rinunciò alla carica di sindaco, spiegando di non sentirsi in grado per via degli impegni accademici e professionali, dell’età e delle condizioni di salute, dimostrando la grande stima nei confronti di Giorgio La Pira che espresse palesemente alla seduta della costituente (quella per intendersi sul preambolo): «Non sono in dissidio col collega ed amico La Pira» disse, perché vi era fra loro, pur nella profonda diversità fra visione laica e di sinistra e la posizione cattolica dell’esponente democristiano, una convergenza sull’idea di sacralità della Carta Costituzionale, un richiamo al “sacro”, o come lo definiva Calamandrei, allo “Spirito”, riconoscendo un valore morale e spirituale nel loro lavoro.
Questo “Spirito” doveva innervare le Città, perché nelle Città, cioè nella vita quotidiana si realizzava ed implementava (diremmo oggi) la Costituzione. Per questo motivo due dei più importanti “Padri” della Costituzione, decisero di candidarsi in Consiglio Comunale e poi a Sindaco.
Ritengo che nell’ottantesimo dalla fine della Guerra, ma, a maggior ragione, di quel convegno del 22-28 ottobre 1945 ci si debba interrogare sulla attuazione della Costituzione e verificare lo stato dell’arte, perché la Costituzione è “Cosa viva” che innerva (o dovrebbe innervare) la realtà, se ciò non avviene significa che vi è stato un cambio di regime. Detta verifica, poi, probabilmente diviene foriera di dibattito politico, circostanza questa di cui abbiamo un profondo bisogno.
Un ulteriore insegnamento, possiamo trarre, dalla vicenda Calamandrei/La Pira, che si sentivano in alternativa, ma non in contrapposizione, ovvero fra loro vi era dialogo, stima, mentre oggi si assiste all’innalzamento delle barriere, in una dinamica, amico-nemico, foriera, dagli insegnamenti del giurista Carl Schimit, dei totalitarismi.
Certo, mi rendo conto che parlare di Città e Costituzione nella Firenze irrispettosa della gerarchia delle fonti come rimarcato dalla nuova sentenza del Consiglio di Stato (la n. 2928/2025) in materia di affitti brevi e turistici, risulta atto quasi rivoluzionario, ma appunto nella Costituzione vi è una implicita funzione rivoluzionaria.