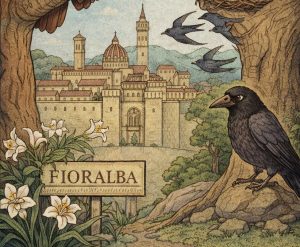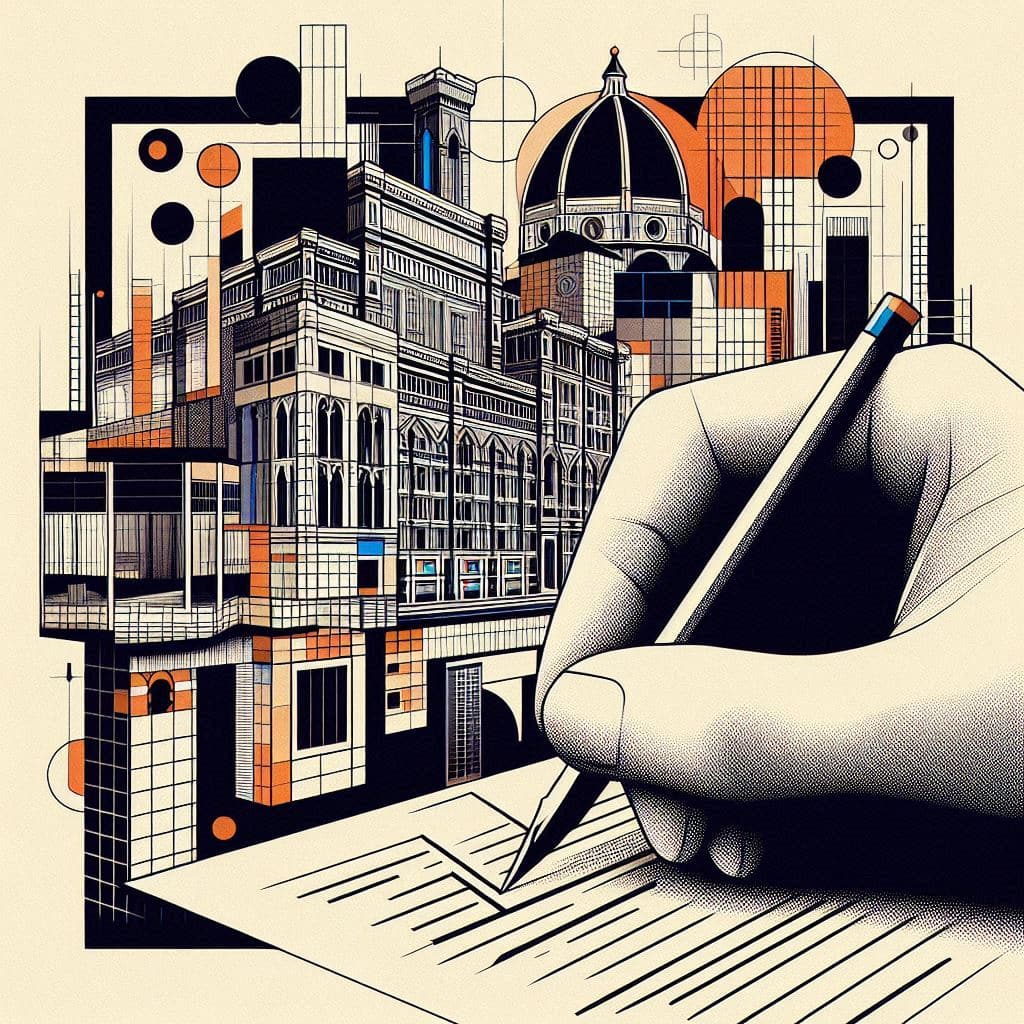Di Michele Sanfilippo
Era il 1972 quando Giorgio Gaber pubblicò la canzone La Libertà con il verso finale “Libertà è partecipazione”. Da allora è diventato l’emblema della sinistra, la sinistra post-sessantottina. La mia esperienza, anche politica, mi ha insegnato che quando un “sinistro” (denominazione prettamente ironica) è in difficoltà o non sa cosa dire, tira fuori il tema della partecipazione.
Il tema della partecipazione, invece, deve essere vagliato per bene, perché è uno degli elementi cardine di un sistema democratico. In primo luogo si deve individuare gli utenti: chi partecipa? In base ai partecipanti la dinamica definisce i propri connotati. Se i partecipanti, fossero i soggetti di Sinistra al caviale o i maggiorenti di destra, la dinamica sarebbe di una democrazia plutocratica.
Se i partecipanti fossero soggetti mobilitati, la dinamica sarebbe di tipo plebiscitario. Così come se il quesito partecipativo fosse di natura troppo tecnica o specialistica, la risposta potrebbe essere di tipo tecnocratico. Insomma, i partecipanti definiscono il tipo di Popolo/Demos. La partecipazione è lo snodo che congiunge il popolo (nelle sue variegate tipologie) e l’esercizio del potere (il Kratos). Ho fatto solo degli esempi, ma le modalità di partecipazione condizionano il tipo di democrazia, fino a declinare in Autocrazia, Oligarchia e Demagogia (o democrazia degenerata). Chi e come partecipa diviene, quindi, l’elemento centrale della dinamica politica. Per questo motivo vengono poste delle regole a disciplinare le modalità della partecipazione. Meno regole sussistono o più la questione posta al vaglio partecipativo è vaga, maggiori sono le possibilità che il processo decisionale degeneri.
Ci tengo ad evidenziare: “Il processo decisionale”; perché puntualizzo? Semplicemente, perché siamo educati ad una analisi di sistema, per cui si dice che quel determinato paese non è democratico, talaltro…. Invece, prima di arrivare ad una situazione di sistema, vi sono una serie di congerie di decisioni che vengono prese sulla base di modalità democratiche o demagogiche o a favore dei pochi o condotte dai pochi sui molti. Il dilemma di Abraham Lincoln, nel celebre discorso di Gettysburg (1863) che la democrazia è “un governo del popolo, dal popolo, per il popolo” ed aggiungerei anche “con il popolo”, impone di stabilire regole predeterminate, volte ad impedire che la decisione degeneri.
La soluzione preferibile è la formazione di persone, selezionate “Dal popolo”, che possano studiare le questioni e le possano dibattere fra loro, per addivenire ad una decisione che accontenti, se non tutti, almeno la maggioranza. Questa è la democrazia rappresentativa. Attraverso una corretta comunicazione ed un rapporto stretto fra il rappresentato ed il rappresentante, potremmo arrivare al virtuosismo di un “Governo con il popolo” (oltre al del, dal, per). Tutti noi abbiamo esempi di partecipazione nel momento elettorale, dove il candidato, fra poco è il nostro migliore amico (che viene perfino alle feste di compleanno e/o si fa chiamare “papi”), ma una volta eletto per volere divino diviene un sapiente che non ha bisogno di alcun confronto. Ricordo, ad esempio, un giovane parlamentare del Movimento 5 stelle che mi chiese aiuto e gli diedi perfino spunti per il suo programma elettorale, una volta eletto gli mandai un messaggio su WhatsApp e mi vidi rispondere, “questo cellulare è un cellulare di servizio” … non disturbare il manovratore. In questa ottica la democrazia rappresentativa, come diceva Rousseau, si esercita solo al momento del voto. Parafrasando una celebre frase di Giuliano Amato, “ad un singolare abbiamo sostituito un plurale”, ma la sostanza cambia poco.
La partecipazione si esplica all’interno di un dibattito pubblico o meglio nella sfera pubblica. La qualità della sfera pubblica condiziona la decisione politica finale e, quindi, la tipologia di decisione e poi di sistema politico (Democratico, demagogico, tecnocratico, plutocratico…). Il filosofo tedesco Jürgen Habermas ci mette in guardia dalla “sfera pubblica” decadente che è caratterizzata da una partecipazione passiva, influenzata dai media; da una Comunicazione di tipo pubblicitario e propagandistico, con il deliberato obiettivo di manipolare il dibattito. Le virtù della democrazia rappresentativa, di converso, sarebbero caratterizzate da un dibattito/partecipazione attiva, critica, razionale, con una comunicazione incentrata sul dialogo e formulata per argomentazione, con lo scopo di ricercare il bene comune o (almeno) l’utilità per la maggioranza.
Per ovviare a potenziali decisioni non autenticamente democratiche, in molti contesti sono previsti strumenti di “Democrazia diretta”, il più conosciuto dei quali è il referendum, che può essere Abrogativo (come avviene livello statale), Approvativo (precedente alla decisione finale, come avviene in alcuni Cantoni della Svizzera ed in Italia ed Irlanda in tema di riforme costituzionali), oppure Facoltativo (come avviene in alcuni Cantoni svizzeri) che si tiene solo se richiesto da una certa parte della popolazione o da enti istituzionali (nel caso della nostra revisione Costituzionale, quando è richiesto dalle Regioni o dal Popolo – quindi il referendum costituzionale è sia approvativo che facoltativo) ed infine Consultivo, che però non è vincolante.
É fuori di dubbio che il referendum rappresenti l’espressione massima di partecipazione, ma è altresì vero che molto facilmente fornisca esempi per forme di “sfera pubblica declinante” con il rischio di finire in una democrazia demagogica e plebiscitaria, specie se non si stabilisco precise regole sulla partecipazione (in particolare i quorum partecipativi e deliberativi) e sui quesiti che potrebbero avere caratteri manipolatori o (molto spesso) plebiscitari.
Oltre a questo difetto, i referendum costano (e parecchio) e creano (paradossalmente) disaffezione, perché un eccesso di referendum (la referendite) comporta per l’elettore uno sforzo di riflessione per tematiche che allo stesso può essere che non interessi. E si, il diritto al voto implica anche il diritto a disinteressarsi, perché diversamente il regime politico declinerebbe in forme di totalitarismo. La “Referendite” è sintomo di una visione totalitaria della politica e di una ricerca plebiscitaria del consenso. La “Referendite”, a ben vedere, forma istituzionalizzata della “Sondaggite”, sostituisce le adunanze plenarie del Sabato Fascista.
Il tema della partecipazione, specie a livello locale, può essere affrontato diversamente. Un modello ci viene dal sistema statunitense che prevede il crearsi di contrapposizioni. Quindi la partecipazione si realizza nel confronto contrapposta fra favorevoli e contrari. Questa contrapposizione avviene (tendenzialmente) nelle aule giudiziari, all’interno delle procedure processuali ben determinate e predeterminate. Questo è il modello denominato dell’adversarial legalism, teorizzato da Robert A. Kagan, incentrato sul ricorso al contenzioso giudiziario come strumento di regolazione e di attuazione forzata delle norme.
La causa, pensiamo alle class actions, diviene, quindi, strumento indiretto di partecipazione ed, aggiungerei, successivo alla deliberazione. L’adversarial legalism ha il pregio di un controllo dal basso sulle istituzioni e un’elevata reattività del sistema legale a istanze sociali emergenti, ma ha il difetto (fra i più) di allungare eccessivamente i tempi della decisione politica che finisce per essere subordinata alle tempistiche giudiziarie.
Questo modello è l’opposto rispetto al cosiddetto legalismo burocratico, diffuso nei Paesi dell’Europa continentale, in cui il rispetto delle norme è garantito principalmente da apparati amministrativi tecnici e centralizzati, e la partecipazione civica si esplica più spesso tramite canali istituzionali e rappresentativi. Il legalismo burocratico garantisce maggiore coerenza e prevedibilità, ma spesso a scapito della possibilità, per i cittadini, di incidere direttamente sui processi decisionali.
Il confronto tra i due modelli evidenzia dunque una tensione strutturale tra efficienza amministrativa e partecipazione democratica diretta. Funziona bene in contesti di presenza di Organizzazioni non governative e di Gruppi di interesse ben determinati e coalizzati. Il pregio di detto sistema è che si impone alle amministrazioni un atteggiamento di grande cautela nella formulazione delle politiche pubbliche, che devono essere giuridicamente ineccepibili per evitare ricorsi che potrebbero bloccarle o modificarle profondamente; il che, però, comporta una logica difensiva e paralizzante, limitando l’innovazione e scoraggiando decisioni coraggiose ma necessarie. Ulteriore difetto è che le cause costano e, quindi, detto modello potrebbe produrre diseguaglianza. Comunque detto modello negli USA è stato utile per la tutela dei diritti civili, nella difesa dell’ambiente e nella trasparenza amministrativa, specialmente a livello locale, perché attraverso il ricorso ai tribunali, molti gruppi marginalizzati o minoritari hanno ottenuto visibilità e riconoscimento, forzando le amministrazioni a tener conto delle loro istanze.
Con questo modello il sistema giuridico si configura non solo come uno spazio di risoluzione dei conflitti, ma anche come strumento di partecipazione, costituendo uno dei principali strumenti attraverso cui la società civile può esercitare un controllo attivo sulle istituzioni locali.
Questo modello è risultato estremamente utile in tema di urbanistica e tutela dell’ambiente, in particolare in due casi emblematici: i progetti edilizi e di gentrificazione (nel 2017) dovuta alla forte espansione immobiliare di Downtown Los Angeles che ha portato alla creazione di Associazioni come L.A CAN (Los Angeles Community Action Network) ed al caso dell’ampliamento del Porto di Los Angeles, determinato, all’inizio degli anni 2000, dallo sviluppo del terminal container China Shipping.
Detta struttura “Avversoriale”, in realtà, potrebbe svilupparsi a fianco del modello del cosiddetto Legalismo Burocratico, tipo dei sistemi eurocontinentali, basti ampliare il concetto di portatori di interesse. L’esperienza in tale senso è stata emblematica, pur in negativo, nella vicenda del Mercato Centrale che ha visto la partecipazione di comitati ed associazioni azionatisi per la difesa dello storico mercato, quale Bene culturale immateriale. L’esito non è stato dei più edificanti, per il prevalere di un modello culturale della giustizia amministrativa che pare ben lontana da ciò che diceva ed auspicava l’ideatore della riforma della Giustizia Amministrativa, Mario Nigro “giudicare sull’azione amministrativa significa amministrare”, giacché spesso si assiste ad un eccesso di formalismo rispetto all’elemento sostanziale.
Diversamente in Francia, esiste uno strumento, l’’enquête publique (l’inchiesta pubblica); è una procedura di partecipazione pubblica prevista nel diritto amministrativo francese, obbligatoria in determinati progetti di interesse pubblico (es. infrastrutture, opere urbanistiche, ambientali) ed ha lo scopo di informare i cittadini su un progetto che può avere impatto sull’ambiente, l’urbanistica o la vita locale, di raccogliere osservazioni, pareri, obiezioni da parte del pubblico e Garantire trasparenza e legalità dell’azione amministrativa. La procedura prevede la nomina di un commissario inchiestatore (commissaire enquêteur), la Pubblicazione dell’avviso di inchiesta, una fa ase di consultazione (documenti pubblici, ricezione delle osservazioni), la relazione finale del commissario con parere motivato (favorable / défavorable), la decisione dell’autorità amministrativa (che può aderire o meno al parere, in caso di non accoglimento deve compiutamente e specificatamente motivare la propria decisione, che un domani potrà essere sucìscettibile di valutazione nelle sedi giudiziarie). Una siffatta procedura è estremamente formalizzata ed obbligatoria e si differisce, quindi, dalle nostre similari Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), Conferenze di servizi, Urbanistica Partecipata.
In una stagione dove vi è la proposta di (opinabili) referendum senza quorum, non vorrei che “la libertà è partecipazione” si trasformasse in una forma di dispotismo illuminato, che di illuminato non abbia altro che la presunzione degli amministratori, che una volta eletti si sentono i depositari di ogni verità.