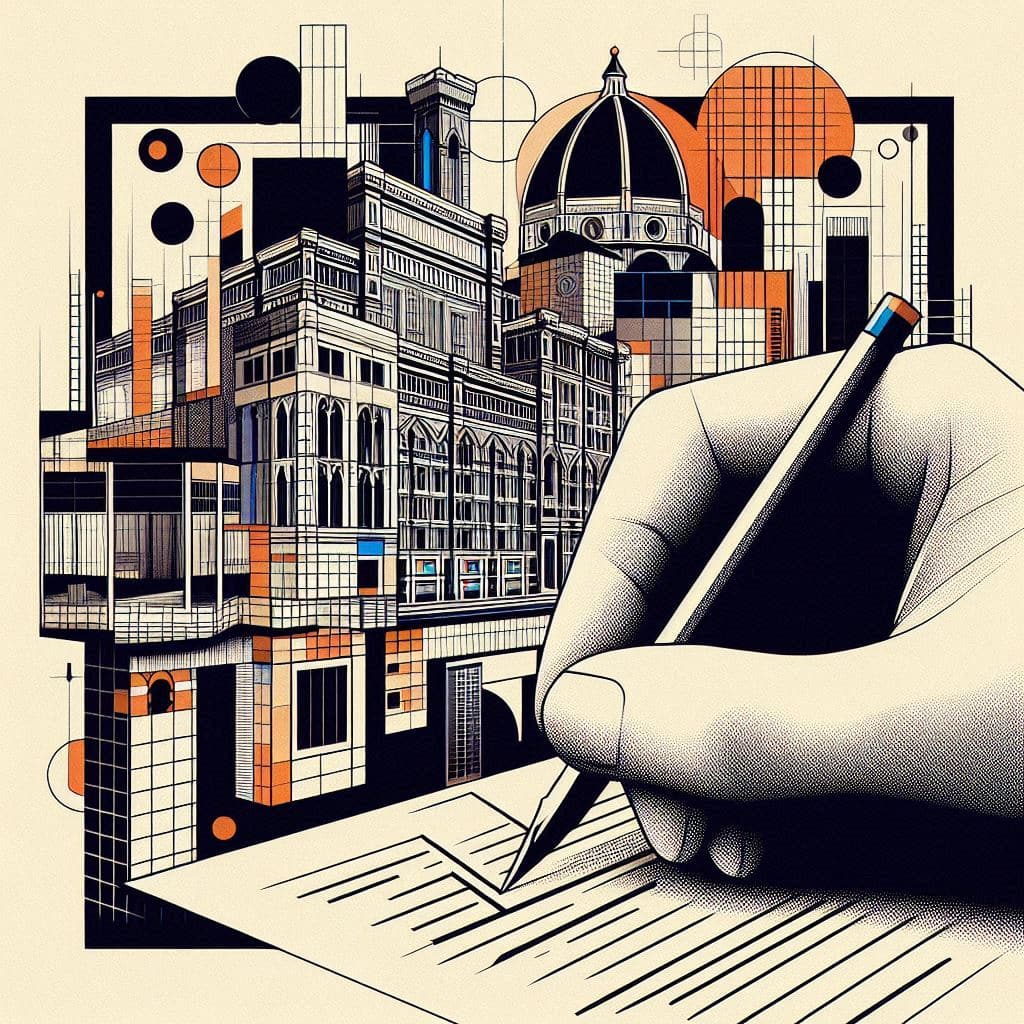di Michele Sanfilippo
Perché la democrazia? Perché gli strumenti della democrazia? Perché gli uomini nei secoli hanno deciso di dotarsi di una siffatta struttura?
Ebbene detti strumenti, che non sono affatto elucubrazioni teoriche, anche se ne hanno parlato per secoli filosofi, politici, rivoluzionari ed idealisti; sono, invece, il portato di esperienze dolorose, persone escluse, bistrattate, ignorate, abbandonate, definite reiette.
Dalla pietà alla partecipazione
A Firenze, dove è nata l’idea moderna di Repubblica, è la Firenze, che in piazza San Martino ha la sede della Confraternita dei Buonomini, voluta da quel santo grande e particolare che era Sant’Antonino Pierozzi, che istituì una apposita confraternita per quei patrizi che cadevano in disgrazia per i cambi repentini di potere. La pietà, ovvero il riconoscimento di quella dignità umana che è data da quella fiammella spirituale che fa vedere nell’altro, pur reietto, pur abbandonato, il volto del Cristo.
La Democrazia violenta
Quanto è distante la visione di Sant’Antonino, che permea la repubblica fiorentina, pensata e voluta dal Beato Savonarola, dall’istituto, della Antica Grecia, dell’Ostracismo, dove si costringeva qualcuno all’esilio dopo averlo privato di tutti i suoi beni! La Democrazia violenta è una ipotesi inscritta nell’animo umano. La democrazia che degenera. In fin dei conti, molte delle esperienze della storia nascono dall’idealità di qualcosa di migliore, anzi, le peggiori esperienze e nefandezze sono figlie di grandi (e presunte idealità). Forse aveva ragione Jean-Paul Sartre, quando diceva, in sintesi che “le rivoluzioni le pensano gli idealisti e le realizzano i malfattori”.
In ultima analisi, la democrazia, in tutte le sue forme, nasce come antidoto al dispotismo, prima e alla dittatura poi, specie nei tempi contemporanei.
Democrazia e giustizia
Come arginare la tendenza dispotica del governante di turno? Semplicemente attraverso regole che amplino i soggetti partecipanti alla decisione pubblica.
Ma perché questo ampliamento? Per una ricerca di giustizia.
La giustizia, nella definizione di San Tommaso d’Aquino (tratta da Ulpiano), si tratterebbe di “Dare a ciascuno il suo, proprio quello che gli spetta”. In questa definizione, quello che più rileva è la specificazione “proprio quello che gli spetta”.
In termini generali, si assiste ad un mutamento nei significati: Ulpiano con il significato di trattare le persone con equità e garantire che le leggi siano applicate in modo imparziale e, in termini economici e sociali distribuire equamente le risorse, dando opportunità o pene secondo equità, alla stessa stregua della visione distributiva di Aristotele (dare a ciascuno secondo merito o bisogno); San Tommaso che l’assurge a virtù cardinale, dove la Giustizia oltre che espressione della volontà razionale dell’uomo è il rispetto dell’ordine divino (qui ci rinvengo, personalmente una particolare similitudine con il concetto di ordine celeste del confucianesimo). In Kant, invece, è una attributo della ragion pratica e dell’autonomia morale. Infine, la visione di John Rawls verso la giustizia sociale e l’equità collettiva, che si può tradurre come equaglianza delle opportunità.
Per un altro aspetto ed è quello che maggiormente mi interessa per il presente ragionamento, è il collegamento fra il tema della Giustizia e la ricerca dell’armonia sociale che si ritrova ne La Repubblica di Platone.
Si perché l’ingiustizia crea disarmonia e disordine sociale. Gli esclusi creano, alla fine, il disordine che provoca una volontà di ribaltamento. Questo ribaltamento è dato dalla disperazione. Sant’Antonino attraverso la pietà cercava di arginare, il Beato Savonarola, con l’idea moderna di repubblica, cerca di convogliare nella partecipazione politica alle decisioni.
A livello storico e comparato, questa ricerca di convogliare le tensioni, al fine di evitare che sfocino in violenza e rabbia, porta ad una proceduralizzazione delle regole, in modo tale di consentire che le istanze dal basso siano portate al/ai detentore/i del potere politico.
Istituti di mediazione: dal Tribuno della Plebe al Difensore Civico
Nell’Antica Roma esisteva l’istituto del Tribuno della Plebe.
Nel mondo scandinavo vi è un istituto, l’ombudsman, la cui etimologia spiega tutto, perché deriva dallo svedese antico “umboðsmaðr”, che significa “colui che fa da tramite” o “delegato, rappresentante pubblico”. È composta da due elementi: “umboð” (delegazione, incarico) e “maðr” (uomo). In sostanza, l’ombudsman è una figura che agisce come intermediario o rappresentante, incaricata di ricevere e gestire reclami contro le istituzioni pubbliche o private che a me pare poco differire dallo Ius intercessionis attribuito ai Tribuni della Plebe copriva molte funzioni che ora sono pensate per il difensore civico.
Questa figura del Difensore Civico è prevista, anche, nell’ordinamento europeo, nella figura del Mediatore europeo, è stata introdotta in Italia dalla Legge sul riordino della amministrazioni locali nel 1990 (L. 142/1990).
Il ruolo sarebbe quello, come fu alla sua istituzione nella Svezia del 1809, di essere un patrocinatore di giustizia ed era un alto rappresentante (indipendente) del Parlamento, all’uopo eletto e delegato a raccogliere le istanze di giustizia provenienti da soggetti esterni al Parlamento medesimo.
Lascio stare la tendenza dei Comuni, compreso quello fiorentino, di limitare le funzioni del difensore civico a un soggetto titolato ad essere garante solo per alcuni diritti. Una siffatta soluzione è del tutto in contrasto con l’essenza dell’istituto che nasce per portare le istanze dal basso al potere politico.
Ricordo a tale proposito la famosa frase, simbolo del dispotismo illuminato, “Ci sarà pure un giudice a Berlino” che nasce dal caso del povero mugnaio, di nome Arnold, che si vede deviare da un Nobile (potere legittimo e costituito) l’acqua che alimenta il suo mulino, il potere, rappresentato dai giudici locali (asserviti) danno torto al mugnaio. A questo punto il povero Mugnaio arriva a rivolgersi a un giudice nella capitale, Berlino, che alla fine gli dà ragione.
Il sistema di portare le istanza di giustizia, fa parte integrante della ricerca del Buon andamento della pubblica amministrazione.
Ritengo, quindi, che il Difensore Civico debba essere ripristinato all’interno delle amministrazioni locali. Io, da sempre, ho proposto che lo stesso sia inserito all’interno dell’Ufficio di presidenza del Consiglio Comunale (addirittura io proporrei che la funzione fosse attribuita al Presidente) al fine di consentire al Consiglio Comunale di esperire quella funzione di controllo dell’operato amministrativo del Comune ed in specifico del Sindaco e della sua Giunta.
Si creerebbe un circuito virtuoso fra istanze dal basso e vaglio politico. Per questo motivo vedo non positivamente l’accentramento delle funzioni in capo ad un organo distante, quale il Difensore Civico Regionale, il quale, invece, deve svolgere paritetiche funzioni, ma nella propria sfera di competenza: l’attività della Regione.
Il nodo del controllo interno
Correlato al difensore civico, vi è poi un ulteriore soggetto che svolge le funzioni di controllo interno (dopo la soppressione del Coreco – Comitato Regionale di Controllo): il Segretario Comunale.
Sul punto non nascondo di essere un nostalgico del Segretario Comunale selezionato da un concorso e non dal perverso meccanismo della nomina da parte del Sindaco fra soggetti selezionati nell’apposito Albo. Non di rado si assiste da un asservimento di detti soggetti, spesso angariati da Sindaci supponenti e dispotici, che usano il ricatto della revoca (pur motivata, trascorso un biennio) o della Decadenza a fine mandato e la non rinomina. Questo meccanismo mina l’indipendenza del soggetto che svolge le funzioni di controllo interno.
Peggio che andare di notte se il Segretario Comunale viene nominato, addirittura, Direttore Generale. Qui si ha l’assurdo che colui che deve dare attuazione agli indirizzi del Sindaco e della sua Amministrazione, diviene controllore di se stesso!
Conclusione
Credo che prima di andare ad inventarsi strumenti di democrazia diretta e di partecipazione, si dovrebbe cercare di rispettare le minime regole di rispetto della legalità, del buon andamento, attraverso strumenti che consentano alla Pubblica Amministrazione di vagliare, con procedure preordinate, ipotesi di azioni correttive, compresa l’attivarsi in Autotutela, perché no? Anche in conseguenza di un dibattito che consenta un ripensamento.
Oggi a Firenze, mi pare si respiri un’aria di Dispotismo Amministrativo, più vicino al regime ed istituto del Podestà (nei poteri accentrati dello stesso e senza meccanismi – effettivi – di controllo legale e democratico).
In copertina: copyright Fotocronache Germogli