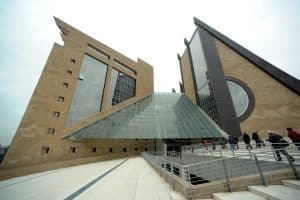Nei giorni in cui la cucina italiana (unica al mondo) diventava patrimonio dell’umanità la scuola italiana propone progetti interculturali calati dall’alto. Vassoi pieni di cibo buttato e una legge contro lo spreco ignorata. Il caso del Mugello mostra il fallimento di un sistema che predica inclusione e pratica rifiuti
Potremmo definirlo “il paradosso dell’Unesco”. Ebbene sì, un titolo giornalitsico ad effetto per sottolineare che, negli stessi giorni in cui la cucina italiana otteneva il riconoscimento Unesco come patrimonio mondiale immateriale dell’umanità – un primato unico al mondo – nelle scuole toscane e nello specifico mugellane, paradossalmente, si sceglieva di riempire i piatti delle future generazioni con cucine di altri Paesi, ribattezzando l’operazione con l’etichetta rassicurante di “Sapori per la Pace”.
Un’iniziativa presentata come progetto educativo e interculturale, ma che nella realtà si è rivelata un clamoroso fallimento, trasformandosi in uno dei più evidenti casi di spreco alimentare degli ultimi anni.
Il flop del Mugello
Il progetto, promosso dalla società che gestisce le mense della Piana fiorentina e del Mugello – celebre peraltro per criticità e segnalazioni sanitarie con alcuni bimbi addirittura finiti in ospedale per salmonellosi lo scorso anno – prevedeva nell’anno scolastico 2025/26 la proposta di piatti palestinesi, sudanesi e ucraini come strumento di riflessione su pace, inclusione e diversità culturale.
Il risultato è stato opposto.
Il caso più eclatante si è registrato a Barberino di Mugello con l’ 85,7% del primo piatto proposto buttato e addirittura il 93,75% del secondo piatto sprecato. Numeri senza precedenti!
L’11 dicembre 2025 agli studenti è stato servito un menù palestinese composto da: Mujadara (riso e lenticchie con cipolle caramellate), Hummus di ceci e cruditè di carote e finocchi
Dal punto di vista nutrizionale, nulla da eccepire: carboidrati, proteine vegetali, fibre e grassi “buoni” erano ben bilanciati.
Ma i vassoi sono tornati indietro quasi intatti.
Il falso mito: “ai ragazzi non piace l’etnico”
Di fronte al fallimento, la giustificazione è stata immediata: “i ragazzi non apprezzano il cibo etnico”. Un alibi comodo e falso.
Gli stessi studenti che rifiutano i piatti calati dall’alto nelle mense scolastiche affollano quotidianamente kebabberie, ristoranti giapponesi, locali street food e mangiano sushi, ramen, poke, tacos, falafel, etc… e lo fanno con entusiasmo.
Il problema, dunque, non è il cibo etnico. Il problema è come viene proposto.
Educazione mancata
L’educazione alimentare non si improvvisa. Non si costruisce con una giornata a tema e un comunicato stampa buono per buggerare chi ha gli occhi foderati di prosciutto.
Serve un percorso di avvicinamento fatto di preparazione, gradualità, coinvolgimento delle famiglie, narrazione culturale, lavoro nelle classi. Tutti elementi (ovviamente) completamente assenti nel progetto toscano.
Senza questo percorso, il rischio è evidente: trasformare un’idea potenzialmente valida in una strumentalizzazione scollegata dalla realtà scolastica. Ed è esattamente ciò che è accaduto.
Quando si faceva meglio
Eppure bastava guardare al passato dato che tentativi cultural-culinari fanno parte della nostra storia recente.
A Roma, già nei primi anni Duemila, il progetto “Ogni mese un Paese” aveva introdotto nelle scuole piatti stranieri accompagnandoli con materiali didattici, schede culturali e attività in classe. A Parma, iniziative simili sono state invece affiancate da laboratori, video-narrazioni e l’introduzione fatta da mediatori culturali.
Lì, il cibo era parte di un percorso educativo. Non una vetrina ideologica.
Il problema strutturale dello spreco
Il caso di Barberino è solo la punta dell’iceberg. Nelle mense scolastiche italiane: tra il 20% e il 30% del cibo viene sprecato, circa 90 grammi al giorno per studente finiscono nei rifiuti e pane, frutta e verdura sono gli alimenti più scartati
Ogni giorno vengono serviti circa 2 milioni di pasti, soprattutto a bambini tra i 3 e gli 11 anni.
Un sistema enorme, che dovrebbe essere un modello di sostenibilità e invece produce tonnellate di rifiuti.
La Legge Gadda: una norma ignorata
Dal 2016 esiste una legge nazionale contro lo spreco: la Legge Gadda (n.166/2016).
Una normativa avanzata che prevede: recupero delle eccedenze, donazioni alimentari, educazione al consumo responsabile e campagne di sensibilizzazione nelle scuole.
Sulla carta, un modello europeo ma nella pratica, una “legge fantasma”.
Nelle scuole non esiste un monitoraggio nazionale degli sprechi, non c’è obbligo di rendicontazione, i bandi al ribasso penalizzano la qualità alla faccia anche della salute dei bambini, l’educazione alimentare è spesso assente e la donazione delle eccedenze è rarissima.
Il risultato? Basta andare a vedere nel primo pomeriggio nei cassonetti vicino ai plessi scolastici pieni di cibo.
Ideologia al posto del buon senso
Troppo spesso i menù “interculturali” sembrano operazioni simboliche, più utili a costruire una narrazione politica che a educare davvero.
Piatti estranei ai gusti dei bambini, nessun lavoro preventivo, nessuna gradualità. Il risultato è sempre lo stesso: rifiuto, spreco, polemiche e poi si scarica la colpa sugli studenti.
Questa non è educazione è improvvisazione. È strumentalizzazione.
Il vero nodo: rispetto per il cibo
La Legge Gadda parla di prevenzione dello spreco, non di operazioni vetrina.
Parla di responsabilità pubblica, non di iniziative episodiche. Parla di cultura del cibo, non di propaganda.
Se davvero si vuole ridurre lo spreco, la scuola deve smettere di usare il pranzo come strumento ideologico e iniziare a considerarlo per ciò che è: un patrimonio educativo, culturale ed economico.
Altrimenti continueremo a buttare via tonnellate di pasti, milioni di euro e, soprattutto, un’occasione preziosa per formare cittadini consapevoli. E nessuna legge, per quanto buona, potrà salvarci dall’ipocrisia.
Riscoprire anche la cucina italiana
Infine, un’ultima domanda: perché non valorizzare seriamente anche la cucina tradizionale italiana, l’unica al mondo riconosciuta dall’Unesco come patrimonio dell’umanità?
Perché non costruire percorsi mirati sulle tradizioni regionali, sui prodotti locali, sulla filiera corta, sul chilometro zero?
Sarebbe educazione vera e sostenibilità concreta.
Sarebbe identità. E forse, questa volta, non finirebbe nella spazzatura.