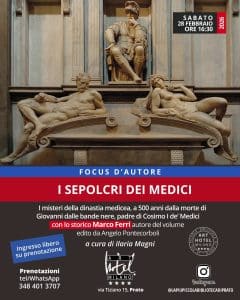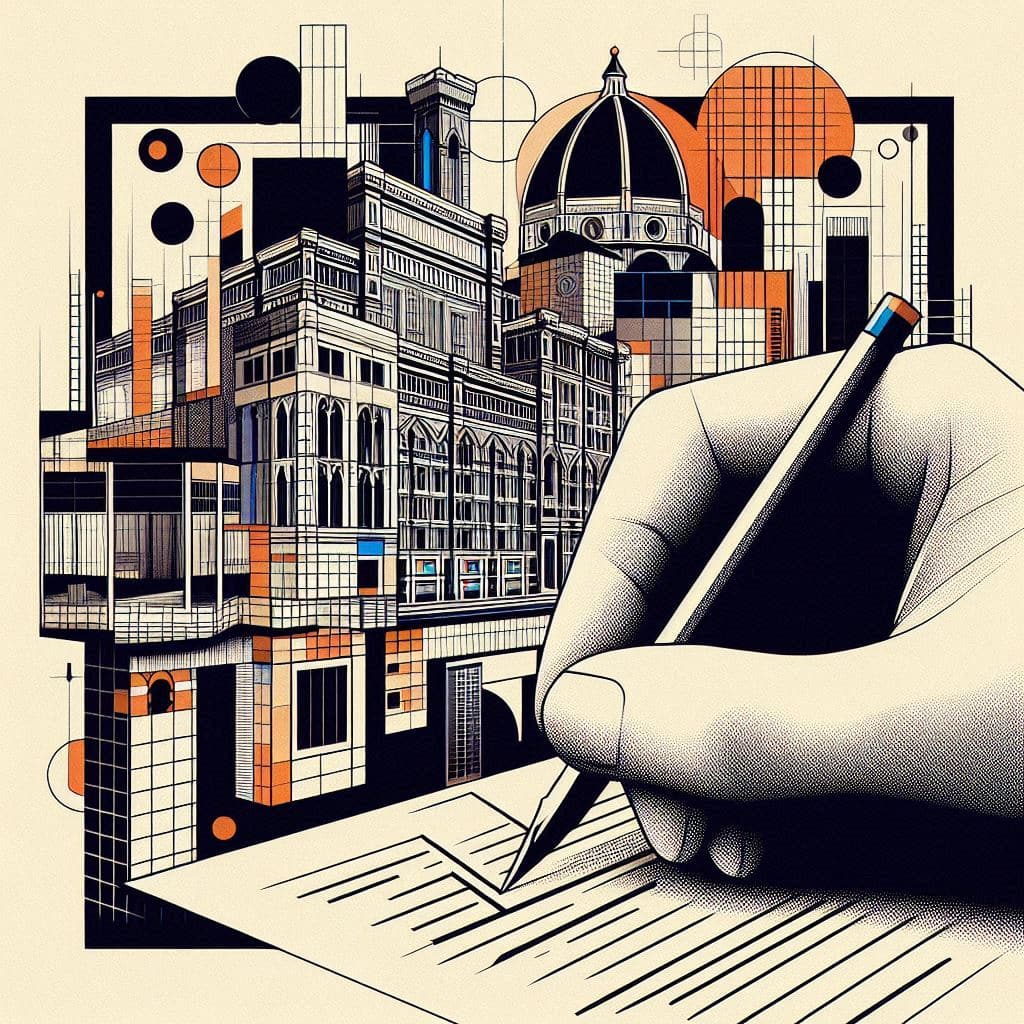EPISODIO 2: FIRENZE NON SI EMOZIONA
Come anticipato nel primo episodio di questa inchiesta, la Giani Tower sembra essere stata temporaneamente messa in stand-by, con le quattro frecce e lo sguardo rivolto al post-elezioni regionali. Si tratta probabilmente di una scelta dettata dal realismo politico, per chiudere momentaneamente il sipario su un progetto che non ha raccolto grandi consensi né tra la gente né nei palazzi. Del resto, non sono pochi gli elementi che ci permettono di comprendere perché l’operazione Terza Torre non abbia suscitato l’entusiasmo sperato
Cominciamo con le motivazioni che hanno portato alla realizzazione di questo concorso. L’obiettivo dichiarato da Giani nel 2022 era quello “di razionalizzare e rendere più efficienti le sedi della Regione Toscana”, risparmiando oltre un milione di euro l’anno che la Regione spende attualmente in affitti. Se la logica è quella di concentrare in un’unica sede gli uffici regionali sparsi sul territorio, riducendo i costi legati agli affitti delle strutture decentrate, è necessario però interrogarsi sulla reale capacità di un’opera dal costo stimato di circa 60 milioni di euro di generare “notevoli risparmi e contenimento dei costi”, sia nel breve che nel lungo periodo.
Va poi sottolineato il costo non indifferente dell’intero iter progettuale. Il montepremi complessivo è stato di €579.275,04, con €405.492,53 destinati al primo classificato e €34.756,50 ai successivi dal secondo al sesto posto. Le spese totali del concorso, inclusi i livelli di progettazione successiva e direzione dei lavori, ammonta a € 4.343.973,82. Se, come sembra prospettarsi ora, il progetto dovesse essere ridimensionato o cancellato, non sarebbe facile giustificare questa spesa di fronte ai contribuenti di una Regione la cui sanità è in sofferenza, o a quei cittadini della Piana che ancora aspettano ristori per i danni causati dalle esondazioni che hanno colpito le loro abitazioni o attività. E se ipoteticamente, come sottolinea Novoli Bene Comune, il Comune non desse l’autorizzazione a costruire? Tutti gli atti posti in essere e soprattutto le spese relative (concorso, saggi terreno, etc.) non sarebbero passibili di un danno erariale?
Un altro dato che non passa inosservato è la scarsa partecipazione al concorso. Solo sette studi di architettura hanno presentato una proposta, e tra questi non figurava alcun partecipante straniero, nonostante quello della Terza Torre fosse ufficialmente un concorso internazionale. Un’assenza che fa riflettere, specie se si considera la caratura simbolica e urbanistica di un intervento del genere in una città globalmente riconosciuta come Firenze. Già nel maggio 2023, Il Giornale dell’Architettura sottolineava come la composizione della commissione giudicatrice apparisse “un po’ troppo locale per un concorso internazionale”. Una sensazione che sembra confermata dal fatto che tutti e cinque i gruppi selezionati per la seconda fase fossero italiani, con il progetto vincitore firmato in particolare da uno studio fiorentino.
Da qui nasce una ulteriore considerazione, non meno importante: come mai un concorso di progettazione in una città d’arte riconosciuta a livello mondiale come Firenze possa risultare così poco attraente per studi internazionali e nazionali. Questo solleva interrogativi non solo sull’appeal del singolo bando, ma anche sul clima culturale, amministrativo e operativo che lo circonda. Potrebbe esserci la percezione che a Firenze molte opere pubbliche, pur annunciate con grande entusiasmo e lanciate tramite concorsi ambiziosi, finiscano per arenarsi nel nulla? Forse la bruciante esperienza dell’infinito iter della Loggia di Isozaki, vincitore di un concorso internazionale nel 1998, poi bocciata dal Consiglio Superiore dei Beni Culturali dopo ben 25 anni, si fa ancora sentire? La lentezza dei procedimenti, l’inefficienza decisionale, le modifiche normative continue e i ricorsi legali sono un incubo anche per i professionisti esteri. Non è irragionevole immaginare che studi internazionali, pur interessati a operare in Italia, decidano di rinunciare a priori quando valutano il dispendio di energie e risorse richieste per partecipare a concorsi che potrebbero non avere alcun seguito pratico. A ciò si aggiunge un altro fattore meno visibile, ma altrettanto rilevante: la difficoltà di interagire con una cultura amministrativa, quella toscana e fiorentina, che nel corso degli anni si è rivelatata troppo autoreferenziale, poco incline al dialogo internazionale e al riconoscimento del valore dell’innovazione progettuale, come evidenziato dalla ben limitata diffusione di opere contemporanee firmate da studi esteri sul territorio.
Eppure non dovrebbe essere così. Come nessun’altra città in Italia, Milano si è resa un formidabile attrattore per investitori, progettisti e designers di tutto il mondo, grazie all’aver messo in piedi una serie di concorsi di rilevanza internazionale, organizzati in collaborazione con altre realtà culturali e con il supporto di soggetti pubblici e privati; eventi come il Salone del Mobile e il Fuorisalone hanno trasformato Milano in una vetrina globale per l’innovazione nel design e nell’architettura, attirando ogni anno migliaia di professionisti e appassionati da tutto il mondo, e contribuendo a consolidare la città come un centro di eccellenza nel settore. E i milanesi hanno risposto negli anni con un entusiasmo e un orgoglio sempre maggiori, ammirando la continua evoluzione della qualità architettonica che, di concorso in concorso, lascia il proprio marchio nella loro città. I concorsi servono ad aprire dibattiti, e a creare entusiasmo e partecipazione, e a far crescere e maturare la cultura architettonica e il senso civico e di appartenenza dei cittadini.
E proprio a questo proposito verrebbe da chiedersi se la realizzazione di un edificio a vocazione civica e rappresentativa, e realizzato a spese dei contribuenti toscani, non avesse dovuto imporre, in sede di definizione dei criteri concorsuali, una serie di parametri di urbanizzazione specifici per restituire maggiori benefici alla collettività, in un quartiere che ancora non ha ricucito le ferite della speculazione edilizia degli anni ’50, ’60 e ’70. Tra le ipotesi progettuali si sarebbero potute contemplare, ad esempio, una ricucitura del tessuto urbano, l’integrazione di opere e servizi essenziali e carenti nell’area, l’introduzione di aree a verde completamente aperte sul quartiere, o la realizzazione di una piazza come fulcro di un nuovo spazio pubblico.
Ma come vedremo, la questione della Terza Torre va ben oltre i numeri e le dinamiche concorsuali fin qui esplorate. Per spiegare la tiepida ricezione che il progetto ha suscitato, è doveroso anche considerare la storica refrattarietà dei fiorentini verso qualsiasi novità, soprattutto quando si tratta di interventi architettonici che sfidano la tradizione estetica e culturale della città – persino quando si parla di interventi in un quartiere devastato da abomini urbanistici e speculazioni selvagge come Novoli. Ed è proprio nel non aver tenuto conto di questa inevitabile resistenza che emerge, forse, l’errore cruciale alla base dell’operazione Terza Torre: l’imposizione dall’alto di una visione politica e amministrativa autoreferenziale, chiusa verso il mondo esterno, incapace di promuovere un reale canale di dialogo civico col territorio che governa. Nel prossimo episodio, proveremo a guardare più a fondo dentro questa filosofia del potere, per capire da dove nascono certe scelte progettuali, e in che modo esse riflettono una precisa idea di città, sempre più distante dai bisogni reali dei cittadini.
Ma il vero cuore della riflessione sarà rivolto a ciò che rischiamo di perdere. Perché ogni grande progetto urbanistico implica delle scelte, delle rinunce, e delle occasioni da cogliere. Nel caso della Terza Torre, l’opportunità più significativa potrebbe essere proprio quella di allargare lo sguardo e ripensare l’intervento in una prospettiva più ampia, trasformandolo in una vera occasione di rigenerazione urbana per Novoli e la città. Un intervento capace di ristabilire un equilibrio oggi fragile tra decisioni calate dall’alto e partecipazione dal basso, tra spazi pubblici e privati, tra ambiente costruito e natura.
Immagine: © Ipostudio architetti srl
Leggi anche gli altri episodi:
Focus LFCV | La Terza Torre, Via di Novoli e la rigenerazione che vorrei (Episodio 1)
Focus LFCV | La Terza Torre, Via di Novoli e la rigenerazione che vorrei (Episodio 2)
Focus LFCV | La Terza Torre, Via di Novoli e la rigenerazione che vorrei (Episodio 3)
Focus LFCV | La Terza Torre, Via di Novoli e la rigenerazione che vorrei (Episodio 4)