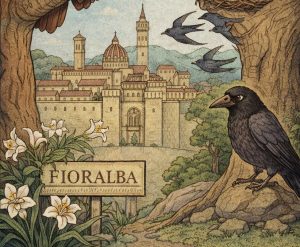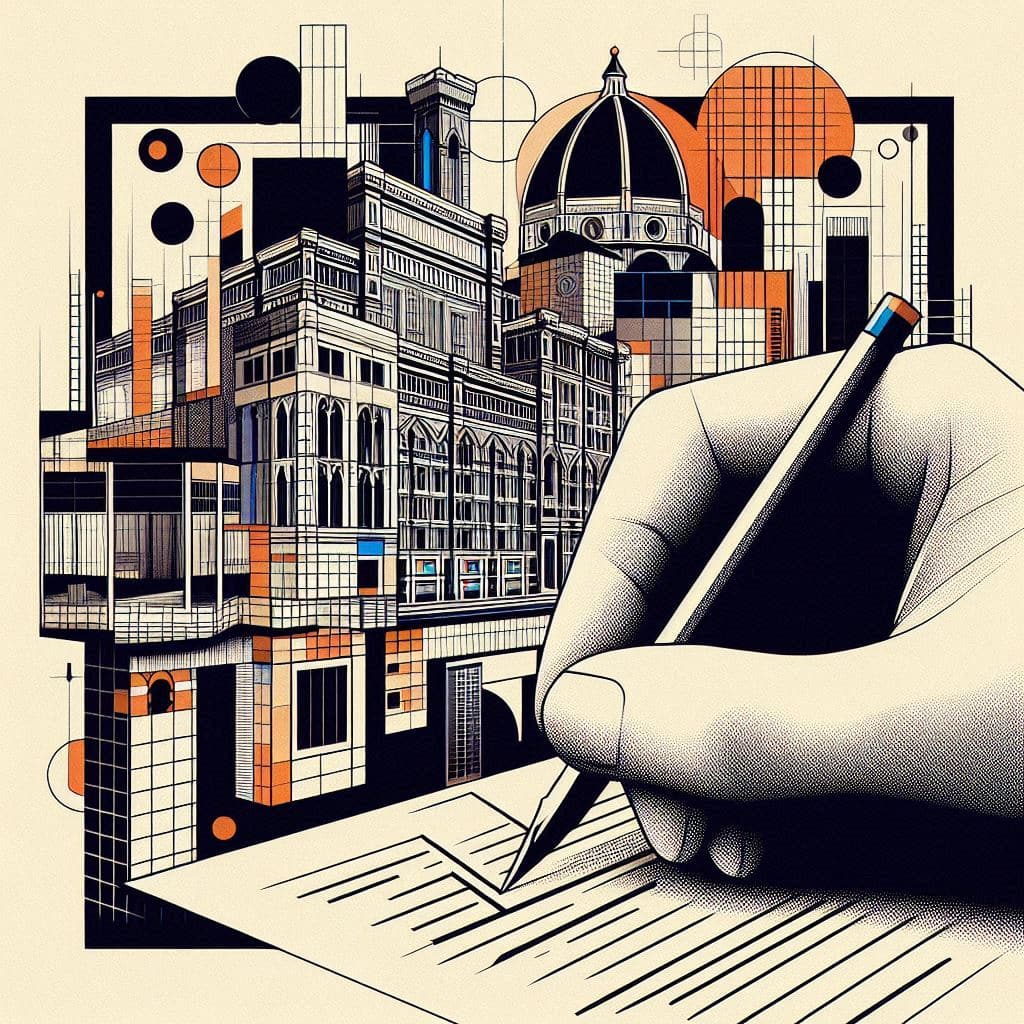di Michele Sanfilippo
Quando un politico è messo alle strette e non sa cosa dire, in modo infantile, scarica la responsabilità sull’Europa: “Lo ha detto l’Europa…”. Sono convinto che l’Unione Europea debba ritrovare se stessa. Ha perso la propria identità, in un minestrone di culture giuridiche e costituzionali fra loro non conciliabili; alle cosiddette costituzioni di terza generazione, quelle per intenderci sociali, ovvero che elencano una serie di diritti sociali, si sono aggiunte quelle fortemente liberiste, scopiazzanti gli Stati Uniti, dei paesi dell’ex Cortina di ferro. Non a caso ci sono lettoni alla Valdis Dombrovskis che ci bacchettano ed impartiscono lezioni, con una arroganza di modi e di sostanza, che neppure i rigorosi tedeschi, storicamente atterriti dalla iperinflazione, avrebbero mai osato. Non è un caso che la prussiana Angela Merkel, inventandosi (appoggiata al presidente di una nota società di consulenza statunitense) la nuova economia sociale e di mercato, abbia trasformato in chiave mercantilistica la dottrina Ordoliberista. L’Europa era diventata solo liberoscambista e così la sua giurisprudenza, altezzosa ed incurante degli ordinamenti originari (quelli dei singoli Stati). Ma, seguendo, invece, i trattati d’origine, che permangono incastonati fra le norme fondamentali dell’ordinamento europeo, restano le vestigia di un costituzionalismo sociale che ci permette di affermare con forza che “L’Europa è sociale o non è”.
Un ulteriore elemento identificativo dell’Unione Europea e del suo costituzionalismo, è venuto ad aggiungersi alla socialità: l’attenzione all’ambiente. L’Europa è green! Questo elemento, specie con la presidenza Trump che ha acuito le divergenze, costituisce un profilo identificativo, giacché l’Europa si differenzia dalle altre posizioni delle varie regioni del globo.
Come è noto, l’amministrazione Trump è del tutto contraria al modello ambientale europeo, in particolare al Green Deal, ESG. È uscita dagli accordi di Parigi del 2015, l’8 gennaio 2025, Trump ha firmato l’Executive Order 14162, ritirando formalmente gli Stati Uniti dall’Accordo di Parigi, ha effettuato un rollback (inversione di rotta) delle politiche climatiche, in particolare sui gas serra e l’abrogazione, con misure di deregolamentazione e tagli ai sussidi per la mobilità elettrica ed efficienza energetica e le rinnovabili. Tutto ciò si lega ad una ottica di avvantaggiarsi di un vantaggio comparato delle fonti fossili e gas degli Stati Uniti, non badando per il sottile nelle modalità estrattive (il fracking che è l’abbreviazione di hydraulic fracturing, tecnica per estrarre gas naturale e petrolio da formazioni rocciose profonde, iniettando acqua ad alta pressione mescolata con sabbia e sostanze chimiche, in modo da fratturare la roccia e rilasciare gli idrocarburi) ad alto impatto ambientale. Da qui il Supporto esplicito a fonti fossili e gas USA e le politiche e minacce, odierne, in punto di tariffe e dazi, nonché la bocciatura di tutte le politiche ESG (ad esempio con la Protect USA Act che vieta agli Stati statunitensi di conformarsi ai criteri ESG imposti dall’UE) e l’indicazione di una profonda revisione delle politiche mondiali in tama di emissioni da metano e delle norme in materia di agricoltura sostenibile. Pertanto fra Europa e Modello USA, caratterizzato da: energia a basso costo, crescita economica tramite energia fossile, autonomia energetica, deregulation, scarso impegno nel contrasto al cambiamento climatico non può che esservi uno scontro sistemico, specie dopo le accelerazioni trumpiane. La posizione di Trump non collima con quella dei democratici, né pienamente con quella repubblicana tradizionale, costituendone una estremizzazione.
L’Europa, in realtà, in questi ultimo decennio ha ricercato un potenziale punto di equilibrio fra visione ed impostazione (latamente) socialdemocratica e l’ottica più incentrata sul mercato, specie nel biennio 2017–2019 nel quale Mariana Mazzucato ha ricoperto il ruolo di consigliera speciale per il Commissario europeo alla Ricerca, Scienza e Innovazione, Carlos Moedas. Essa ha elaborato il rapporto Mission-Oriented Research and Innovation in the European Union, che ha rivoluzionato il paradigma delle politiche di ricerca europee introducendo le missioni, strumento chiave per il programma Horizon Europe. Il contenuto del suo lavoro è stato fondamentale per la definizione del programma Horizon Europe, ponendo le “missioni” come criteri di politiche innovative, trasversali e orientate a problemi concreti quali clima, salute, ambiente e città intelligenti. Ha definito una nuova metodologia di mission-oriented policy, basata su obiettivi ambiziosi, misurabili e con scadenze precise. Le sue raccomandazioni hanno incluso la partecipazione di cittadini e attori diversi, e un nuovo approccio alla governance delle missioni per evitare barriere alla partecipazione. L’impatto istituzionale è stato concreto: il Parlamento Europeo ha votato e approvato la sua proposta mission oriented dentro Horizon Europe, rendendola un vero e proprio strumento legislativo dell’Unione.
Il metodo PNR costituisce una applicazione pedissequa di detto modello.
A tutto ciò si devono aggiungere, sul piano privato i criteri ESG (Environmental, Social, Governance), detta in gergo sistema ESG che pur costituendo una realtà distinta converge in punto di sostenibilità e l’innovazione con il modello europeo. Infatti, il programma quadro dell’Unione Europea per la ricerca e l’innovazione, attivo dal 2021 al 2027, con un budget di oltre 95 miliardi di euro. Presenta l’obiettivo: finanziare progetti che affrontino sfide globali relative al clima, l’ambiente, la salute, l’energia pulita ed i trasporti sostenibili, la digitalizzazione e inclusione sociale, mentre il Sistema ESG, con i suoi parametri, sono utilizzati da imprese e investitori per valutare la sostenibilità ambientale (E), l’impatto sociale (S) e la buona governance (G) di un’organizzazione.
Questi modelli, in realtà nascono dalla cosiddetta Agenda 21 di Rio de Janeiro del 1992 che a seguito del Rapporto Brundtland del 1987 definisce i concetti di sostenibilità, dove il sistema economico, finanziario e produttivo deve essere in grado di garantire un “Futuro comune” (da qui il titolo del rapporto Our Common Future, redatto dalla Commissione Mondiale sull’Ambiente e lo Sviluppo – WCED – e presieduta da: Gro Harlem Brundtland – all’epoca primo ministro della Norvegia) e con ciò inserisce nel concetto di sviluppo anche la dimensione sociale.
Il tema diventerebbe molto complesso, se collegassimo il modello europeo alle nuove articolazioni e criteri dei bilanci locali e di quello nazionale. Giova ricordare che, tendenzialmente, i bilanci locali sono strutturati secondo modalità “flusso” o per cassa, mentre, quello nazionale è per competenza, anche se detta strutturazione a maggior valenza politica si suddivide ed articola (ora) per missione. Questa caratterizzazione per Cassa o per Flusso, consente di monitorare meglio le politiche adottate, purché articolate per Missione (il risultato finale a cui si tende), suddivise per Obiettivi intermedi ben definiti, che consentono di monitorare lo stato di avanzamento, secondo, appunto, il metodo della Missione Orientata, di cui al modello europeo.
I Sindaci, ma anche le altre amministrazioni locali, ma maggiormente i Sindaci, oggi sono dotati di strumenti potenziali importantissimi, sempre che riescano a comprendere il cambiamento del loro ruolo che è quello di Direttore d’orchestra fra progettazione/missione e coinvolgimento della finanza privata (ESG orientata) e quella pubblica (Mission – Oriented) e fra soggetti pubblici e privati.
Con questo nuovo modello si assiste ad una nuova centralità del ruolo pubblico, quello che potremmo immaginificamente individuare nella Bacchetta del Direttore d’Orchestra che dirige gli orchestrali (tutti i soggetti coinvolti: pubblico, privato, cittadini, associazioni, enti di ricerca, soggetti della ricerca e sviluppo) per il raggiungimento armonico della composizione progettuale (la Missione).
Il problema è: conoscere le note per scrivere bene lo spartito, ossia il programma redatto con i fini chiari – la missione, gli obiettivi da raggiungere (suddivisi per modalità, tempi e costi), l’individuazione degli strumenti e degli orchestrali.
Nel fare ciò, però, l’amministrazione non deve lasciarsi soffocare dalle modalità dei tempi del sistema economico-finanziario, che sono tutti di breve termine, perché diventerebbe subalterna al privato, diventando una copia sbiadita del mercato, ma deve individuare le missioni con un orizzonte più ampio, anche temporalmente.
La tentazione del tutto e subito è tipica del modello della scuolo di Chicago, dove suoi seguaci Tullock e Buchanan, scrissero, negli anni ’60 un saggio, il Calcolo del consenso, dove, per loro, il politico si comporta come le aziende private, perché le seconde puntano all’ottimizzazione del profitto ed il politico all’ottimizzazione dei voti, il risultato elettorale.
La buona politica, individua i problemi all’orizzonte, cerca di prevenirli, attraverso politiche di ampio orizzonte e, con la programmazione, indicherà gli obiettivi di medio termini e potrà essere valutata dagli elettori sulla base delle prospettive e degli obiettivi raggiunti.
Faccio un esempio, sicuramente è retoricamente più appagante parlare di una Firenze per i giovani, politiche di riscontro immediato (e di facile consumo, visto la scarsità di giovani in un paese di vecchi), mentre il problema è dato dal fatto che nel 2050 la per metà la popolazione italiana sarà ultra-ottuagenaria.
Per ora vedo solo una tendenziale privatizzazione del Welfare, mettendo in bocca alla speculazione le fragilità. Le liste di attesa in sanità non sono solo una vergogna, ma violano palesemente il dettame costituzionale e mi auguro che la Procura della Repubblica indaghi e trovi i responsabili, perché ricordo che il diritto penale è posto a presidio dei diritti fondamentali. Parimenti la stessa magistratura contabile deve valutare il mancato “Buon andamento” dell’amministrazione in un servizio essenziale come quello della sanità.
Noi elettori giudichiamo sulla base dei risultati e mi pare che l’attività di Federico Gelli e compagnia sia sotto gli occhi di tutti: le liste di attesa si allungano ed i diritti si affievoliscono.
Mi pare, quello della sanità, per quanto concerne la classe politica, un modello da rivedere e ripensare, in modo serio. Come ci dice l’Europa.
In copertina: copyright Fotocronache Germogli