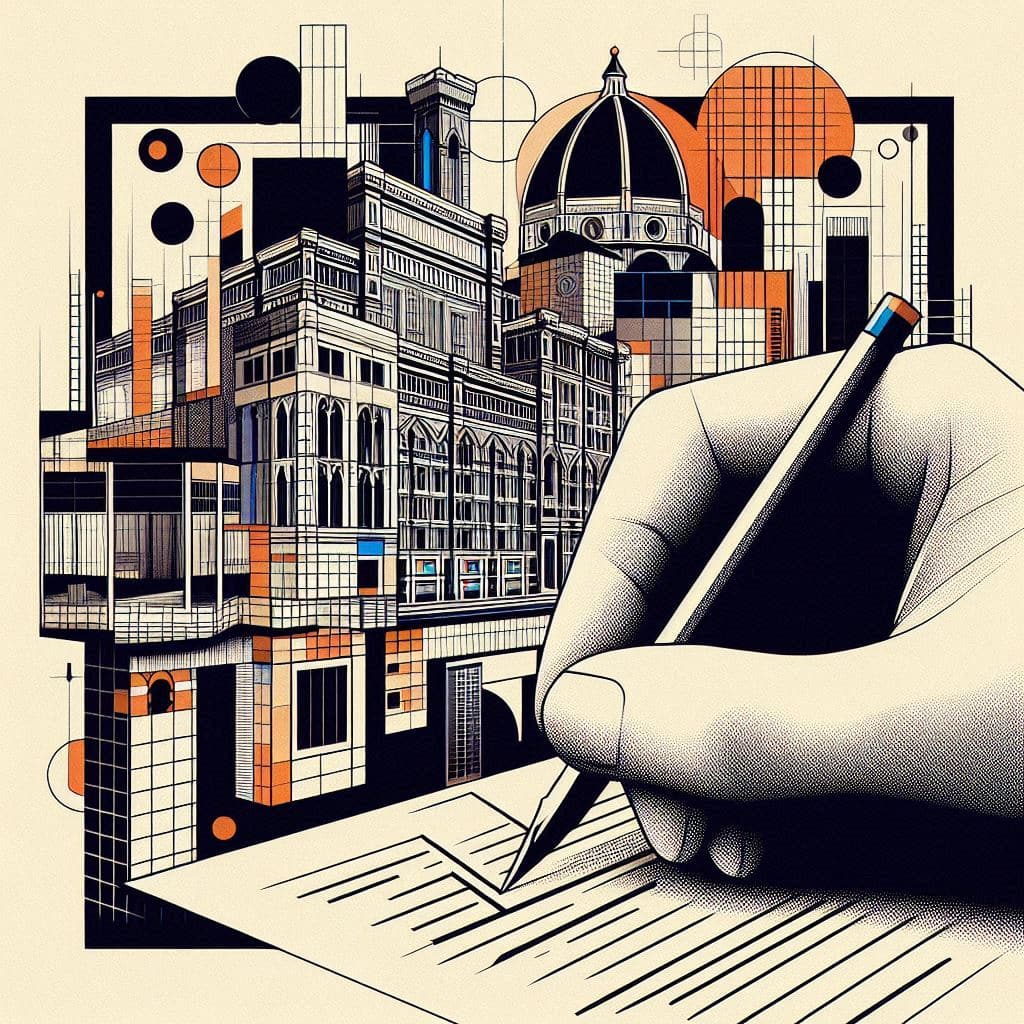Firenze è una città d’acqua. Come dimostrano i danni del maltempo di ieri e gli allagamenti di gennaio. Soffermandosi, per allargare lo sguardo, sui dettagli della straordinaria Pianta della Catena, databile intorno al 1470, si intravedono rivi, alcuni scomparsi e altri deviati. Se ne scorge uno lungo le vecchie Mura “di quà” e “di là d’Arno”, mentre vicino Porta San Gallo si vede un corso, molto probabilmente il Mugnone; poco più in là, nel 1600, fu costruito, vicino l’attuale via La Marmora, il bizzarro torrino del Maglio per fungere da sfiato delle acque provenienti da Pratolino.
Nei secoli, tanti sono stati tombati, continuando a scorrere sotto: il Fosso di San Rocco, di Carraia e del Gelsomino (Q1, zona dell’Erta Canina), il Mensola, l’Affrico, il Gervasio (Q2), il Fosso degli Ortolani vicino l’attuale via Canova (se c’erano e in parte ci sono ancora gli orti vuol dire che c’è acqua).
Ovviamente, la scelta di tombarli nasce dalla necessità di realizzare opere di pubblico interesse, secoli addietro il passaggio delle vecchie Mura (lo stesso Mugnone fu deviato), da quella di ridurre l’impatto delle esondazioni, principalmente durante i lavori per Firenze Capitale, oppure da necessità igienico-sanitarie. Analoghi lavori sono stati fatti, per esempio, a Milano (i navigli erano vie acquose di comunicazione), che presenta oggi analoghi problemi.
La presenza di questa matrice d’acqua sotto imporrebbe una revisione alcuni progetti infrastrutturali; di contro, l’impossibilità di utilizzare il sottosuolo acquoso porta a saturare la superficie, soprattutto in alcune direttrici, come verso la Piana.
La travagliata TAV, nella zona di via Circondaria, poggia sull’area degli ex Macelli, che vi furono costruiti per lavare strumenti in ragione della presenza di acqua. Dalla parte opposta, a Campo di Marte (la zona vicina era attraversata dal già citato Gervasio), in molti ricordano il muro d’acqua fangosa che il genius loci fiorentino ha prontamente ribattezzato una nauseante “creme caramel” che, nel 2023, ha invaso le strade non appena si è iniziato a trivellare. La zona paludosa di San Donato, vicino la Chiesa “polverosa”, fu faticosamente domata grazie ai lavori dei Demidoff, a partire dal tempo di Nicola Demidoff, ambasciatore nientemeno che di Alessandro I, trionfatore – alla fine – su Napoleone; la splendida villa poi è andata distrutta prima dalle bombe poi dai lavori post-bellici. E come non ricordare il “muro d’acqua” che nel 1992 inondò la zona del Terzolle (altro rivo)?
Già i cronisti del Trecento, nel raccontare la drammatica alluvione del 1333, davano la colpa all’urbanizzazione feroce e allo sfruttamento selvaggio del fiume. Erano la “gente nova” e i “subiti guadagni”. Quella ciclica è l’impostazione più solida per capire la storia.
La fine di un’idea di città dei cittadini è iniziata con l’alluvione del 1966 che, da un lato, falcidiò i ceti popolari, portando allo svuotamento di rioni, e, dall’altro, accelerò gli animal spirits speculativi già liberatisi con i lavori del Poggi. Sono dinamiche iniziate allora che proseguono tutt’oggi con l’espulsione di sempre più residenti per il crollo della qualità della vita e per la spirale dei prezzi.
Firenze è il suo fiume – e i suoi affluenti – e con esso dovrebbe recuperare un rapporto che sembra perduto. Firenze è in una crisi profonda. Ne sta cambiando connotati e persone. Masse di fiorentini sono costrette a una diaspora. Masse d’acqua violentemente riconquistano i metri quadri sottratti dal consumo di suolo, chiazze d’acqua restano per giorni nelle zone della Piana o al confine con Firenze, attirando una tipica fauna delle zone umide. È questo il destino di Firenze? Continuare a perdere imprese, botteghe, persone per colpa dell’acqua?