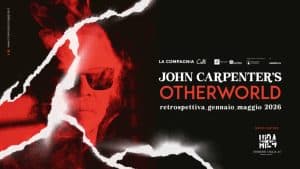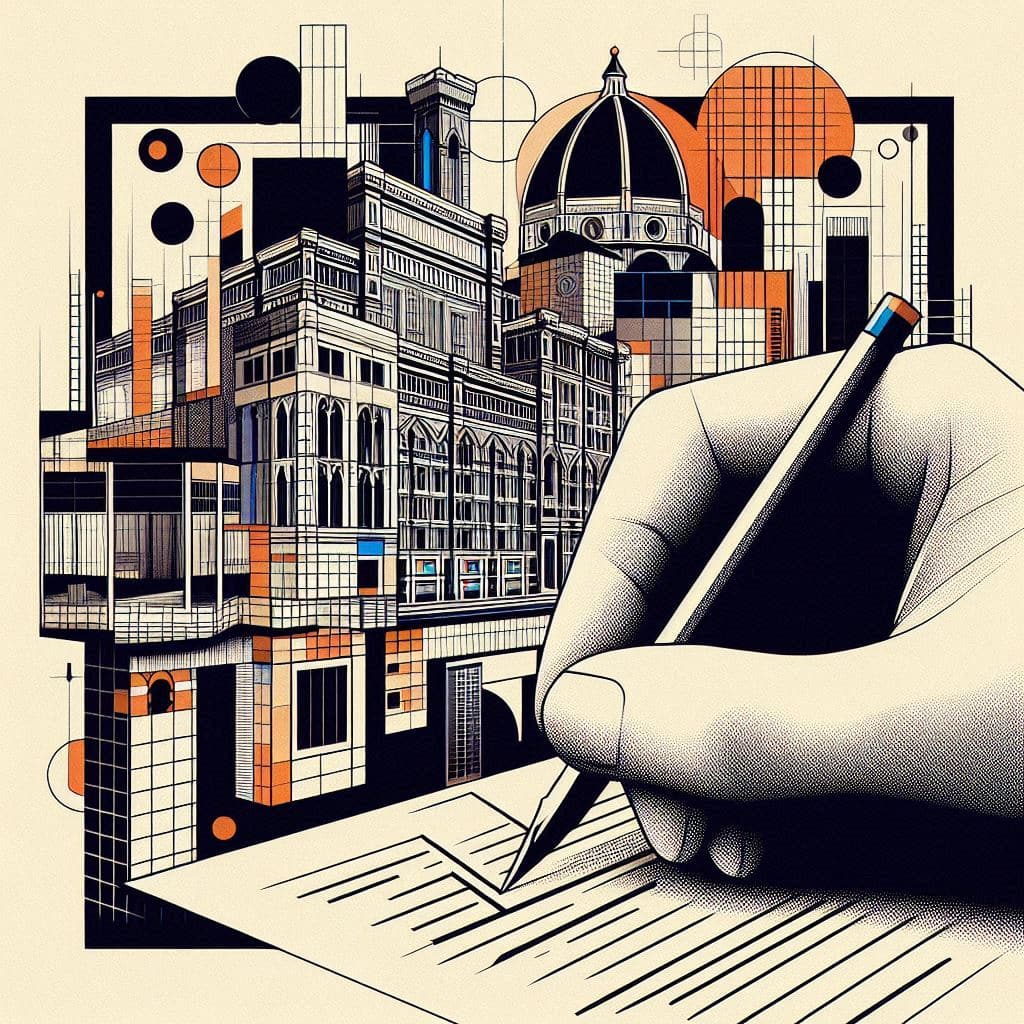Il ‘Secolo dei Lumi’ (e delle riforme), narrato attraverso circa 150 opere allestite nelle sale al piano terreno della Galleria, con capolavori di Goya, Tiepolo, Canaletto, Vigée Le Brun, Liotard, Mengs: molti mai visti, altri invisibili da oltre un decennio a causa dei lavori di ampliamento del percorso espositivo
E non solo: ci sono anche l’imponente dipinto del maestro francese Pierre Subleyras recentemente acquisito, ‘restaurato in diretta’ durante l’esposizione. Poi, il Gabinetto delle Antichità Erotiche ricostruito secondo la moda del tempo e spettacolari vedute dipinte e souvenir di luoghi iconici del Grand Tour
Il direttore Simone Verde: “Raccontiamo un secolo complesso attraverso la sua cultura estetica e allo stesso tempo la trasformazione degli Uffizi nel primo museo moderno d’Europa”
Firenze torna a raccontare il suo Settecento con una mostra che affonda le radici nella straordinaria – e spesso inaccessibile – collezione degli Uffizi. “Firenze e l’Europa. Arti del Settecento agli Uffizi”, curata da Simone Verde e Alessandra Griffo, è un’occasione preziosa per incontrare circa 150 opere che, nella maggior parte dei casi, vivono lontano dagli occhi del pubblico, custodite nei depositi del museo. Un patrimonio che, se esposto in maniera sistematica e curata, non si limita a stupire: offre una lettura raffinata di un secolo di passaggio, tra gli ultimi fasti medicei e la nuova stagione lorenese.
Il dibattito sulle “opere nei depositi” è spesso circondato da una retorica eccessiva. L’idea che ogni magazzino museale custodisca innumerevoli capolavori “dimenticati” pronti a incantare folle di turisti è una semplificazione. Solo istituzioni di portata eccezionale, come gli Uffizi, possiedono un patrimonio tale da richiedere una rotazione espositiva continua. La selezione delle opere non è mai casuale: richiede competenza, contesto e coerenza con il percorso del museo.
In questa mostra, il focus è sul Settecento, epoca in cui la raccolta medicea, ormai prossima alla transizione verso i Lorena, assume un carattere più pubblico grazie ad Anna Maria Luisa de’ Medici, ultima erede della dinastia, e poi a Pietro Leopoldo di Lorena. È un secolo di viaggi, contaminazioni e nuovi linguaggi artistici, dove la raffinatezza del tardo barocco convive con il gusto per l’esotico, la passione per le scuole nazionali e il fascino di soggetti privati e intimi.
Il percorso espositivo è suddiviso in sezioni tematiche che raccontano queste suggestioni: dal turismo formativo del Grand Tour al nascente gusto romantico per la natura sublime, dall’esotismo extraeuropeo fino alla sensualità velata da “camerino segreto”.
Tra i capolavori, spicca La Pulce (circa 1715) di Giuseppe Maria Crespi: un momento di intimità domestica di matrice caravaggesca, trasformato in scena di genere con il gusto e la curiosità voyeuristica delle élite. Accanto a questa, il raffinato Autoritratto di Elisabeth Vigée-Le Brun, artista che trovò rifugio in Italia dopo la fuga dalla Francia rivoluzionaria, qui ritratta con la grazia aristocratica che la legò a Maria Antonietta. Il modello di questa femminilità elegante si ritrova nella figura di Angelica Kauffmann, presente in mostra con il Ritratto di Fortunata Sulgher Fantastici (1792), dove bellezza e letteratura si intrecciano in un ideale estetico quasi “corretto” da un lieve abbellimento pittorico.
L’apertura verso il mondo extraeuropeo è rappresentata dal sorprendente Ritratto dell’imperatore cinese Kangxi di Giovanni Gherardini, realizzato alla corte di Pechino nei primi anni del secolo: un’opera che, nell’equilibrio tra Oriente e Occidente, recupera suggestioni del primo Rinascimento toscano, anticipando atmosfere del Novecento. Allo stesso spirito di apertura appartiene il Ritratto di Maria Adelaide di Francia in abito turco (1753) di Jean-Étienne Liotard, che unisce l’orientalismo di moda a un rigore formale ancora accademico.
Il Settecento fiorentino e internazionale si riflette anche nei ritratti più intimi, come quello di Giovanni de’ Servi, meccanico (1773) di Johann Zoffany, che con sottile ironia gioca tra simboli e gesti allusivi. Più convenzionali, invece, alcune opere di maestri noti: il Matrimonio mistico di Santa Caterina di Pierre Subleyras, elegante ma meno incisivo delle sue composizioni licenziose, o il Rinaldo e Ubaldo attribuito a Giambattista Tiepolo, di qualità non eccelsa rispetto ai vertici dell’artista.
La mostra, in programma fino al 28 novembre, non è solo un’esposizione: è un invito a guardare oltre l’idea di “capolavoro nascosto” e a comprendere la logica curatoriale che guida un museo come gli Uffizi. Qui, la rotazione non è un riempitivo, ma un’opportunità per rileggere interi periodi della storia dell’arte con occhi nuovi.