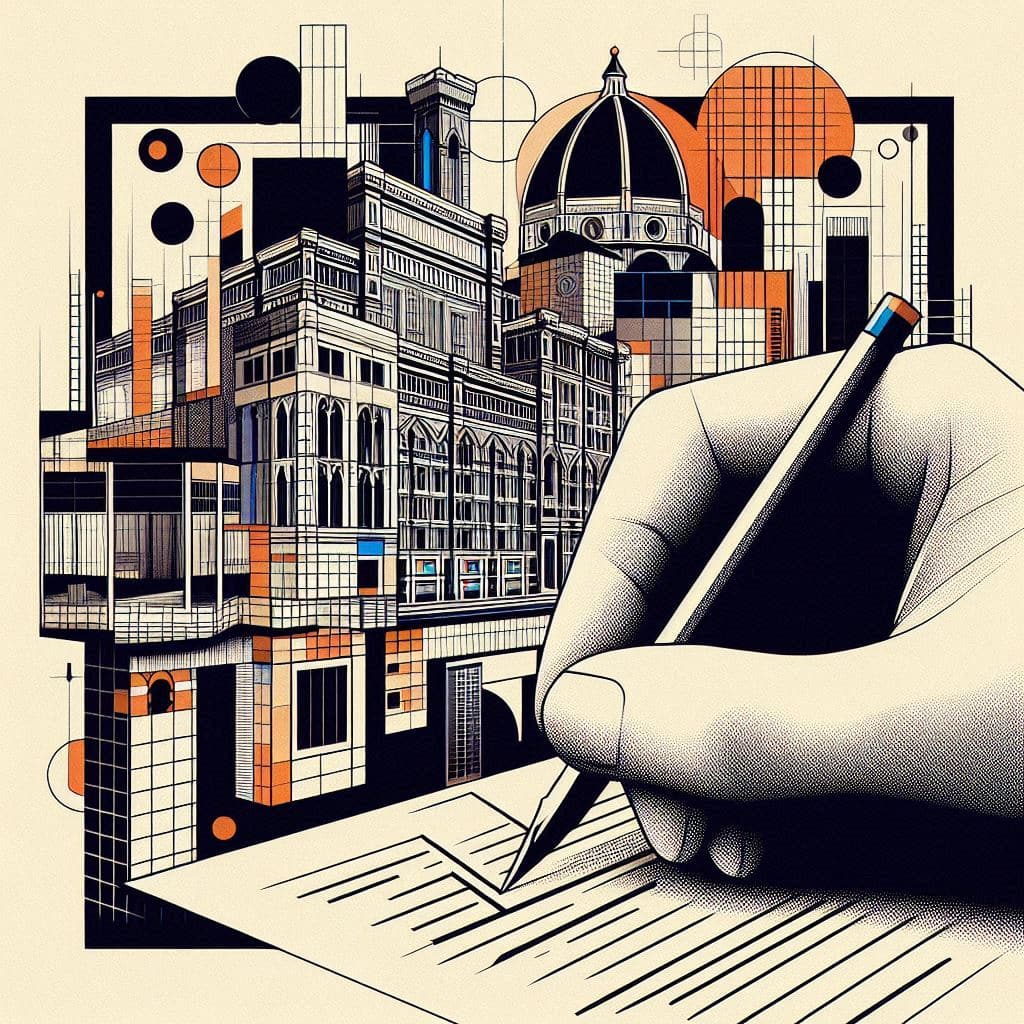Un’altra storia è ancora possibile. La racconteremo da qui.
Essere “di Firenze” ha perso il suo valore. Firenze non ha più una sua banca. Certo, anche il fiorino quest’oggi soffrirebbe l’inflazione e le filiali medicee non terrebbero il passo di una turbo-finanza sempre più astratta, dis-umana e feroce; tuttavia, la città delle lettere di cambio, incubatrice di un’accumulazione primigenia della ricchezza, cioè il capitalismo, cioè la modernità, non ha più un suo cuore finanziario autonomo, capace di pompare linfa nel suo sistema produttivo, espandendosi altrove, a Bruges e a Lione, ad Amsterdam e ad Amburgo. E portando un po’ del giglio “fuori le mura”.
Parlano sempre meno fiorentino le innovazioni e le scoperte scientifiche, l’università si è ripiegata su sé stessa, la ricerca è spezzettata, gli istituti invecchiano. Si è persa la capacità di generare una cultura viva, anche in una contrapposizione violenta – e necessaria – rispetto alle glorie di un passato con il quale non solo il turista medio, il madido ciabattone sedotto da gingilli fosforescenti e bisteccone mal-scongelate, ma anche il medio fiorentino furbetto e con un po’ di puzzetta sotto il naso non riesce a stabilire un contatto, perse – come sono – le chiavi interpretative di questa realtà, codici e linguaggi comuni. Un passato lontano, indefinito e, proprio per questo, un presente miserrimo.
Firenze, la città che ha liberato gli ebrei dal ghetto e che ha accolto anglicani, luterani e ortodossi, ha perso la sua capacità di essere un terreno per un dialogo tra le religioni, frutto del mutuo riconoscimento della centralità dell’uomo. La questione della moschea grida vendetta e mette in discussione la radice stessa di una libertà non solo sulla carta. Il trionfo della radicalità nel mondo, del Male, tanto “misterioso” ma tangibile nel nostro tempo, nasce della fine di quegli spazi reali e possibili per un confronto, duro, serrato ma necessario. Firenze avrebbe dovuto assolvere alla sua missione.
Anche il dialetto, il fiorentino, non se la passa meglio, degradato a mera macchietta comica quando, invece, è stato, prima di tutto, una lingua viva di una comunità pensante, capace, da un lato, di esprimere la varietà delle situazioni umane e, dall’altro, di custodire – per secoli – un’idea di Italia, quando l’Italia non c’era.
Persa com’è, la città perde i suoi cittadini. Vanno via e non tornano più. Incalzati come sono dalla spirale dei prezzi fuggono verso altri lidi e la città, matrigna e non madre, erige un muro – verde – affinché non tornino più.
Scappano e non rimpiangono questa Firenze che i fiorentini non li vuole. Scappano e sono ben felici di lasciarsi alle spalle rumori di cantieri idioti, risposte scorbutiche di impiegati comunali, transenne senza tempo, metri quadri d’oro, progetti stravecchi, mercati rifatti in ferraglia, infestazioni di pali.
Chi resta, chi resta e ancora passa per il centro, si aggrappa alle rovine di quel labirinto di bellezza che è stato una città viva, con uomini diversi ma, come noi, geniali e normalissimi, poveri e straccioni come i poveri della Cappella Brancacci oppure opulenti e ricchissimi come le famiglie che perpetuano la dominazione, donne e uomini nostri maggiori, sedotti dalle passioni e intenti agli affari del mondo terribile e vasto, ma capaci, a differenza di noi fiorentini di oggi, di esprimere un valore. Qualcosa che resta.
È difficile credere che una città e una cittadinanza – le pietre pietre sono senza le persone – che sono stati in grado di esprimere così tanto valore – le cattedrali che puntano al cielo, le forme geometriche che racchiudono l’universo, cioè Dio, gli spedali – abbiano accettato una vita così. È vero, è già successo. Città – e civiltà – un tempo grandi scompaiono. Luoghi che per lungo tempo sono stati un baricentro di una storia sprofondano nella sabbia del tempo. E non riemergono più da una decadenza e tristezza senza fine. Alessandria d’Egitto non è più un centro del Logos, Atene non fa più scuola. Anche se non c’è stato un terremoto, un’alluvione o un’invasione dal mare o dalle steppe, Firenze si è spenta.
Fummo, noi fiorentini, il “quinto elemento” della Terra. Oggi è terra di conquista, Firenze. Preda di investimenti usa e getta, come la carta di panini unti, bisunti e pesantissimi, che tanto vanno di moda. Progetti calati dall’alto e basta.
Come se la collettività, il contesto, il pregresso, la tradizione semplicemente non esistano. E non abbiano valore. Non basta più rendersene conto quando gli student hotel hanno già invaso, con le loro ventole sonore e il ronzio del trolley, interi rioni, con buona pace delle regole e dei divieti tardivi. E non basta più vedere il proprio «particulare» senza un quadro di insieme. Rischia di essere una battaglia di retroguardia, e già perdente, senza una solidità d’analisi.
Il potere ha raggiunto una dimensione verticistica che mal si concilia con tempi e spazi e luoghi delle comunioni democratiche alle quali eravamo abituati. Di queste dinamiche escludenti Firenze, cuore dell’Europa e della civiltà italiana, è uno specchio fedele. Quasi predittivo.
Questo è il nostro destino? Transitare in una città morta dove, un tempo, incredibilmente, c’era una vita che non c’è più se non in tracce sempre più incomprensibili e lontane? Il significato della nostra presenza sulla terra e in questi luoghi, ai quali siamo visceralmente legati, non può essere solo questo. Né possiamo vivere di ricordi e di rimpianti.
A un disegno preciso, a una dominazione che non sembra lasciare spazio a una biodiversità radicale, dobbiamo contrapporre una resistenza civica, rigorosa e totale. È nata La Firenze che vorrei. Cercheremo di essere alti, ma aperti. Lo faremo rispettando le soggettività di tutti come espressioni, tutte meritevoli e belle, di una città senza paragoni.
Firenze è attesa nei prossimi anni, forse mesi, da una trasformazione di cui intravediamo solo aspetti negativi. Ciò ci ha spinto a creare uno spazio che non c’era per tutte le coscienze critiche.
C’è sempre un’alternativa a un’esistenza che non meriterebbe di essere vissuta. Il futuro è ciò che costruiamo oggi.
«Uomini siate e non pecore matte»